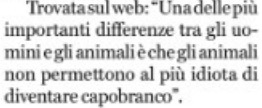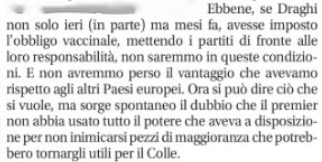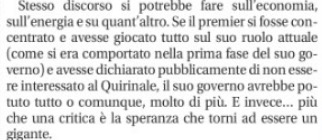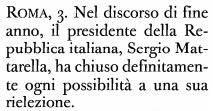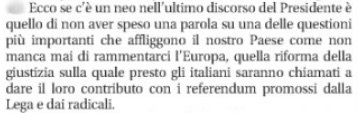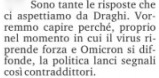
A Mario Draghi, costretto dalle polemiche mediatiche e politiche a tenere domani una conferenza stampa sulla vaccinazione obbligatoria per gli ultracinquantenni e sulle altre misure adottate dal Consiglio dei Ministri, il direttore Massimo Giannini ha anticipato nell’editoriale di oggi della Stampa questa domanda: “Perché nel momento in cui il virus riprende forza e Omicron si diffonde la politica emana segnali così contraddittori?”.

Evidentemente Giannini non condivide la rappresentazione dell’ultima riunione di governo fatta dal ministro forzista Renato Brunetta. Che al Corriere della Sera, pur raccontando del collega leghista Massimo Garavaglia arrivato ad avviarsi all’uscita per protesta contro ciò che stava per essere deciso, ha detto che “il governo è il luogo della calma, dei toni bassi, delle approvazioni unanimi. Da febbraio a oggi su 109 provvedimenti – ha spiegato- è successo solo due volte che la Lega si sia astenuta. Dove sono le liti e le spaccature?”.
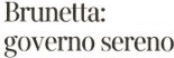
Il governo insomma avrebbe tutto il diritto di essere “sereno”, ha titolato il Corriere in prima pagina l’intervista di Brunetta riesumando un aggettivo infausto per l’uso che ne fece otto anni fa l’allora segretario del Pd Matteo Renzi parlando di Enrico Letta, che dopo pochi giorni egli stesso avrebbe detronizzato per sostituirlo a Palazzo Chigi. Da allora la serenità in politica ha finito di avere il significato assegnato dal dizionario della lingua italiana.
Già immaginato e rappresentato dal vignettista Riccardo Mannelli sulla prima pagina del solito Fatto Quotidiano in mutande, con un gioco sin troppo facile di idee e parole fra Draghi e “Braghi”, ben difficilmente il pur franco presidente del Consiglio potrebbe rispondere a Giannini, o a chi nella conferenza stampa dovesse raccoglierne e rilanciarne la domanda, in modo conforme alla realtà. Che sarebbe pressappoco questo: più che dal Covid o dalla sua ultima variante, Omicron. il governo è disturbato, minacciato e quant’altro da una situazione politica intossicata dalla scadenza del Quirinale. E’ insomma il fattore Q, non O come Omicron o C come Covid, a determinare tensioni e confusioni nei partiti che fanno parte della maggioranza, divisi ancor più del solito fra di loro e al loro interno su come affrontare la scadenza istituzionalmente ineludibile del mandato di Sergio Mattarella. E ciò anche per la perdurante indisponibilità del presidente uscente della Repubblica ad essere confermato, come sempre da più parti, fuori dal Parlamento ma ora anche dentro, viene chiesto o auspicato nella ragionevole speranza che l’anno prossimo, al più tardi, esaurito anche il loro mandato, vengano elette le nuove Camere, ridotte peraltro di un terzo dei seggi. Dove anche i numeri, oltre che i sicuramente diversi rapporti di forza fra i partiti, potrebbero fare affrontare meglio, più in linea con gli orientamenti dell’elettorato, il problema della successione a Mattarella, se questi dovesse avvertire la sensibilità di riaprire il problema di una sua successione.

Sarebbe la soluzione più semplice -altro che l”imbalsamazione” dello stesso Mattarella al Quirinale e di Draghi a Palazzo Chigi derisa da Marco Travaglio nell’editoriale del Fatto Quotidiano affiancato alla vignetta sul presidente del Consiglio in mutande. Si preferisce invece una corsa a soluzioni sempre più improbabili o estemporanee, compresa l’ultima appena proposta, fuori dal Parlamento, dall’ex sindaca grillina di Roma Virginia Raggi di un presidente “non politico”. Purché naturalmente non sia Draghi, troppo tecnico e troppo compromesso a Palazzo Chigi per risultare idoneo. Candidiamo allora il buon Massimo Galli, l’ex primario dell’ospedale Sacco di Milano, per solidarietà dopo essere stato contagiato da Omicron pure lui, ormai pensionato ma per fortuna protetto dalle tre dosi di vaccino iniettategli quando era ancora in servizio.