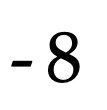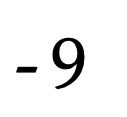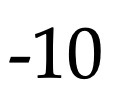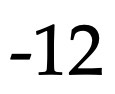Settantasei anni da compiere a settembre, laureato in filosofia ma esperto di economia, non a caso vice ministro appunto dell’Economa nei governi di Matteo Renzi e di Paolo Gentiloni, presidente della Commissione Bilancio del Senato, Enrico -anzi Antonio Enrico- Morando si può considerare il più liberal dei fondatori del Pd, pur provenendo dal Pci e dal suo giornalismo militante. Tanto liberal che il segretario del Pd appena nato, Walter Veltroni, lo scelse come coordinatore, cioè capo, del “governo ombra” di tradizione anglosassone formato anche per dare un segnale inconfondibile, anglosassone appunto, della formazione politica che si proponeva di fare diventare maggioritaria, riscattando la sinistra dai condizionamenti radicali, intesi come estremisti, non ceto come pannelliani, subiti nelle esperienze dell’Ulivo e dell’Unione.
Della sua breve esperienza giornalistica all’Unità Morando ha ricavato e conservato il meglio, direi, di una professione così facilmente esposta ai rischi della prolissità, genericità, approssimazione e presunzione. Lo scrivo anche in senso autocritico, per carità, potendomi essere capitato di sbagliare proprio in quelle direzioni, per quanti sforzi abbia compiuto di non cadere in tentazione. E per quanta buina scuola abbia avuto lavorando per una decina d’anni con Indro Montanelli. Che aveva un carattere leggermente peggiore del mio, che pure lui considerava il peggiore in assoluto, rammaricandosene qualche volta anche con i nostri migliori amici politici comuni: ad esempio, Arnaldo Forlani. Che me lo confidò chiedendomi, sorpreso, che cosa mai avessi fatto per guadagnarmi quel giudizio.
A Morandi credo che spetti l’Oscar della chiarezza e della sintesi nella campagna referendaria della sinistra del sì -che c’è, per fortuna- alla riforma costituzionale della magistratura. In sette righe stampate, non di più, a pagina 26 del Corriere della Sera del 12 marzo dirette all’amico e tuttora compagno di partito Luciano Violanta -ma anche ad altri né comunisti né post-comunisti di analoghe convinzioni o paure sorprendenti come gli eterni democristiani Clemente Mastella e Paolo Cirino Pomicino, in ordine alfabetico- Morando ha smascherato la debolezza, contraddittorietà, inconsistenza della campagna referendaria del no. Che naturalmente, nella sua presuntuosa autosufficienza, si sente la meno politicizzata o più civile.
“I sostenitori del no- ha scritto testualmente Morando- dovrebbero scegliere fra queste due critiche: a) la riforma è volta a subordinare il pm al potere politico; b) la riforma dà troppo potere al pm. Sostenerle entrambe può solo dimostrare che entrambe hanno debole fondamento”. Debole, a dir poco. Un pubblico ministero troppo forte ma lasciatosi sottomettere dalla politica, anziché sottometterla, è un ossimoro. Niente di più.
Ha ragione, questa volta azzeccandoci nel suo italiano sempre ruspante, l’ex pm storico Antonio Di Pietro a dire, sul fronte del sì referendario che ha smutandato il no quasi come Morando sul fronte della sinistra, che un pubblico ministero, o semplicemente un magistrato serio può essere bloccato o da un altro della stessa qualità o da una bomba. Il tempo non è trascorso inutilmente per “Tonino”, diversamente dagli ex colleghi rimasti arroccati nelle loro postazioni e nelle loro cattive abitudini.
Pubblicato su Libero