Non vorrei che Alessandro Di Battista, Dibba per gli amici, o il Che Guevara de’ Noantri, come lo sfottono gli antipatizzanti del movimento grillino, si montasse la testa. E con lui se la montasse anche il padre, ex elettore di destra, a sentirsi rimproverare di avere surriscaldato la crisi di governo, con pesanti attacchi al modo in cui l’ha gestita il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come accadde nell’estate del 1964. Quando Pietro Nenni, allora vice presidente del Consiglio, scrisse nei suoi diari di avere sentito “rumori di sciabole”.
Presidente della Repubblica era in quei tempi Antonio Segni, il leader democristiano dei moderati mandato al Quirinale due anni prima per compensare la svolta del centrosinistra gestita dal segretario del partito Aldo Moro. Che nel 1963 riuscì a realizzare il primo governo a partecipazione socialista.
Nell’estate appunto del 1964 Moro fu costretto a dimettersi per la bocciatura parlamentare, a scrutinio segreto, di un pur modesto finanziamento pubblico alla scuola materna privata. Segni esitò a dargli l’incarico per chiudere la crisi con la conferma del centrosinistra. E, preoccupato che il ritorno ad un governo centrista potesse provocare tumulti di piazza, convocò al Quirinale, con tanto di comunicato ufficiale, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Giovanni De Lorenzo. Che gli fornì ampie garanzie di controllo dell’ordine pubblico, di cui però non rimase per niente convinto Mario Scelba quando Segni lo sondò per fare un governo di centro. Lo stesso Scelba lo avrebbe poi raccontato nella sua biografia, spiegando che a non piacergli era stato proprio il nome di De Lorenzo.
In quei giorni si creò, a torto o a ragione, un clima di alta tensione. Lo stesso Moro, oltre a qualche esponente di sinistra, politica e sindacale, dormì per due notti fuori casa. Il ministro socialdemocratico degli Esteri Giuseppe Saragat scambiò le esitazioni di Segni di fronte al reincarico di Moro, parlandone con amici di partito e con lo tesso Moro, per una tentazione di forzare la Costituzione: un po’ come quello che i Di Battista padre e figlio, mettendo in imbarazzo i dirigenti del loro movimento, hanno più o meno dichiarato in questa crisi di fronte alle esitazioni di Mattarella di dare l’incarico al professore Giuseppe Conte, designato alla presidenza del Consiglio insieme da grillini e leghisti.
Gli attacchi dei Di Battista, per quanto il loro livello non sia certo neppure paragonabile a quello di Saragat nel 1964, sono stati tali, e tanto minacciosi, che Mattarella ne è rimasto turbato. Anzi, “arrabbiato”, come ha riferito nella sua corrispondenza dal Quirinale l’informatissimo Marzio Breda sul Corriere della Sera.
E’ circolata addirittura voce che proprio quegli attacchi, per quanto contestati da Luigi Di Maio e poi dal presidente grillino della Camera Roberto Fico con pubblici apprezzamenti dell’operato di Mattarella, abbiano spinto il presidente della Repubblica ad anticipare di 24 ore la convocazione del professore Conte al Quirinale per il conferimento dell’incarico, troncando così anche le polemiche sul suo curriculum.
Bisogna stare attenti a surriscaldare troppo il clima politico durante una crisi di governo, se persino a un uomo dell’esperienza e della caratura di Saragat la situazione sfuggì letteralmente di mano, sino ad un epilogo drammatico. In quella torrida estate di 54 anni fa, ricomposto il centro sinistra col secondo governo Moro, il leader socialdemoratico ebbe un alterco con Segni al Quirinale, presente lo stesso Moro, rimproverandogli così duramente la gestione della crisi da provocargli un ictus. Dal quale il presidente non si sarebbe più ripreso, sino a doversi dimettere dopo qualche mese. E a succedergli, paradossalmente, fu lo stesso Saragat, dopo vari e falliti tentativi di un accordo su un candidato democristiano, come il presidente dimissionario. L’elezione di Saragat avvenne al ventunesimo scrutinio, tra Natale e Capodanno.
Pubblicato su Il Dubbio


 Il capo dello Stato aveva dato l’impressione di volere allungare i tempi della sua riflessione, pur convinto -come ha scritto il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda- che il curriculum del professore Giuseppe Conte, lungo originariamente una decina di pagine, fosse “un po’ gonfiato ma sostanzialmente non falso”. Gonfiato nei “perfezionamenti degli studi” giuridici e linguistici vantati dal docente pugliese dell’Università di Firenze in sedi estere, come quella di New York, nei cui archivi il suo nome non risulta. E ciò per non parlare del giallo di una sua vertenza col fisco, per quanto un’avventura del genere possa capitare a tutti, a dire il vero.
Il capo dello Stato aveva dato l’impressione di volere allungare i tempi della sua riflessione, pur convinto -come ha scritto il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda- che il curriculum del professore Giuseppe Conte, lungo originariamente una decina di pagine, fosse “un po’ gonfiato ma sostanzialmente non falso”. Gonfiato nei “perfezionamenti degli studi” giuridici e linguistici vantati dal docente pugliese dell’Università di Firenze in sedi estere, come quella di New York, nei cui archivi il suo nome non risulta. E ciò per non parlare del giallo di una sua vertenza col fisco, per quanto un’avventura del genere possa capitare a tutti, a dire il vero. Un altro professore finito o sbattuto con Conte sulle prime pagine è Paolo Savona, destinato da Di Maio e Salvini al Ministero dell’Economia, già ministro dell’Industria nel governo di Carlo Azeglio Ciampi nel 1993. Di lui sembra che abbiano allarmato o imbarazzato Sergio Mattarella recenti e pesanti giudizi espressi sull’abitudine dei tedeschi di comandare nell’Unione Europea. Un’abitudine, in verità, difficilmente negabile ma scomoda da condividere forse da parte del presidente della Repubblica per ragioni, diciamo così, diplomatiche. Che potrebbero tuttavia essere chiarite e definite, se Mattarella lo volesse, in qualche contatto.
Un altro professore finito o sbattuto con Conte sulle prime pagine è Paolo Savona, destinato da Di Maio e Salvini al Ministero dell’Economia, già ministro dell’Industria nel governo di Carlo Azeglio Ciampi nel 1993. Di lui sembra che abbiano allarmato o imbarazzato Sergio Mattarella recenti e pesanti giudizi espressi sull’abitudine dei tedeschi di comandare nell’Unione Europea. Un’abitudine, in verità, difficilmente negabile ma scomoda da condividere forse da parte del presidente della Repubblica per ragioni, diciamo così, diplomatiche. Che potrebbero tuttavia essere chiarite e definite, se Mattarella lo volesse, in qualche contatto.
 Una volta incaricato, il Conte del Grillo, come il professore di diritto privato all’Università di Firenze è stato definito ironicamente, ma non troppo, nel titolo copertina del Manifesto, abitualmente felice in queste scelte, diventerà l’unico e titolato interlocutore del presidente della Repubblica per conto del governo. All’interno del quale però gli assai probabili ministri Di Maio e Salvini, come ha argutamente raccontato in una vignetta il bravo Vauro Senesi sul Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, sono destinati ad azzuffarsi “su chi è Re”. E il Conte del Grillo avrà il suo daffare per difendersene, magari ricorrendo all’aiuto proprio di Mattarella, pur così incerto sinora nel conferirgli l’incarico per la sua scarsa caratura politica. Ma anche per l’allarme provocato nelle cancellerie europee e nei mercati dal “contratto” di governo stipulato fra pentastellati e leghisti. Che ha fatto ingrassare in pochi giorni di una cinquantina di chili, o punti, mister Spread.
Una volta incaricato, il Conte del Grillo, come il professore di diritto privato all’Università di Firenze è stato definito ironicamente, ma non troppo, nel titolo copertina del Manifesto, abitualmente felice in queste scelte, diventerà l’unico e titolato interlocutore del presidente della Repubblica per conto del governo. All’interno del quale però gli assai probabili ministri Di Maio e Salvini, come ha argutamente raccontato in una vignetta il bravo Vauro Senesi sul Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, sono destinati ad azzuffarsi “su chi è Re”. E il Conte del Grillo avrà il suo daffare per difendersene, magari ricorrendo all’aiuto proprio di Mattarella, pur così incerto sinora nel conferirgli l’incarico per la sua scarsa caratura politica. Ma anche per l’allarme provocato nelle cancellerie europee e nei mercati dal “contratto” di governo stipulato fra pentastellati e leghisti. Che ha fatto ingrassare in pochi giorni di una cinquantina di chili, o punti, mister Spread. 
 E’ fuori dall’ordinario, diciamo così, anche la pazienza mostrata dal professore caro ai dioscuri del governo legastellato, come ormai dobbiamo abituarci a chiamarlo. Un altro, al posto di Giuseppe Conte, si sarebbe tanto spaventato di fronte allo scetticismo e all’ironia provocati dal suo arrivo sulla scena della crisi da rilasciare la solita dichiarazione di rinuncia preventiva. L’uomo evidentemente ha quanto meno un buon sistema nervoso, oltre alla competenza giuridica che gli ha permesso di partecipare, pur senza lasciare traccia fotografica, alle delegazioni grilline avvicendatesi nella trattativa sul “contratto”, come Di Maio e Salvini preferiscono definire quello che una volta si chiamava “programma” di governo. Dubbi su questo cambio di terminologia sono stati peraltro espressi anche dal presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky, non sospettabile di preconcetti verso i grillini per averne condiviso tante posizioni.
E’ fuori dall’ordinario, diciamo così, anche la pazienza mostrata dal professore caro ai dioscuri del governo legastellato, come ormai dobbiamo abituarci a chiamarlo. Un altro, al posto di Giuseppe Conte, si sarebbe tanto spaventato di fronte allo scetticismo e all’ironia provocati dal suo arrivo sulla scena della crisi da rilasciare la solita dichiarazione di rinuncia preventiva. L’uomo evidentemente ha quanto meno un buon sistema nervoso, oltre alla competenza giuridica che gli ha permesso di partecipare, pur senza lasciare traccia fotografica, alle delegazioni grilline avvicendatesi nella trattativa sul “contratto”, come Di Maio e Salvini preferiscono definire quello che una volta si chiamava “programma” di governo. Dubbi su questo cambio di terminologia sono stati peraltro espressi anche dal presidente emerito della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky, non sospettabile di preconcetti verso i grillini per averne condiviso tante posizioni.
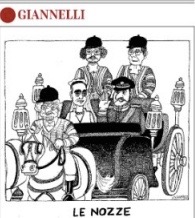 “Questo matrimonio mi agita, ma è un miracolo”, ha detto Beppe Grillo fra il palco e il retropalco di un suo spettacolo a La Spezia. Il comico genovese non parlava delle nozze inglesi tra il principe Harry e Meghan, che ha incollato ai televisori molti più italiani di quanti egli non riuscirà mai a raccogliere in un teatro o in una piazza durante tutta la sua vita, ma delle nozze politiche italiane fra il suo Luigi Di Maio e il segretario leghista Matteo Salvini. Che hanno acceso la fantasia di Giannelli sul Corriere della Sera accoppiandole praticamente in una vignetta dove proprio Grillo è inconfondibilmente in primo piano, sul cavallo della carrozza che trasporta gli sposi.
“Questo matrimonio mi agita, ma è un miracolo”, ha detto Beppe Grillo fra il palco e il retropalco di un suo spettacolo a La Spezia. Il comico genovese non parlava delle nozze inglesi tra il principe Harry e Meghan, che ha incollato ai televisori molti più italiani di quanti egli non riuscirà mai a raccogliere in un teatro o in una piazza durante tutta la sua vita, ma delle nozze politiche italiane fra il suo Luigi Di Maio e il segretario leghista Matteo Salvini. Che hanno acceso la fantasia di Giannelli sul Corriere della Sera accoppiandole praticamente in una vignetta dove proprio Grillo è inconfondibilmente in primo piano, sul cavallo della carrozza che trasporta gli sposi.  Convinto da tempo, e giustamente, che l’europeismo sia il vero e moderno discrimine fra la sinistra e la destra, Scalfari si è quindi rassegnato a coltivare la speranza che il Pd, dopo la riunione interlocutoria dell’assemblea nazionale appena svoltasi sotto la presidenza del “figurino” Matteo Orfini, esca dalla crisi in cui l’avrebbe fatto precipitare anche Renzi col “morbo della semidittatura”, cioè con quella voglia irrefrenabile di “comandare da solo”, e si affidi ad una guida collegiale -par di capire- che lo riconcili in qualche modo con un elettorato quasi dimezzatosi negli ultimi quattro anni.
Convinto da tempo, e giustamente, che l’europeismo sia il vero e moderno discrimine fra la sinistra e la destra, Scalfari si è quindi rassegnato a coltivare la speranza che il Pd, dopo la riunione interlocutoria dell’assemblea nazionale appena svoltasi sotto la presidenza del “figurino” Matteo Orfini, esca dalla crisi in cui l’avrebbe fatto precipitare anche Renzi col “morbo della semidittatura”, cioè con quella voglia irrefrenabile di “comandare da solo”, e si affidi ad una guida collegiale -par di capire- che lo riconcili in qualche modo con un elettorato quasi dimezzatosi negli ultimi quattro anni. 
 Ora a rappresentare la ricerca del presidente del Consiglio ancora in corso fra grillini e leghisti basta e avanza l’arguta vignetta di Altan su Repubblica, dove uno dei due attori parla dell’attesa del nome e cognome della persona da sistemare a Palazzo Chigi e l’altro gli chiede se sia davvero sicuro che occorra anche il cognome, e non solo il nome.
Ora a rappresentare la ricerca del presidente del Consiglio ancora in corso fra grillini e leghisti basta e avanza l’arguta vignetta di Altan su Repubblica, dove uno dei due attori parla dell’attesa del nome e cognome della persona da sistemare a Palazzo Chigi e l’altro gli chiede se sia davvero sicuro che occorra anche il cognome, e non solo il nome. Le distanze tra un Salvini che le vignette del Foglio riprendono ormai in tenuta fascista e un Berlusconi sulla cui testa i capelli non si drizzano solo perché sono incollati sono inversamente proporzionali a quelle fra il Cavaliere e Matteo Renzi. Che hanno appena formulato giudizi e preoccupazioni analoghe, per esempio, sulla deriva giustizialista del contratto di governo già acclamato digitalmente dai grillini e passato al Consiglio federale della Lega senza neppure il ricorso ad una votazione, avendo tutti preferito rimettersi da quelle parti al popolo dei gazebo mobilitato in questo week end. Che per fortuna farà riposare un po’ gli speculatori di borsa, scatenatisi contro i titoli dell’ingente debito pubblico italiano da quando i gestanti del nuovo governo hanno fatto sapere e capire che intendono aumentarne ancora la consistenza per cercare di realizzare i loro generosi propositi, diciamo così, sociali: dal cosiddetto reddito di cittadinanza in su, o in giù, come preferite.
Le distanze tra un Salvini che le vignette del Foglio riprendono ormai in tenuta fascista e un Berlusconi sulla cui testa i capelli non si drizzano solo perché sono incollati sono inversamente proporzionali a quelle fra il Cavaliere e Matteo Renzi. Che hanno appena formulato giudizi e preoccupazioni analoghe, per esempio, sulla deriva giustizialista del contratto di governo già acclamato digitalmente dai grillini e passato al Consiglio federale della Lega senza neppure il ricorso ad una votazione, avendo tutti preferito rimettersi da quelle parti al popolo dei gazebo mobilitato in questo week end. Che per fortuna farà riposare un po’ gli speculatori di borsa, scatenatisi contro i titoli dell’ingente debito pubblico italiano da quando i gestanti del nuovo governo hanno fatto sapere e capire che intendono aumentarne ancora la consistenza per cercare di realizzare i loro generosi propositi, diciamo così, sociali: dal cosiddetto reddito di cittadinanza in su, o in giù, come preferite. 
 Ma la definizione più appropriata, e più in linea anche con quella “del cambiamento” attribuitole dai negoziatori nel titolo del contratto appartiene all’ex guardasigilli e presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick. Che peraltro conosce bene i grillini, frequentandoli a tal punto da essersi guadagnato una consulenza, o qualcosa del genere, dalla sindaca a cinque stelle di Roma Virginia Raggi. Ma anche la sponsorizzazione, per alcune settimane, del fantasioso fondatore del Foglio Giuliano Ferrara come presidente di una compagine ministeriale comprensiva del movimento di Beppe Grillo: una sponsorizzazione che forse gli ha più nuociuto che giovato, vista l’opinione che Giulianone ha dei pentastellati, ben al di là dei “nuovi barbari” intravisti nella redazione del Financial Times.
Ma la definizione più appropriata, e più in linea anche con quella “del cambiamento” attribuitole dai negoziatori nel titolo del contratto appartiene all’ex guardasigilli e presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick. Che peraltro conosce bene i grillini, frequentandoli a tal punto da essersi guadagnato una consulenza, o qualcosa del genere, dalla sindaca a cinque stelle di Roma Virginia Raggi. Ma anche la sponsorizzazione, per alcune settimane, del fantasioso fondatore del Foglio Giuliano Ferrara come presidente di una compagine ministeriale comprensiva del movimento di Beppe Grillo: una sponsorizzazione che forse gli ha più nuociuto che giovato, vista l’opinione che Giulianone ha dei pentastellati, ben al di là dei “nuovi barbari” intravisti nella redazione del Financial Times. Tutto questo scrivo per attenermi agli aspetti istituzionali del governo che sta nascendo, ripeto, ormai più per forza d’inerzia o stanchezza che per convinzione dei gestanti, senza entrare quindi negli aspetti politici, o programmatici, come si diceva una volta. A proposito dei quali voglio essere tanto ottimista da attribuire alla troppo giovane età dei negoziatori o gestanti, e quindi alla loro scarsa conoscenza della storia della nostra Repubblica, la stretta giustizialista che hanno concordato in tema, per esempio, di prescrizione proprio nel trentesimo anniversario della morte di Enzo Tortora: il popolare e arciliberale conduttore televisivo sbattuto in galera da innocente con l’accusa di camorra, sostenuta col solito apporto dei soliti pentiti, e destinato ad uscirne solo per i pochi anni che lo speravano dalla morte per un tumore seguito sicuramente alle sue sofferenze fisiche e psichiche. Ma che ne sanno di Tortora i baldanzosi protagonisti del “cambiamento” 2 punto 18? Niente.
Tutto questo scrivo per attenermi agli aspetti istituzionali del governo che sta nascendo, ripeto, ormai più per forza d’inerzia o stanchezza che per convinzione dei gestanti, senza entrare quindi negli aspetti politici, o programmatici, come si diceva una volta. A proposito dei quali voglio essere tanto ottimista da attribuire alla troppo giovane età dei negoziatori o gestanti, e quindi alla loro scarsa conoscenza della storia della nostra Repubblica, la stretta giustizialista che hanno concordato in tema, per esempio, di prescrizione proprio nel trentesimo anniversario della morte di Enzo Tortora: il popolare e arciliberale conduttore televisivo sbattuto in galera da innocente con l’accusa di camorra, sostenuta col solito apporto dei soliti pentiti, e destinato ad uscirne solo per i pochi anni che lo speravano dalla morte per un tumore seguito sicuramente alle sue sofferenze fisiche e psichiche. Ma che ne sanno di Tortora i baldanzosi protagonisti del “cambiamento” 2 punto 18? Niente.
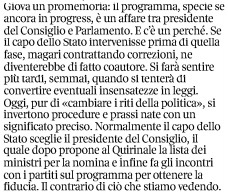 In ogni caso -e arriviamo al monito, appunto, partito dal colle più alto di Roma- il presidente della Repubblica “si farà sentire più tardi”, una volta definiti anche i dettagli del programma o contratto, e magari anche prestatosi alla formazione del nuovo governo cercando di conciliare le proposte di Salvini e di Di Maio con le sue prerogative costituzionali nella nomina del presidente del Consiglio e dei ministri. Si farà sentire, “semmai quando si tenterà -ha scritto il quirinalista del Corriere della Sera- di convertire eventuali insensatezze in leggi”.
In ogni caso -e arriviamo al monito, appunto, partito dal colle più alto di Roma- il presidente della Repubblica “si farà sentire più tardi”, una volta definiti anche i dettagli del programma o contratto, e magari anche prestatosi alla formazione del nuovo governo cercando di conciliare le proposte di Salvini e di Di Maio con le sue prerogative costituzionali nella nomina del presidente del Consiglio e dei ministri. Si farà sentire, “semmai quando si tenterà -ha scritto il quirinalista del Corriere della Sera- di convertire eventuali insensatezze in leggi”.