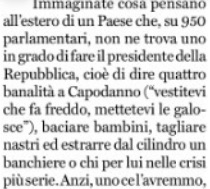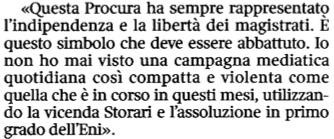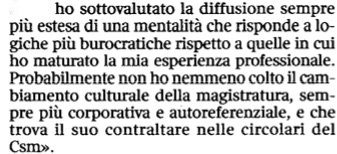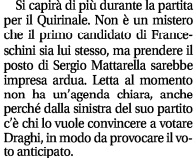Ero certo, anzi certissimo, che al Fatto Quotidiano non avrebbero perdonato a Franco Bernabè la partecipazione di giovedì scorso alla trasmissione di Lilli Gruber su la 7, per quanto in quel salotto televisivo il direttore dello stesso Fatto, Marco Travaglio, e taluni dei suoi collaboratori siano praticamente di casa, e trattati di solito con i guanti. Che invece la conduttrice dismette spesso con altri ospiti che non le fanno la cortesia di assecondarla nelle risposte.
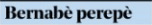
Puntualmente è arrivato oggi non un corsivetto, o “la cattiveria” di giornata, o una vignetta, o il fotomontaggio più o meno di rito -non mancando certamente materiale d’archivio su cui lavorare contro un manager così noto, “ex amministratore di tutto”, come lo ha ironicamente definito Travaglio- ma un editoriale vero e proprio. Il cui titolo parla da solo: “Bernabè perepè”.
Con mia grande sorpresa, tuttavia, conoscendo bene l’insofferenza verbale e mimica dimostrata da Travaglio ogni qualvolta gli capita di vedere e sentire uno che non parla male dell’arcinemico Silvio Berlusconi, o addirittura ne parla bene, il direttore del Fatto Quotidiano non se l’è presa per il riconoscimento reso da Bernabè all’ex presidente del Consiglio di non avere mai cercato di interferire in alcun modo nel suo lavoro alla guida di importantissime aziende e gruppi.

No. Questa volta Travaglio non è riuscito a digerire il fatto, minuscolo, che Bernabè abbia elogiato come più non si poteva il presidente del Consiglio in carica Mario Draghi, senza alcun imbarazzo per essere stato da lui appena nominato presidente delle Acciaierie d’Italia, senza mai neppure nominare, e tanto meno riconoscere qualche merito a chi lo ha preceduto a Palazzo Chigi. E ne è stato così barbaramente, incivilmente, ingiustamente, ignobilmente allontanato da meritarsi quel volumetto dello stesso Travaglio dal titolo di un giallo come “Conticidio”. Sto scrivendo naturalmente di Giuseppe Conte, non una ma due volte capo del governo nella storia recentissima della Repubblica italiana, uscito da Palazzo Chigi ancora fresco di energie e già dichiaratamente sfinito, o quasi, dalla fatica immane -lo riconosco anch’io- di presiedere il Movimento 5 Stelle sotto la vigilanza -pardon, la “garanzia”- di Beppe Grillo. Che dopo averlo designato a quella carica lo bocciò clamorosamente e pubblicamente come incapace e poi lo riabilitò facendogli pagare, come ogni buon genovese, il pranzo della riconciliazione, o del presunto chiarimento, in una trattoria sulla sabbia toscana di Marina di Bibbona. Dove di casa, intesa in tutti i sensi, anche come villa con tanto di stanze, servizi, cancello e utenze per la residenza estiva, non era però il pugliese Conte, ma il ligure Grillo.
Più che un attacco a Bernabè, peraltro accusato da qualche critico sino a qualche mese fa di essere particolarmente attento anche alla novità politica costituita dai grillini, al netto delle loro stravaganze e delle loro aggressioni verbali per frenare le quali si è dovuto mettere mano anche al regolamento, che ora vieta l’uso di parole e immagini volente; più che un attacco a Bernabè, dicevo, quella di Travaglio mi è sembrata una specie di scenata di gelosia, o nostalgia. Di cui Conte sarà rimasto, si spera, commosso.
Ripreso da http://www.startmag.it