Sembrano dunque passati, o si sono quanto meno allontanati, i tempi del “Conte dimezzato”, del “presidente dandy” elegante e ondeggiante nell’imitazione che ne fa Maurizio Crozza, dell’uomo “di polsino” più che di polso, di “sor Contento”, del “quasi presidente” e, ultimo per la penna del severo Ezio Mauro su Repubblica, del “premier forse nato” ma “per gli uomini di Stato stiamo ancora aspettando”.
Il presidente del Consiglio, anche a costo di procurarsi altri soprannomi di cui cercare poi di liberarsi, ha voluto cambiare registro e proporsi per quello che sempre, dal primo momento, lo ha incoraggiato ad essere il capo dello Stato nominandolo: un presidente risoluto nell’esercizio delle funzioni assegnategli dall’articolo 95 della Costituzione. Egli “dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri”.
Sulle orme del predecessore Giorgio Napolitano, che abituò i giornalisti a dichiarazioni esplicative delle sue decisioni a chiusura delle crisi di governo, Sergio Mattarella confessò l’anno scorso una certa ritrosia avvertita nell’accettare la designazione di un pur apprezzato professionista come Conte, professore di diritto e avvocato civilista, fattagli dai due partiti della maggioranza maturata dopo le elezioni politiche attorno a un contratto. Che volle ispirarsi proprio nel nome a quello ben più voluminoso e dettagliato faticosamente stipulato a Berlino dai popolari e dai socialdemocratici per il nuovo e dichiaratamente ultimo governo di Angela Merkel. Altra cosa, mi direte. Eh, sì. Ma, appunto, lo dite voi.
Il presidente della Repubblica avrebbe preferito una persona -spiegò- di esperienza “elettiva”, da elezione a parlamentare, specie in considerazione del fatto che avrebbe dovuto essere affiancato da due vice presidenti di maggiore caratura politica, diciamo così, entrambi leader dei movimenti al governo, ma senza averne mai praticato neppure l’ombra a livello locale: nessuno dei tre, peraltro.
Poi Mattarella si diede coraggio, visto che era già un miracolo la nascita di una maggioranza nell’incerto scenario uscito dalle urne del 4 marzo, e la conseguente rinuncia all’ipotesi delle elezioni anticipate cui già sembrava rassegnato. Ma soprattutto cercò di dare coraggio allo stesso Conte, esortandolo appunto -come dicevo- a un esercizio per niente timido delle sue funzioni, e garantendogli una sponda nelle difficoltà che avesse dovuto incontrare. So che quell’offerta o garanzia di Mattarella impensierì, dietro le quinte della festa del giuramento del governo gialloverde al Quirinale, entrambi i partiti della maggioranza, specie quello delle cinque stelle, in cui durante la crisi era esplosa addirittura la tentazione -ricordate?- del cosiddetto impeachment del capo dello Stato per le resistenze opposte alla lista dei ministri così come gli era stata proposta in un primo momento: con Paolo Savona al Ministero dell’Economia, poi dirottato al Ministero senza portafogli per gli affari europei, e ora neppure più ministro ma presidente della Consob, la Commissione nazionale di controllo delle società e della Borsa.
Lo zampino di Mattarella, e forse anche qualcosa in più dello zampino, è stato avvertito durante i mesi scorsi in più di un passaggio difficile del governo e, più in particolare, del suo presidente alle prese con l’attivismo vigilante e le opposte esigenze dei due vice: per esempio, nella gestione della prima nave affacciatasi d’estate alle coste italiane con migranti di cui al Viminale si impedì lo sbarco. Poi fu il turno delle trattative con la Commissione Europea di Bruxelles per ridurre il deficit di bilancio festeggiato sul balcone di Palazzo Chigi da Luigi Di Maio come la soluzione, addirittura, del problema della povertà in Italia. Poi arrivarono i turni del gasdotto con approdo in Puglia -Tap- imposto da Conte ai grillini, e delle nomine alla Banca d’Italia, bloccate sino a pochissimo tempo fa per le resistenze, a turno, di uno o l’altro partito di governo.
Ma l’evento un po’ liberatorio, diciamo così, per il dispiegamento dell’esercizio delle funzioni di presidente del Consiglio è stato la rimozione del sottosegretario leghista Armando Siri, difeso ostinatamente, su posizioni di pur inusuale garantismo, dal proprio partito come indagato per corruzione ma alla fine abbandonato al suo destino di ex per il puntiglio di “scollatore” dichiarato da Conte. Il quale è stato sicuro dal primo momento che il governo non sarebbe caduto su questo, e che non vi sarebbe stato neppure bisogno di contarsi nel Consiglio dei Ministri. Tanto sicuro del fatto suo è stato il presidente del Consiglio -e non del Coniglio, come lo ha chiamato con sarcasmo su tutta la prima pagina il manifesto– da incorrere nell’infortunio di un decreto poi corretto per superare l’esame imprescindibile, e forse sottovalutato, del Quirinale.
Da allora, senza voler correre appresso ai retroscenisti sulle tracce di un accordo sottobanco fra Salvini e Conte perché il primo potesse difendere sino alla fine Siri e l’altro potesse scollarlo senza conseguenze, o di un maggiore spazio di manovra procurato a Conte dai sei punti perduti da Salvini in meno di un mese nei sondaggi elettorali diffusi dal Corriere della Sera, il presidente del Consiglio è andato crescendo di autostima. Il quotidiano Libero gli ha addirittura applicato l’immagine spagnola del Caudillo per via del giornale di Madrid El Pais col quale Conte ha liquidato come “illusione ottica”, e anche acustica evidentemente, la percezione a lungo diffusasi di Salvini come del vero capo, o quanto meno protagonista, del governo italiano.
Al pubblico più strettamente di casa, parlando in particolare ai giornalisti accorsi all’inaugurazione della nuova sede dei servizi segreti, e a poca e forse non casuale distanza dal capo dello Stato, Conte aveva già raccomandato di non confondere la sua autorità con quella pur notevole ma evidentemente inferiore di “arbitro”.
A chi immagina a questo punto, con euforia o con paura, secondo i gusti, una prateria davanti al tonico o tonificato presidente grillino del Consiglio, pubblicamente entrato nel Movimento delle cinque stelle in occasione del raduno dell’autunno scorso al Circo Massimo, di nome e di fatto, suggerirei tuttavia prudenza, non essendo mancati nella storia della Repubblica italiana presidenti del Consiglio tanto apparentemente forti, caratterialmente e/o politicamente, da cadere come quelli deboli.
Alcide De Gasperi, che era appunto De Gasperi, il presidente della ricostruzione dell’Italia dalle macerie della seconda guerra mondiale, si spense politicamente, e l’anno dopo anche fisicamente, con un modesto, direi banale governo monocolore democristiano che non riuscì nell’estate del 1953 a ottenere neppure la fiducia d’esordio, o investitura.
Giuseppe Pella, subito dopo imposto alla Dc dal presidente della Repubblica Luigi Einaudi, nonostante o proprio per la forza dimostrata schierando sui confini orientali le truppe italiane per rivendicare Trieste ancora contesa anche dalla Iugoslavia, cadde prima della Befana per un modestissimo rimpasto tentato per sostituire il ministro dell’Agricoltura.
Mario Scelba, arrivato alla guida del governo dopo essere stato un fortissimo, mitico ministro dell’Interno, si dimise nel 1955 per ragioni di cortesia personale e politica nelle mani del collega di partito Giovanni Gronchi eletto al Quirinale e si vide sfrattato.
Nel 1959 Amintore Fanfani contemporaneamente segretario della Dc, presidente del Consiglio e ministro degli Esteri perse tutte e tre le cariche, contemporaneamente, in meno di un anno da quando le aveva irruentemente cumulate.
Fernando Tambroni, l’ultimo avvocato alla guida del governo prima di Conte, nel 1960 pagò con la caduta sia la popolarità guadagnatasi con la riduzione del prezzo della benzina sia l’impopolarità procuratasi nelle piazze insanguinate dai disordini per avere portato nella maggioranza i neofascisti del Movimento Sociale.
Nel 1968 Aldo Moro, il conterraneo cui Conte ha voluto ispirarsi sin dall’arrivo a Palazzo Chigi, ne fu allontanato in malo modo, dopo quattro anni di ininterrotto governo, sotto il fuoco combinato del suo partito, la Dc, e del Psi: l’uno considerandolo troppo accomodante verso l’altro, ma essendo stato egli in realtà severo con entrambi. Ai democristiani, per esempio, Moro negò la rottura con i socialisti sollecitata dopo meno di un anno, nella velenosa estate del 1964, tra i “rumori di sciabole” avvertiti da Pietro Nenni nei suoi diari, e ai socialisti appena unificati un’inchiesta parlamentare sui servizi segreti. Che Moro considerava un ossimoro.
Bettino Craxi, che nel 1985 aveva prima sconfitto il Pci nel referendum sui tagli anti-inflazionistici alla scala mobile dei salari e poi neutralizzato i marines di Reagan, sbarcati a Sigonella, dopo la conclusione del sequestro della motonave Achille Lauro, per cercare di farne la dependance di un aeroporto americano, fu estromesso nel 1987 da Palazzo Chigi perché troppo ingombrante agli occhi dell’allora segretario della Dc Ciriaco De Mita. Che però nel prenderne il posto, l’anno dopo, non riuscì a tenerlo per più di 13 mesi essendosi ostinato pure lui, come Fanfani, a fare insieme il capo del partito e del governo.
Giulio Andreotti, il “Belzebù” dei suoi nemici, o “la volpe” sfuggita alle pelliccerie per sette governi, uno in meno del suo scopritore e maestro De Gasperi, dovette nel 1993 seguire la corrente giustizialista votando con la mano alzata al Senato contro se stesso, cioè a favore del processo di mafia allestitogli a Palermo da Giancarlo Caselli. E conclusosi almeno senza condanna, deve ammettere il famoso magistrato d’accusa, che contesta ancora l’assoluzione per via della prescrizione applicata a una parte delle imputazioni.
Silvio Berlusconi, l’uomo nuovo e insieme forte della cosiddetta seconda Repubblica, eletto direttamente nell’immaginario collettivo alla guida del governo, ha potuto esserne scalzato -al netto di tutte le sue vicende giudiziarie- con quello che lui ha un po’ curiosamente chiamato “colpo di Stato”, avendovi contribuito con la controfirma della nomina del suo imminente successore Mario Monti a senatore a vita e poi con l’appoggio per un buon annetto al Gabinetto dei tecnici.
Massimo D’Alema, il “Baffino” di ferro, non resistette a Palazzo Chigi più di un anno e mezzo, e con ben due governi, per avere ceduto alla tentazione gladiatoria di scommettere su un certo risultato di un turno di elezioni regionali da cui avrebbe potuto invece defilarsi.
Romano Prodi, che ha un caratterino pure lui, a dispetto del soprannome di “Mortadella” affibbiatogli dagli avversari di destra, e non contestato da quelli di sinistra che ne determinarono almeno la prima caduta, nel 1998, conseguì ai suoi tempi due curiose vittorie elettorali sullo stesso rivale, che era Berlusconi: curiose, perché esaurite entrambe a meno della metà delle rispettive legislature.
Fra i presidenti del Consiglio delle tre edizioni, o due edizioni e mezza, della Repubblica il più giovane, il più ambizioso e il più dotato dichiaratamente di un “caratteraccio”, convinto che senza non se ne avrebbe nessuno, come d’altronde soleva dire l’indimenticabile presidente della Repubblica Sandro Pertini, è stato sicuramente Matteo Renzi. Il quale ha spinto lo spirito, anzi l’istinto del comando -che il compianto Gianni De Michelis, arrivato nel 1992 sulla soglia di Palazzo Chigi, chiamava “il piacere dell’autorità”- sino a intestarsi sia come segretario del Pd sia come presidente del Consiglio un progetto, anzi un sistema di “rottamazione”.
E’, tutto sommato, naturale che Renzi, anche ora che è o recita il ruolo dell’appartato, o di semplice “senatore di Scandicci”, sia molto avaro nel giudicare i suoi successori a Palazzo Chigi. Lo è anche con Paolo Gentiloni, pur da lui stesso spinto alla guida del governo quando decise di allontanarsene per avere perduto il referendum sulla riforma costituzionale che aveva compiuto l’errore di trasformare in un plebiscito sulla sua leadaership: un errore che Matteo Salvini, pur propostosi di non seguirne l’esempio, ha stranamente copiato prima ancora di diventare presidente del Consiglio trasformando in un referendum su di sè le elezioni europee, regionali e amministrative del 26 maggio.
Da Gentiloni il predecessore si aspettava forse un carattere abbastanza forte da sostenere, dopo la sconfitta referendaria, la richiesta di elezioni anticipate da lui avanzata come segretario del Pd per cercare di investire nel rinnovo del Parlamento il rilevante 40 per cento raccolto dalla bocciata riforma costituzionale. Ma Gentiloni condivise il no del presidente della Repubblica allo scioglimento delle Camere, da cui derivò obiettivamente un epilogo della legislatura tanto lungo quanto rovinoso per il segretario del Pd, per quanto preoccupatosi di farsi confermare dal congresso. Che fu convocato in modi e termini tali da lasciare alla minoranza dei rottamati o rottamandi la ragione, o il pretesto, di una scissione che avrebbe quanto meno contribuito a spianare la strada al successo dei grillini nelle elezioni ordinarie del 2018.
“Adesso è il tempo del premier senza carattere”, ha appena dichiarato Renzi a Repubblica parlando di Conte anche dopo l’intervista un po’ muscolare del professore a El Pais. Ai fatti l’ardua sentenza.
Pubblicato su Il Dubbio
 al gioco di parole e di accenti con cui Emilio Giannelli ha rappresentato sulla prima pagina del Corriere della Sera la disavventura giudiziaria degli amministratori leghisti di Legnano, a cominciare dal sindaco. E ha giocato sulla somiglianza disegnata fra la statua della Giustizia e il volto ormai abituale, per i vignettisti, del vice presidente grillino del Consiglio Luigi Di Maio per rafforzare il ruolo di difensore e garante dell’onestà assuntosi dal capo del movimento delle 5 stelle anche contro il suo alleato di governo e omologo a Palazzo Chigi, quando i due vi si recano dai loro dicasteri.
al gioco di parole e di accenti con cui Emilio Giannelli ha rappresentato sulla prima pagina del Corriere della Sera la disavventura giudiziaria degli amministratori leghisti di Legnano, a cominciare dal sindaco. E ha giocato sulla somiglianza disegnata fra la statua della Giustizia e il volto ormai abituale, per i vignettisti, del vice presidente grillino del Consiglio Luigi Di Maio per rafforzare il ruolo di difensore e garante dell’onestà assuntosi dal capo del movimento delle 5 stelle anche contro il suo alleato di governo e omologo a Palazzo Chigi, quando i due vi si recano dai loro dicasteri.  di prima pagina, dei “legnati a Legnano” in questo finale di campagna elettorale per il voto europeo e amministrativo del 26 maggio. Cui Salvini si avvicina con viaggi sempre più difficili e contestati in volo, in treno, in auto e a piedi.
di prima pagina, dei “legnati a Legnano” in questo finale di campagna elettorale per il voto europeo e amministrativo del 26 maggio. Cui Salvini si avvicina con viaggi sempre più difficili e contestati in volo, in treno, in auto e a piedi.  contributo l’informazione con la solita enfatizzazione delle inchieste giudiziarie, anche nei giornali ritenuti generalmente più sobri, ma ugualmente tentati dallo scoop, vero o presunto che esso poi si riveli lungo la strada. Esasperata è anche la rappresentazione , diciamo la verità, di Salvini come del Duce redivivo, che gli copia le leggi razziali con le norme sulla sicurezza già fatte approvare dal Parlamento e con quelle che vorrebbe aggiungere.
contributo l’informazione con la solita enfatizzazione delle inchieste giudiziarie, anche nei giornali ritenuti generalmente più sobri, ma ugualmente tentati dallo scoop, vero o presunto che esso poi si riveli lungo la strada. Esasperata è anche la rappresentazione , diciamo la verità, di Salvini come del Duce redivivo, che gli copia le leggi razziali con le norme sulla sicurezza già fatte approvare dal Parlamento e con quelle che vorrebbe aggiungere. Quotidiano- che Salvini “va punito dai cattolici nelle urne”. Non a caso, sempre nella rappresentazione del giornale di Marco Travaglio, il leader leghista sarebbe stato tenuto lontano dalle sacre stanze dove avrebbe cercato di essere ricevuto, almeno prima -presumo- di prendersela con l’elemosiniere del Pontefice che ha riattaccato la luce agli occupanti abusivi di un palazzo romano nei pressi della Basilica di San Giovanni.
Quotidiano- che Salvini “va punito dai cattolici nelle urne”. Non a caso, sempre nella rappresentazione del giornale di Marco Travaglio, il leader leghista sarebbe stato tenuto lontano dalle sacre stanze dove avrebbe cercato di essere ricevuto, almeno prima -presumo- di prendersela con l’elemosiniere del Pontefice che ha riattaccato la luce agli occupanti abusivi di un palazzo romano nei pressi della Basilica di San Giovanni.

 Che ha appena rilasciato un’intervista a più giornali di varia nazionalità per sottolineare “gli approcci diversi” di popolari e leghisti: tanto diversi da non farle ritenere né possibili né auspicabili accordi fra di loro. “La mia Europa saprà difendersi da Salvini”, fa dire nel titolo di prima pagina alla Merkel La Stampa pubblicando il suo messaggio mediatico agli elettori, e ai partiti, a dieci giorni ormai dalle elezioni continentali.
Che ha appena rilasciato un’intervista a più giornali di varia nazionalità per sottolineare “gli approcci diversi” di popolari e leghisti: tanto diversi da non farle ritenere né possibili né auspicabili accordi fra di loro. “La mia Europa saprà difendersi da Salvini”, fa dire nel titolo di prima pagina alla Merkel La Stampa pubblicando il suo messaggio mediatico agli elettori, e ai partiti, a dieci giorni ormai dalle elezioni continentali.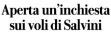 scarse presenze al Viminale per una campagna elettorale ormai “volante”, finita anche sotto i riflettori della Corte dei Conti e sempre più contestata con iniziative che hanno obbligato
scarse presenze al Viminale per una campagna elettorale ormai “volante”, finita anche sotto i riflettori della Corte dei Conti e sempre più contestata con iniziative che hanno obbligato le forze dell’ordine a interventi inusuali. Sono quelli contro gli “affacciati alla finestra”, come li ha definiti in prima pagina il manifesto con un titolo che potrebbe anche essere letto come un’esortazione, un’incitazione, un ordine, come preferite.
le forze dell’ordine a interventi inusuali. Sono quelli contro gli “affacciati alla finestra”, come li ha definiti in prima pagina il manifesto con un titolo che potrebbe anche essere letto come un’esortazione, un’incitazione, un ordine, come preferite.
 condividere la festa dei grillini, sopra e sotto il balcone di Palazzo Chigi, per il deficit al 2,4 per cento imposto da Luigi Di Maio al ministro dell’Economia Giovanni Tria. Poi -si ricorderà- il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, spinto dietro le quinte dal capo dello Stato, negoziò personalmente con la Commissione dell’Unione Europea la riduzione di quel 2,4 al 2,04 per evitare una rovinosa rottura e il procedimento d’infrazione.
condividere la festa dei grillini, sopra e sotto il balcone di Palazzo Chigi, per il deficit al 2,4 per cento imposto da Luigi Di Maio al ministro dell’Economia Giovanni Tria. Poi -si ricorderà- il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, spinto dietro le quinte dal capo dello Stato, negoziò personalmente con la Commissione dell’Unione Europea la riduzione di quel 2,4 al 2,04 per evitare una rovinosa rottura e il procedimento d’infrazione. sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio, dubitava pubblicamente di una simile prospettiva e faceva capire di non vedere l’ora di finirla, con una risolutiva crisi di governo. E un altro leghista, Roberto Maroni, predecessore di Salvini sia alla segreteria del partito sia al Ministero dell’Interno, ironizzava col Foglio sul “fisico bestiale” e sulla “giornata di 48 ore” del suo capitano.
sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio, dubitava pubblicamente di una simile prospettiva e faceva capire di non vedere l’ora di finirla, con una risolutiva crisi di governo. E un altro leghista, Roberto Maroni, predecessore di Salvini sia alla segreteria del partito sia al Ministero dell’Interno, ironizzava col Foglio sul “fisico bestiale” e sulla “giornata di 48 ore” del suo capitano.
 contro i 61 mila di Caltanisetta, i 51 mila di Mazara del Vallo, i 39 mila di Monreale, i 31 mila di Castelvetrano e via discendendo.
contro i 61 mila di Caltanisetta, i 51 mila di Mazara del Vallo, i 39 mila di Monreale, i 31 mila di Castelvetrano e via discendendo. nell’elezione di Lucio Greco a sindaco di Gela col 52,5 per cento, e l’appoggio del Pd, contro il leghista Giuseppe Spada. E l’ha interpretata senza mezzi termini come la prova che la salvezza di Forza Italia stia più nella capacità di raccordarsi al Pd che nella confluenza a tappe nella Lega perseguita dal governatore azzurro della Liguria Giovanni Toti.
nell’elezione di Lucio Greco a sindaco di Gela col 52,5 per cento, e l’appoggio del Pd, contro il leghista Giuseppe Spada. E l’ha interpretata senza mezzi termini come la prova che la salvezza di Forza Italia stia più nella capacità di raccordarsi al Pd che nella confluenza a tappe nella Lega perseguita dal governatore azzurro della Liguria Giovanni Toti.

 personalmente infilato nel pozzetto dei contatori dell’energia elettrica per togliere i sigilli posti sei giorni fa per una morosità di circa 300 mila euro e ripristinare così le forniture. “Ora paghino le bollette”, ha detto Salvini alludendo al Vaticano.
personalmente infilato nel pozzetto dei contatori dell’energia elettrica per togliere i sigilli posti sei giorni fa per una morosità di circa 300 mila euro e ripristinare così le forniture. “Ora paghino le bollette”, ha detto Salvini alludendo al Vaticano. 
 parlamentare, anziché governativa. In secondo luogo impose, in funzione “consociativa” secondo la valutazione condivisibile di Cazzola, che il progetto di legge venisse partorito da una commissione speciale. Che fu presieduta da Nino Cristofori, “sodale- ha scritto Cazzola- di Giulio Andreotti. Di cui infatti sarebbe poi stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dal 1989 al 1992, diventando ministro del Lavoro nel primo governo di Giuliano Amato.
parlamentare, anziché governativa. In secondo luogo impose, in funzione “consociativa” secondo la valutazione condivisibile di Cazzola, che il progetto di legge venisse partorito da una commissione speciale. Che fu presieduta da Nino Cristofori, “sodale- ha scritto Cazzola- di Giulio Andreotti. Di cui infatti sarebbe poi stato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dal 1989 al 1992, diventando ministro del Lavoro nel primo governo di Giuliano Amato.

 in prima pagina timori di crisi a Palazzo Chigi. Dove le preoccupazioni sarebbero state create, in particolare, dall’arrivo del testo di un decreto legge predisposto proprio da Salvini per una ulteriore stretta sul terreno della sicurezza e della gestione dei migranti, comprensiva dell’accorpamento al Viminale delle competenze oggi distribuite fra vari Ministeri. I cui titolari spesso si beccano fra di loro, specie in campagna elettorale, come avviene adesso, a due settimane dal rinnovo del Parlamento europeo, del Consiglio regionale piemontese e di numerose amministrazioni comunali.
in prima pagina timori di crisi a Palazzo Chigi. Dove le preoccupazioni sarebbero state create, in particolare, dall’arrivo del testo di un decreto legge predisposto proprio da Salvini per una ulteriore stretta sul terreno della sicurezza e della gestione dei migranti, comprensiva dell’accorpamento al Viminale delle competenze oggi distribuite fra vari Ministeri. I cui titolari spesso si beccano fra di loro, specie in campagna elettorale, come avviene adesso, a due settimane dal rinnovo del Parlamento europeo, del Consiglio regionale piemontese e di numerose amministrazioni comunali.  dello stesso Corriere della Sera, voglia mettere all’angolo il movimento delle 5 stelle, sino a provocare una crisi, sul terreno a lui più favorevole per la percezione che ne ha l’elettorato: quello appunto della sicurezza e del contenimento dell’’immigrazione in vista del ritorno, per quanto in ritardo, del bel tempo e della migliore navigabilità nel Mediterraneo.
dello stesso Corriere della Sera, voglia mettere all’angolo il movimento delle 5 stelle, sino a provocare una crisi, sul terreno a lui più favorevole per la percezione che ne ha l’elettorato: quello appunto della sicurezza e del contenimento dell’’immigrazione in vista del ritorno, per quanto in ritardo, del bel tempo e della migliore navigabilità nel Mediterraneo.  appartenenti anche alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri degli Esteri, della Difesa e delle Infrastrutture. Ma si potrebbe arrivare anche al Ministero dell’Economia, stando al ragionamento fatto da Salvini nella lettera per chiedere un “salto di qualità” nell’azione di governo per il contenimento e la prevenzione dell’immigrazione. Non si tratta di scippare niente a nessuno, in materia di competenze, perché -ha osservato il titolare della Farnesina- a discutere e a decidere sarebbe comunque collegialmente il Consiglio dei Ministri.
appartenenti anche alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri degli Esteri, della Difesa e delle Infrastrutture. Ma si potrebbe arrivare anche al Ministero dell’Economia, stando al ragionamento fatto da Salvini nella lettera per chiedere un “salto di qualità” nell’azione di governo per il contenimento e la prevenzione dell’immigrazione. Non si tratta di scippare niente a nessuno, in materia di competenze, perché -ha osservato il titolare della Farnesina- a discutere e a decidere sarebbe comunque collegialmente il Consiglio dei Ministri. 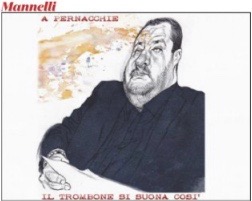 alla vigilia di un’altra rivoluzione grafica, ha generosamente paragonato il conflitto ormai permanente fra i due vice presidenti del Consiglio ad uno spartito musicale nel quale Salvini suona al pianoforte e Di Maio al violino. Beh, il pianoforte questa volta si è fatto sentire più del violino, anche se al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio il ministro dell’Interno preferiscono associarlo nella vignetta di prima pagina all’immagine e al suono del trombone.
alla vigilia di un’altra rivoluzione grafica, ha generosamente paragonato il conflitto ormai permanente fra i due vice presidenti del Consiglio ad uno spartito musicale nel quale Salvini suona al pianoforte e Di Maio al violino. Beh, il pianoforte questa volta si è fatto sentire più del violino, anche se al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio il ministro dell’Interno preferiscono associarlo nella vignetta di prima pagina all’immagine e al suono del trombone.
 chiamato “mare nero”, o dalle contestazioni rivoltegli in Calabria da elettori refrattari ai suoi comizi, o dalla rimozione del sottosegretario inquisito Armando Siri che ha dovuto alla fine accettare dopo averlo a lungo difeso;
chiamato “mare nero”, o dalle contestazioni rivoltegli in Calabria da elettori refrattari ai suoi comizi, o dalla rimozione del sottosegretario inquisito Armando Siri che ha dovuto alla fine accettare dopo averlo a lungo difeso;  Matteo Salvini, dicevo, ha reagito in un modo contraddittorio, a dir poco. Di cui ha subito profittato il suo omologo grillino alla vice Presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, per attaccarlo sino al sarcasmo e trarne qualche vantaggio nelle ultime due settimane di campagna elettorale per le europee, le regionali e le amministrative del 26 maggio.
Matteo Salvini, dicevo, ha reagito in un modo contraddittorio, a dir poco. Di cui ha subito profittato il suo omologo grillino alla vice Presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, per attaccarlo sino al sarcasmo e trarne qualche vantaggio nelle ultime due settimane di campagna elettorale per le europee, le regionali e le amministrative del 26 maggio. E tanto meno a mantenere tutto quello che ha promesso agli elettori in questo campo su cui, non meno o ancora di più che su quello fiscale, ha scommesso nella partita di governo con i grillini. Della quale peraltro potrà sempre meno giustificarsi vantando il permesso a giocarla datogli l’anno scorso dall’alleato di centrodestra Silvio Berlusconi, avendone ormai perduto ogni copertura, se mai ne ha avuto davvero una. Il Cavaliere si è nel frattempo indebolito, e in tutti i sensi: non solo in quello politico, dove Forza Italia è scesa ormai costantemente sotto il 10 per cento e combatte praticamente per la sopravvivenza, con tutti gli inconvenienti che comporta una condizione del genere.
E tanto meno a mantenere tutto quello che ha promesso agli elettori in questo campo su cui, non meno o ancora di più che su quello fiscale, ha scommesso nella partita di governo con i grillini. Della quale peraltro potrà sempre meno giustificarsi vantando il permesso a giocarla datogli l’anno scorso dall’alleato di centrodestra Silvio Berlusconi, avendone ormai perduto ogni copertura, se mai ne ha avuto davvero una. Il Cavaliere si è nel frattempo indebolito, e in tutti i sensi: non solo in quello politico, dove Forza Italia è scesa ormai costantemente sotto il 10 per cento e combatte praticamente per la sopravvivenza, con tutti gli inconvenienti che comporta una condizione del genere.