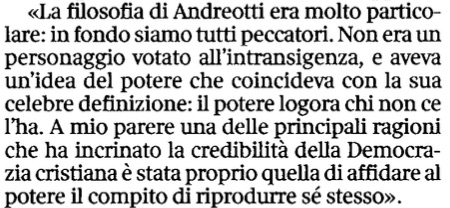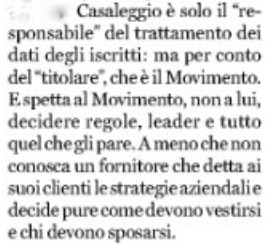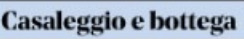Ogni tanto Goffredo Bettini mostra di avere capito di averla sparata grossa gridando al complotto contro Giuseppe Conte, non caduto -ha detto- ma fatto cadere da interessi più forti di lui, e a dispetto delle sue virtù salvifiche che i complottisti, appunto, non avrebbero voluto dargli il tempo di dimostrare pienamente. Per cui, poveretto, ora da nuovo Moro capace di scomporre e ricomporre equilibri malmessi egli è stato ridimensionato a un sostanziale vice di Beppe Grillo alle prese con la rifondazione di un movimento destinata, occhio e croce, al fallimento di tutte le altre rifondazioni politiche tentate in anni più o meno recenti, a cominciare da quella -ricordate?- del partito comunista.
Ma ogni volta che Bettini cerca di correggersi finisce per ripetere le stesse cose in modo peggiore, più pasticciato e meno credibile. Eccovene l’ultima prova, che pure sembrava promettente per il riconoscimento, finalmente, di qualche fesseria politica effettivamente commessa da Conte almeno negli ultimi mesi del suo secondo governo: “C’erano degli interessi perché la campagna è stata sproporzionata agli errori e non mi pare che questo voglia dire che c’è stato un complotto”. Ah no? “Non esiste il complotto”, ha insistito l’oracolo spiegando però: “Renzi ha fatto cadere il governo Conte 2 ma credo che, al di là di Renzi, ci sia stato qualcosa di più grande che si è mosso”. Ma allora ci risiamo…col complotto.
Eh, sì, ci risiamo perché sentite il proseguimento del discorso, misto di riconoscimento dei propri limiti investigativi e di imitazione della buonanima di Pier Paolo Pasolini: “Non sono uno 007, non sta alla politica portare prove. Do un’opinione e una lettura politica”.

Sentite, anzi rileggete con me ciò che il 14 novembre 1974 Pasolini scrisse sul Corriere della Sera diretto da Piero Ottone a proposito non di colpi di Stato e stragi: “Io so ma non ho le prove, non ho nemmeno indizi. Io so perché sono intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa, o si tace, che coordina fatti anche lontani, che mette insieme pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, la follia, il mistero”.
Non fece in tempo, Pasolini, se mai ne avesse avuto i titoli, a partecipare ad un concorso per magistrati. Lo avrebbe vinto di sicuro, visti anche certi pubblici ministeri e giudici in circolazione, fra i quali -grazie a Dio- ogni tanto c’è qualcuno che mostra di ravvedersi, com’è appena accaduto -per giunta sul Fatto Quotidiano- a Henry John Voodcock in polemica con Gian Carlo Caselli.
Per fortuna, all’età che ha, e col solo diploma di maturità scientifica che ha avuto il tempo e la voglia di prendere, possiamo risparmiarci l’approdo di Bettini dalla politica alla magistratura.
Ripreso da http://www.startmag.it e http://www.policymakermag.it