Per quanto messa ampiamente nel conto, si è rivelata superiore al previsto l’insofferenza di Giancarlo Caselli per le celebrazioni mediatiche ed anche istituzionali – com’è avvenuto ieri alla Biblioteca Giovanni Spadolini al Senato- del centenario della nascita del suo ex ed ormai defunto imputato eccellente di mafia Giulio Andreotti.
Già intervenuto con largo anticipo lunedì 7 gennaio sul Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, dov’è di casa, con un duro articolo di monito a non “stravolgere la verità” e “truffare il popolo italiano in nome del quale si pronunciano le sentenze”, Caselli ha voluto scrivere una lettera al Corriere della Sera -che l’ha pubblicata sabato 12 gennaio- per contestare la rappresentazione quanto meno scettica, fatta su quel giornale da Antonio Polito, di un Andreotti assolto per modo di dire. In particolare, assolto dall’accusa formulata proprio da Caselli, quand’era capo della Procura di Palermo, di concorso esterno in associazione mafiosa ma prescritto per i fatti, pur accertati secondo lo stesso Caselli fino alla primavera del 1980, di associazione a delinquere. Che era il reato contestabile appunto sino a 39 anni fa, prima che nel codice penale entrasse quello specifico di associazione mafiosa.
A Polito, come più in generale aveva fatto sul giornale di Travaglio prevenendo quanti si accingevano ad occuparsi della lunga vicenda processuale di Andreotti, durata ben undici anni, Caselli è tornato a rileggere, diciamo cosi, testo alla mano, la sentenza d’appello in cui all’ex presidente del Consiglio sarebbero stati fatti barba e capelli per i suoi rapporti con esponenti neppure secondari della mafia.
In particolare, l’ex magistrato ora in pensione ha indicato come emblematici “due incontri” di Andreotti, presenti il suo luogotenente in Sicilia Salvo Lima, Vito Ciancimino e i cugini Salvo, col “capo dei capi” di mafia Stefano Bontate per discutere anche dell’assassinio del presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, suo collega di partito e fratello dell’attuale presidente della Repubblica, Sergio: assassinio compiuto la mattina della Befana proprio del 1980. Di cui è stato quindi celebrato in questi giorni il trentanovesimo anniversario, con una intensità però mediatica e politica che ha dato a qualcuno, a torto o a ragione, il pretesto per contrapporlo in qualche modo alla ricorrenza del centenario della nascita di Andreotti.
A quest’ultimo proprio Caselli, sempre riferendosi alla sentenza d’appello, e di revisione di quella pienamente assolutoria di primo grado, emessa a Palermo nel processo da lui promosso, è tornato a rimproverare di non avere usato le informazioni probabilmente ricevute da Bontate, morto l’anno dopo, per aiutare la magistratura a fare piena luce sull’assassinio di Piersanti Mattarella. Che “aveva pagato con la vita il coraggio di essersi opposto a Cosa Nostra”, ha ricordato in modo questa volta davvero pertinente l’ex magistrato anche nel primo intervento sul Fatto Quotidiano.
Implacabile nella sua reazione al pur “interessante” articolo dell’editorialista e vice direttore del Corriere della Sera, Caselli ha citato la sentenza d’appello del 2003 per incidere anche sulle colonne del più diffuso giornale italiano che Andreotti “con la sua condotta ha, non senza personale tornaconto, consapevolmente e deliberatamente coltivato una stabile relazione col sodalizio criminale ed arrecato, comunque, allo stesso un contributo rafforzativo, manifestando la sua disponibilità a favorire i mafiosi”.
Il buon Polito ha proposto un po’ ironicamente in un brevissimo corsivo di replica a Caselli una soluzione di “compromesso” alla disputa sulla conclusione del processo di mafia al 7 volte presidente del Consiglio e 27 volte ministro: “non condannato”. Cioè, non assolto e neppure condannato.
Ignoro, almeno sino ad ora, la reazione di Caselli al “lodo” Polito. Nel mio piccolo, molto piccolo per carità, memore anche di un’analoga polemica avuta con Caselli nel 2008 sulle colonne del Tempo, preferisco seguire il percorso suggerito in questi giorni su facebook da un figlio di Andreotti, Stefano. Che ha riproposto all’attenzione del pubblico navigante la lettera scritta proprio al Tempo in quell’occasione dagli avvocati dell’ex imputato eccellente, allora peraltro ancora in vita. Dal quale ho motivo di ritenere che fosse venuta l’idea di quella missiva per non intervenire direttamente lui nella polemica, come io invece gli avevo chiesto ottenendo una risposta interlocutoria.
Gli avvocati Giulia Bongiorno e Franco Coppi, nell’ordine in cui firmarono la lettera, non credo solo per ragioni di cavalleria da parte del professore e titolare dello studio legale, visto il particolare impegno messo nella difesa dell’ex presidente del Consiglio dall’attuale ministra della funzione pubblica, contestarono a Caselli di fermarsi sempre, nei suoi interventi critici sul loro assistito, alla sentenza d’appello. E di limitarsi ad accennare al terzo e definitivo verdetto, quello della Cassazione emesso alla fine dell’anno successivo, come ad una pura e semplice ratifica dell’altro.
Invece nella sentenza della Cassazione si trova ciò che Caselli, secondo Stefano Andreotti, cerca sempre di tenere per sé, sapendo forse che chi lo legge sui giornali, o lo sente alla radio o in televisione, difficilmente ha poi la voglia e il tempo di controllare scrupolosamente gli atti. Si legge, in particolare, nelle carte della suprema Corte che da parte dei giudici di appello in ordine ai fatti prescritti “la ricostruzione e la valutazione dei singoli episodi è stata effettuata in base ad apprezzamenti e interpretazioni che possono anche non essere condivise”.
Ancora più in particolare, nella sentenza davvero definitiva di un processo -non dimentichiamolo- alla cui “autorizzazione” lo stesso imputato contribuì votando palesemente a favore nell’aula del Senato, e quindi rinunciando per la parte che lo interessava all’immunità  ancora spettantegli in quel momento come parlamentare, è scritto che agli apprezzamenti e alle interpretazioni dei giudici d’appello, sempre in ordine ai fatti coperti dalla prescrizione, “sono contrapponibili altre dotate di uguale forza logica”. Non mi sembrano, francamente, parole e concetti di poco conto, ignorabili o sorvolabili in una polemica così aspra come quella che l’ex capo della Procura della Repubblica di Palermo usa condurre ogni volta che ne ha l’occasione parlando o scrivendo della vicenda giudiziaria di Andreotti.
ancora spettantegli in quel momento come parlamentare, è scritto che agli apprezzamenti e alle interpretazioni dei giudici d’appello, sempre in ordine ai fatti coperti dalla prescrizione, “sono contrapponibili altre dotate di uguale forza logica”. Non mi sembrano, francamente, parole e concetti di poco conto, ignorabili o sorvolabili in una polemica così aspra come quella che l’ex capo della Procura della Repubblica di Palermo usa condurre ogni volta che ne ha l’occasione parlando o scrivendo della vicenda giudiziaria di Andreotti.
Caselli, si sa, avrebbe voluto che il senatore a vita, nonostante la lunghezza del procedimento cui era stato sottoposto, protrattosi -ripeto- per undici anni, ben oltre forse la “ragionevole durata” richiesta dall’articolo 111 della Costituzione nel nuovo testo in vigore dal 1999, rinunciasse anche alla prescrizione. E ancora gli contesta praticamente, anche da morto, di non averlo fatto.
Una volta, andato a trovarlo a Palazzo Giustiniani in occasione di un compleanno, ne parlai con Andreotti, reduce da una fastidiosa influenza. Ma più che le sue parole, oggi facilmente confutabili dai suoi irriducibili avversari perché sarebbero postume, preferisco riferire quelle appena pronunciate dalla figlia Serena in una intervista ai tre giornali –Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino- del gruppo Riffeser: “Avremmo voluto batterci per ottenere una forma di completo scagionamento, di piena innocenza. L’abbiamo detto al babbo, ma lui e la mamma erano stanchi e hanno detto basta. Fermiamoci, va bene così, fu la risposta”. La mamma di Serena, Livia, dopo tante apprensioni e amarezze sarebbe stata peraltro dolorosamente colpita da una inguaribile malattia neurologica. Non dico di più per dare un’idea di ciò che accadde in quei tempi ad Andreotti e alla sua famiglia, a dispetto della tranquillità olimpica, o quasi, che l’ex presidente del Consiglio ostentava in pubblico, e nelle aule processuali, o dintorni, che egli frequentava con lo scrupolo di sempre.
E’ impressionante, a quest’ultimo proposito, il racconto che in questi giorni ha fatto un amico giornalista dell’allora imputato di una serata trascorsa con lui in un albergo di Palermo, fra un’udienza processuale e l’altra. Andreotti trovava il tempo, e la voglia, di parlare degli anni giovanili in cui da sottosegretario di Alcide De Gasperi alla Presidenza del Consiglio si occupava anche di spettacolo e frequentava attori e attrici incorrendo una volta nelle proteste della moglie. Che si ingelosì davanti ad una foto che lo ritraeva sorridente a Venezia con Anna Magnani, allora legata a Roberto Rossellini. Che prima ancora di conoscere e di unirsi a Ingrid Bergman già faceva soffrire, diciamo così, la grande attrice romana.
Francamente, anche alla luce delle postille della Cassazione su cui Caselli di solito tace, non mi sembra giusto -e neppure umano, aggiungerei- trattare ancora Andreotti, a sei anni circa della morte, come un imputato e partecipare ad una caccia contro di lui alla maniera un po’ dell’ispettore di polizia Javert con l’ex galeotto Jean Valjean nei Miserabili di Victor Hugo. E con questo, scusandomi in anticipo con Caselli se dovesse sentirsi ingiustamente colpito da questo richiamo letterario, davvero completo e chiudo la rievocazione di Andreotti cominciata martedì scorso 8 gennaio su queste pagine, in vista del centenario della sua nascita.
Che riposi davvero e finalmente in pace, avvolto nella bandiera pur metaforica dell’articolo 59 della Costituzione, applicatogli nella nomina a senatore a vita per avere “illustrato la Patria”, il protagonista di tantissimi anni della politica italiana. Cui qualcuno cerca ogni tanto di paragonare i davvero, e sotto tutti gli aspetti, lontanissimi attori di oggi, ora accomunandogli l’ex presidente del Consiglio, pure lui, Mario Monti per la sua ironia pungente, ora il presidente del Consiglio in carica Giuseppe Conte per le mediazioni con cui si sta cimentando, ora addirittura il giovanissimo vice presidente grillino del Consiglio Luigi Di Maio per la sua agilità di posizionamento. Ha fatto quest’ultimo paragone persino in un saggio il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana mettendo a dura prova la sedia alla quale ero appoggiato leggendolo.
Pubblicato su Il Dubbio
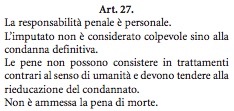 comminatigli dai tribunali per quattro omicidi, ne ha distrutto di un colpo la credibilità istituzionale di ministro della Repubblica. Che ha giurato al Quirinale davanti al capo dello Stato, firmandone poi il verbale, di “osservare lealmente la Costituzione”. Eppure essa dice all’articolo 27, fra l’altro: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
comminatigli dai tribunali per quattro omicidi, ne ha distrutto di un colpo la credibilità istituzionale di ministro della Repubblica. Che ha giurato al Quirinale davanti al capo dello Stato, firmandone poi il verbale, di “osservare lealmente la Costituzione”. Eppure essa dice all’articolo 27, fra l’altro: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Questo, pur in un Paese ormai sgangherato culturalmente e politicamente come il nostro, può sfuggire all’ultimo manettaro incontrato per strada, e che magari avrebbe preferito la pena di morte all’ergastolo per Battisti, ma non a un ministro dell’Interno fra le cui aspirazioni c’è anche quella di guidare un giorno il governo. E spero che gli basti il governo.
Questo, pur in un Paese ormai sgangherato culturalmente e politicamente come il nostro, può sfuggire all’ultimo manettaro incontrato per strada, e che magari avrebbe preferito la pena di morte all’ergastolo per Battisti, ma non a un ministro dell’Interno fra le cui aspirazioni c’è anche quella di guidare un giorno il governo. E spero che gli basti il governo.  di capire, dopo avere scoperto quelli in arme fra altre sbarre, quando era solo un criminale comune. Eppure, a parte il contributo obbiettivo e anche di sangue – ricordo Guido Rossa a Genova nel 1979- che va riconosciuto ai comunisti nella lotta al terrorismo in Italia, senza lasciarsi condizionare dal famoso “album di famiglia” onestamente ammesso da Rossana Rossanda sul manifesto, mi sembrava di aver letto da qualche parte che a Salvini da giovane la sinistra non dispiacesse.
di capire, dopo avere scoperto quelli in arme fra altre sbarre, quando era solo un criminale comune. Eppure, a parte il contributo obbiettivo e anche di sangue – ricordo Guido Rossa a Genova nel 1979- che va riconosciuto ai comunisti nella lotta al terrorismo in Italia, senza lasciarsi condizionare dal famoso “album di famiglia” onestamente ammesso da Rossana Rossanda sul manifesto, mi sembrava di aver letto da qualche parte che a Salvini da giovane la sinistra non dispiacesse.

 ancora spettantegli in quel momento come parlamentare, è scritto che agli apprezzamenti e alle interpretazioni dei giudici d’appello, sempre in ordine ai fatti coperti dalla prescrizione, “sono contrapponibili altre dotate di uguale forza logica”. Non mi sembrano, francamente, parole e concetti di poco conto, ignorabili o sorvolabili in una polemica così aspra come quella che l’ex capo della Procura della Repubblica di Palermo usa condurre ogni volta che ne ha l’occasione parlando o scrivendo della vicenda giudiziaria di Andreotti.
ancora spettantegli in quel momento come parlamentare, è scritto che agli apprezzamenti e alle interpretazioni dei giudici d’appello, sempre in ordine ai fatti coperti dalla prescrizione, “sono contrapponibili altre dotate di uguale forza logica”. Non mi sembrano, francamente, parole e concetti di poco conto, ignorabili o sorvolabili in una polemica così aspra come quella che l’ex capo della Procura della Repubblica di Palermo usa condurre ogni volta che ne ha l’occasione parlando o scrivendo della vicenda giudiziaria di Andreotti.
 italiano dove scontare i due ergastoli guadagnatisi per quattro omicidi commessi nei cosiddetti anni di piombo
italiano dove scontare i due ergastoli guadagnatisi per quattro omicidi commessi nei cosiddetti anni di piombo in Italia, avrà sicuramente notato quanto il ministro dell’Interno abbia evitato di assumersi tutti o i maggiori meriti dell’operazione. Lo ha evitato resistendo anche ai tentativi un po’ melliflui del conduttore di compiacere la sua vanità personale e politica, fra un sorriso e un’allusione, non foss’altro per ricambiargli il favore professionale ricevuto con quella nuova e puntuale presenza nella sua “non arena”. Che è poi un nome destinato ad ampliarla, in riferimento alle precedenti e interrotte edizioni alla Rai.
in Italia, avrà sicuramente notato quanto il ministro dell’Interno abbia evitato di assumersi tutti o i maggiori meriti dell’operazione. Lo ha evitato resistendo anche ai tentativi un po’ melliflui del conduttore di compiacere la sua vanità personale e politica, fra un sorriso e un’allusione, non foss’altro per ricambiargli il favore professionale ricevuto con quella nuova e puntuale presenza nella sua “non arena”. Che è poi un nome destinato ad ampliarla, in riferimento alle precedenti e interrotte edizioni alla Rai.  occasioni di sofferenza per il ruolo preponderante che egli ha svolto concretamente e mediaticamente nel governo dal momento della sua formazione: una sofferenza che ogni tanto esplode con proteste o vere e proprie ritorsioni politiche. Fra le quali può essere annoverato anche l’intervento a gamba più o meno tesa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del vice presidente Luigi Di Maio, entrambi grillini appunto, nella vicenda dei 49 profughi rimasti per una ventina di giorni bloccati davanti all’isola di Malta, e alla fine accollatisi pure dall’Italia, mentre Salvini protestava da Varsavia. Dove peraltro egli era in missione più di partito che di governo, non ben digerita -credo- dal ministro degli Esteri.
occasioni di sofferenza per il ruolo preponderante che egli ha svolto concretamente e mediaticamente nel governo dal momento della sua formazione: una sofferenza che ogni tanto esplode con proteste o vere e proprie ritorsioni politiche. Fra le quali può essere annoverato anche l’intervento a gamba più o meno tesa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del vice presidente Luigi Di Maio, entrambi grillini appunto, nella vicenda dei 49 profughi rimasti per una ventina di giorni bloccati davanti all’isola di Malta, e alla fine accollatisi pure dall’Italia, mentre Salvini protestava da Varsavia. Dove peraltro egli era in missione più di partito che di governo, non ben digerita -credo- dal ministro degli Esteri. ugualmente una sua rilevanza pratica, e non solo mediatica, ai fini del trattamento penitenziario di cui potrà beneficiare il terrorista per tanto tempo, e con tanta spavalderia, sottrattosi alla giustizia del suo Paese.
ugualmente una sua rilevanza pratica, e non solo mediatica, ai fini del trattamento penitenziario di cui potrà beneficiare il terrorista per tanto tempo, e con tanta spavalderia, sottrattosi alla giustizia del suo Paese.  la maggiore forza conseguita col caso Battisti nelle sostanziali vertenze che ha con i grillini all’interno del governo. Dove “qualche lite c’è”, ha appena ammesso in una intervista il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, né grillino né leghista, pur cercando di delimitare i contrasti al tema dell’immigrazione e attribuendone la colpa alle carenze di solidarietà, chiarezza, determinazione e quant’altro dell’Unione Europea.
la maggiore forza conseguita col caso Battisti nelle sostanziali vertenze che ha con i grillini all’interno del governo. Dove “qualche lite c’è”, ha appena ammesso in una intervista il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, né grillino né leghista, pur cercando di delimitare i contrasti al tema dell’immigrazione e attribuendone la colpa alle carenze di solidarietà, chiarezza, determinazione e quant’altro dell’Unione Europea.  anticipato alla pensione, o di quelle nuove sulla legittima difesa, o della linea di alta velocità ferroviaria per le merci da Lione a Torino: la famosa Tav, preferita ormai dal dibattito pubblico nel genere femminile rispetto a quello maschile reclamato, forse con maggiore rigore tecnico, dagli specialisti del Ministero delle Infrastrutture, e del Fatto Quotidiano.
anticipato alla pensione, o di quelle nuove sulla legittima difesa, o della linea di alta velocità ferroviaria per le merci da Lione a Torino: la famosa Tav, preferita ormai dal dibattito pubblico nel genere femminile rispetto a quello maschile reclamato, forse con maggiore rigore tecnico, dagli specialisti del Ministero delle Infrastrutture, e del Fatto Quotidiano. e stazioni, in grado di far ricalcolare in modo salvifico il rapporto fra costi e benefici calcolato da una commissione di cui lo stesso ministro grillino delle Infrastrutture, notoriamente contrario all’opera, non ha sinora ritenuto opportuno ufficializzare il risultato.
e stazioni, in grado di far ricalcolare in modo salvifico il rapporto fra costi e benefici calcolato da una commissione di cui lo stesso ministro grillino delle Infrastrutture, notoriamente contrario all’opera, non ha sinora ritenuto opportuno ufficializzare il risultato. 

 riempita spontaneamente, al richiamo di sole sette “madamine”, di trentamila manifestanti a favore della Tav: la linea ferroviaria di alta velocità per le merci progettata fra Lione e Torino, e notoriamente osteggiata dai grillini. Il cui arrivo al vertice dell’amministrazione comunale torinese non li ha evidentemente aiutati a mettersi in sintonia con la città, ma anche col resto del nord, su un tema che va ben oltre la Tav. O il Tav, come preferiscono chiamarlo nella redazione del protogrillino Fatto Quotidiano, dove peraltro si sono consolati fotograficamente ricordando che un’analoga manifestazione aveva raccolto
riempita spontaneamente, al richiamo di sole sette “madamine”, di trentamila manifestanti a favore della Tav: la linea ferroviaria di alta velocità per le merci progettata fra Lione e Torino, e notoriamente osteggiata dai grillini. Il cui arrivo al vertice dell’amministrazione comunale torinese non li ha evidentemente aiutati a mettersi in sintonia con la città, ma anche col resto del nord, su un tema che va ben oltre la Tav. O il Tav, come preferiscono chiamarlo nella redazione del protogrillino Fatto Quotidiano, dove peraltro si sono consolati fotograficamente ricordando che un’analoga manifestazione aveva raccolto  nello stesso posto due mesi fa settantamila persone, ma dimenticando il diverso e più affrettato contesto dei due avvenimenti. In ogni caso, fare spallucce a trentamila manifestanti, tanto convinti delle loro idee da non avere bisogno di sfasciare vetrine o altro per cercare di imporle, è cosa di per sé esplicativa dei limiti della polemica del giornale di Marco Travaglio.
nello stesso posto due mesi fa settantamila persone, ma dimenticando il diverso e più affrettato contesto dei due avvenimenti. In ogni caso, fare spallucce a trentamila manifestanti, tanto convinti delle loro idee da non avere bisogno di sfasciare vetrine o altro per cercare di imporle, è cosa di per sé esplicativa dei limiti della polemica del giornale di Marco Travaglio. di un’opera. E’ in gioco la modernizzazione del nord e, più in generale, dell’Italia già minacciata dalla recessione. E’ in gioco la logica della “decrescita felice” che i grillini si sono sempre vantati di coltivare, preferendola ad una crescita a rischio di una concezione fideistica dell’onestà, che peraltro ogni tanto si scopre che essi violano a casa loro.
di un’opera. E’ in gioco la modernizzazione del nord e, più in generale, dell’Italia già minacciata dalla recessione. E’ in gioco la logica della “decrescita felice” che i grillini si sono sempre vantati di coltivare, preferendola ad una crescita a rischio di una concezione fideistica dell’onestà, che peraltro ogni tanto si scopre che essi violano a casa loro.  il quale Salvini si è già prenotato a partecipare votando sì alla Tav, o al Tav, difficilmente potrà concludersi con un compromesso. Sarà un sì, probabilissimo, o un no improbabile. L’unico modo per scamparvi sarebbe quello di impedire la consultazione, appunto, del popolo: cosa che stranamente ha auspicato l’imprevedibile Matteo Renzi rivendicando la primazia del Parlamento per decisioni di questo tipo. Ci mancava, nel repertorio dell’ex segretario del Pd, solo questo: un Renzi d’accordo con i grillini, anche se al solo o prevalente scopo di vedere scoppiare l’attuale maggioranza spuria di governo non in piazza, com’è appunto avvenuto a Torino, dove i leghisti si sono uniti ai manifestanti, ma nel Parlamento, più in particolare -magari- nell’aula del Senato, dove lui rappresenta la “sua” Firenze appena raccontata in televisione.
il quale Salvini si è già prenotato a partecipare votando sì alla Tav, o al Tav, difficilmente potrà concludersi con un compromesso. Sarà un sì, probabilissimo, o un no improbabile. L’unico modo per scamparvi sarebbe quello di impedire la consultazione, appunto, del popolo: cosa che stranamente ha auspicato l’imprevedibile Matteo Renzi rivendicando la primazia del Parlamento per decisioni di questo tipo. Ci mancava, nel repertorio dell’ex segretario del Pd, solo questo: un Renzi d’accordo con i grillini, anche se al solo o prevalente scopo di vedere scoppiare l’attuale maggioranza spuria di governo non in piazza, com’è appunto avvenuto a Torino, dove i leghisti si sono uniti ai manifestanti, ma nel Parlamento, più in particolare -magari- nell’aula del Senato, dove lui rappresenta la “sua” Firenze appena raccontata in televisione. un paragone che potrebbe sembrare a prima vista eccessivo, il “vento del nord” esaltato da Pietro Nenni sull’Avanti! del 27 aprile 1945: un vento che completò la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascita avviando l’intero Paese verso la Repubblica, cui si approdò col referendum dell’anno successivo, e una nuova Costituzione.
un paragone che potrebbe sembrare a prima vista eccessivo, il “vento del nord” esaltato da Pietro Nenni sull’Avanti! del 27 aprile 1945: un vento che completò la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascita avviando l’intero Paese verso la Repubblica, cui si approdò col referendum dell’anno successivo, e una nuova Costituzione. 
 con tanto di bandiere e di striscione ottimistico steso alle spalle degli oratori, e l’impietoso annuncio ufficiale del calo della produzione industriale italiana del 2,6 per cento in un anno, tra novembre 2017 e novembre 2018, con un picco peraltro del 19 per cento nel settore dell’auto. Che è lo stesso disgraziatamente colpito nella manovra fiscale di fine anno dai grillini, fra le deboli resistenze dei leghisti, con una sovrattassa studiata per agevolare il futuro -si potrebbe dire- della motorizzazione elettrica, ma destinata intanto a colpire il presente e più diffuso commercio della motorizzazione a benzina o nafta.
con tanto di bandiere e di striscione ottimistico steso alle spalle degli oratori, e l’impietoso annuncio ufficiale del calo della produzione industriale italiana del 2,6 per cento in un anno, tra novembre 2017 e novembre 2018, con un picco peraltro del 19 per cento nel settore dell’auto. Che è lo stesso disgraziatamente colpito nella manovra fiscale di fine anno dai grillini, fra le deboli resistenze dei leghisti, con una sovrattassa studiata per agevolare il futuro -si potrebbe dire- della motorizzazione elettrica, ma destinata intanto a colpire il presente e più diffuso commercio della motorizzazione a benzina o nafta.  stesso “Dibba” ha appena ripetuto al canale televisivo 9, si è spinto a immaginare a breve addirittura un nuovo “boom economico” tipo anni Sessanta, quando le autostrade, con viadotti annessi e
stesso “Dibba” ha appena ripetuto al canale televisivo 9, si è spinto a immaginare a breve addirittura un nuovo “boom economico” tipo anni Sessanta, quando le autostrade, con viadotti annessi e  connessi, diedero una forte spinta allo sviluppo del Paese. Le autostrade di Di Maio però avrebbero meno rischi e costi. E quali potrebbero essere? Ma è chiaro: quelle “digitali”, ha chiarito il volatile “Giggino”, come lo ha sfottuto il manifesto in prima pagina commentandone la sortita.
connessi, diedero una forte spinta allo sviluppo del Paese. Le autostrade di Di Maio però avrebbero meno rischi e costi. E quali potrebbero essere? Ma è chiaro: quelle “digitali”, ha chiarito il volatile “Giggino”, come lo ha sfottuto il manifesto in prima pagina commentandone la sortita. Sulle autostrade digitali dell’ancòra capo del movimento grillino viaggia notoriamente, sulle orme del padre, Davide Casaleggio: un redivivo Jean-Jacques Rousseau. Che prima o dopo dovrà soddisfare però la curiosità di quell’impiccione di Francesco Tullio Altan, smanioso di conoscere e rivelare ai lettori della sua Repubblica di carta il rapporto fra costi e benefici del governo in carica, e non solo della o del Tav.
Sulle autostrade digitali dell’ancòra capo del movimento grillino viaggia notoriamente, sulle orme del padre, Davide Casaleggio: un redivivo Jean-Jacques Rousseau. Che prima o dopo dovrà soddisfare però la curiosità di quell’impiccione di Francesco Tullio Altan, smanioso di conoscere e rivelare ai lettori della sua Repubblica di carta il rapporto fra costi e benefici del governo in carica, e non solo della o del Tav.
 a sorpresa ai vaccini procurando le vertigini ai suoi, educati quanto meno allo scetticismo sulla materia- non ha investito solo il Quirinale. Dove il presidente della Repubblica ha interrotto la sua riflessione critica e preoccupata sulla legge contro la corruzione, ma anche contro la prescrizione, e a dispetto pure dei dubbi espressi dal Consiglio Superiore della Magistratura l’ha firmata per non provocare altre tensioni nella coalizione di governo. La paura di una crisi ha investito pure il palazzo adiacente al Quirinale: quello della Consulta, dove siedono, studiano e deliberano i giudici della Corte Costituzionale.
a sorpresa ai vaccini procurando le vertigini ai suoi, educati quanto meno allo scetticismo sulla materia- non ha investito solo il Quirinale. Dove il presidente della Repubblica ha interrotto la sua riflessione critica e preoccupata sulla legge contro la corruzione, ma anche contro la prescrizione, e a dispetto pure dei dubbi espressi dal Consiglio Superiore della Magistratura l’ha firmata per non provocare altre tensioni nella coalizione di governo. La paura di una crisi ha investito pure il palazzo adiacente al Quirinale: quello della Consulta, dove siedono, studiano e deliberano i giudici della Corte Costituzionale.  e maggioranza parlamentare di turno- a non riprovarci più, e tanto meno a ricorrere a forzature più vistose ancora. “Simili modalità decisionali dovranno essere abbandonate”, ha avvertito il comunicato della Corte alludendo allo scavalcamento completo della commissione parlamentare competente, avvenuto a Palazzo Madama e tradottosi in aula in una mezza rivolta di senatori contro i banchi del governo e della presidenza dell’assemblea, con fogli che svolazzavano da ogni parte, e al sostanziale bavaglio imposto dal solito ricorso al voto di fiducia sull’altrettanto solito maxi-emendamento di centinaia di pagine e migliaia di commi per spazzare via singole proposte di modifica e dibattito.
e maggioranza parlamentare di turno- a non riprovarci più, e tanto meno a ricorrere a forzature più vistose ancora. “Simili modalità decisionali dovranno essere abbandonate”, ha avvertito il comunicato della Corte alludendo allo scavalcamento completo della commissione parlamentare competente, avvenuto a Palazzo Madama e tradottosi in aula in una mezza rivolta di senatori contro i banchi del governo e della presidenza dell’assemblea, con fogli che svolazzavano da ogni parte, e al sostanziale bavaglio imposto dal solito ricorso al voto di fiducia sull’altrettanto solito maxi-emendamento di centinaia di pagine e migliaia di commi per spazzare via singole proposte di modifica e dibattito. anche formalmente. Ma non è detto che il puntellamento ad ogni costo sia il rimedio migliore. I ponti maltenuti prima o dopo crollano, come si è visto a metà agosto a Genova. Dove peraltro l’emergenza nuova si chiama Carige, l’acronimo della Cassa di Risparmio locale, si fa per dire. E la maggioranza la sta affrontando fra le solite divisioni, recriminazioni e quant’altro, più per fare campagna elettorale, al suo interno e all’esterno, che per risolvere davvero il problema.
anche formalmente. Ma non è detto che il puntellamento ad ogni costo sia il rimedio migliore. I ponti maltenuti prima o dopo crollano, come si è visto a metà agosto a Genova. Dove peraltro l’emergenza nuova si chiama Carige, l’acronimo della Cassa di Risparmio locale, si fa per dire. E la maggioranza la sta affrontando fra le solite divisioni, recriminazioni e quant’altro, più per fare campagna elettorale, al suo interno e all’esterno, che per risolvere davvero il problema. 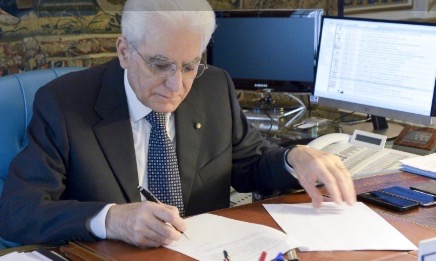


 natura in cantiere a Palazzo Chigi e dintorni, comprese le aule e le commissioni parlamentari. Infine, costretto al solito vertice, il presidente del Consiglio ha trovato il modo di disinnescare l’ennesima mina copiando paradossalmente proprio Salvini, che nella scorsa estate era uscito dal blocco imposto nel porto di Catania a un pattugliatore italiano carico di profughi soccorsi in mare trattandone la consegna di buona parte alla Chiesa di Papa Francesco.
natura in cantiere a Palazzo Chigi e dintorni, comprese le aule e le commissioni parlamentari. Infine, costretto al solito vertice, il presidente del Consiglio ha trovato il modo di disinnescare l’ennesima mina copiando paradossalmente proprio Salvini, che nella scorsa estate era uscito dal blocco imposto nel porto di Catania a un pattugliatore italiano carico di profughi soccorsi in mare trattandone la consegna di buona parte alla Chiesa di Papa Francesco. Che a sue spese -è stato precisato per dare a Salvini il motivo di considerarsi soddisfatto- si è accollata l’accoglienza di tutta o parte della quota di 15 immigrati assegnata all’Italia in una trattativa a otto svoltasi a livello europeo. Dove si dovrà però trovare adesso anche un accordo per la ripartizione di circa 240 profughi accolti nei mesi scorsi da Malta e di altre centinaia accolti invece dall’Italia e rimastivi, in attesa dell’accoglienza alla quale si erano impegnati alcuni paesi dell’Unione Europea.
Che a sue spese -è stato precisato per dare a Salvini il motivo di considerarsi soddisfatto- si è accollata l’accoglienza di tutta o parte della quota di 15 immigrati assegnata all’Italia in una trattativa a otto svoltasi a livello europeo. Dove si dovrà però trovare adesso anche un accordo per la ripartizione di circa 240 profughi accolti nei mesi scorsi da Malta e di altre centinaia accolti invece dall’Italia e rimastivi, in attesa dell’accoglienza alla quale si erano impegnati alcuni paesi dell’Unione Europea.  come tante altre – dal reddito di cittadinanza alla pensione anticipata, dalla Tav al salvataggio della Cassa di Risparmio di Genova- destinate ad una sostanziale dissolvenza, in attesa solo di conoscere gli effetti che potranno derivarne soprattutto nelle elezioni di maggio per il rinnovo del Parlamento Europeo. Dei cui risultati si vedrà che uso vorranno fare le componenti dell’attuale maggioranza. Esse non sono più due, come alla formazione del governo Conte, perché quella grillina si è andata via via scomponendo di fatto in tendenze, aree, correnti e quant’altro la cui convivenza dipenderà anch’essa dai risultati delle elezioni europee di maggio, o da quelle regionali che le precederanno già dal mese prossimo.
come tante altre – dal reddito di cittadinanza alla pensione anticipata, dalla Tav al salvataggio della Cassa di Risparmio di Genova- destinate ad una sostanziale dissolvenza, in attesa solo di conoscere gli effetti che potranno derivarne soprattutto nelle elezioni di maggio per il rinnovo del Parlamento Europeo. Dei cui risultati si vedrà che uso vorranno fare le componenti dell’attuale maggioranza. Esse non sono più due, come alla formazione del governo Conte, perché quella grillina si è andata via via scomponendo di fatto in tendenze, aree, correnti e quant’altro la cui convivenza dipenderà anch’essa dai risultati delle elezioni europee di maggio, o da quelle regionali che le precederanno già dal mese prossimo.