In verità, non lo ha mai chiamato per nome in un’intervista appena concessa al Corriere della Sera, ma penso che Matteo Salvini abbia in testa anche lui per il futuro del suo movimento quel “partito liberale di massa” immaginato da Silvio Berlusconi per la sua Forza Italia, ed esplicitato per primo dal professore
da Silvio Berlusconi per la sua Forza Italia, ed esplicitato per primo dal professore  Giuliano Urbani. Dal quale il Cavaliere di Arcore si lasciò consigliare con altri professori come Antonio Martino e Carlo Scognamiglio Pasini, cui altri poi si sarebbero aggiunti, da Marcello Pera a Lucio Colletti, da Saverio Vertone a Piero Melograni, preparando la sua “discesa in campo” politico, mentre la cosiddetta prima Repubblica tirava le cuoia nelle astanterie giudiziarie.
Giuliano Urbani. Dal quale il Cavaliere di Arcore si lasciò consigliare con altri professori come Antonio Martino e Carlo Scognamiglio Pasini, cui altri poi si sarebbero aggiunti, da Marcello Pera a Lucio Colletti, da Saverio Vertone a Piero Melograni, preparando la sua “discesa in campo” politico, mentre la cosiddetta prima Repubblica tirava le cuoia nelle astanterie giudiziarie.
Richiesto se l’ex presidente del Senato Marcello Pera, da tempo staccatosi da Forza Italia, sia pure con quel misto di garbo e franchezza che lo distingue, sia già diventato suo “consigliere”, il leader leghista ha risposto: “L’ho incontrato più volte insieme ad altre teste pensanti. Abbiamo bisogno di cervelli per ragionare sul futuro, come fece a suo tempo Berlusconi. Le idee di Pera sono stimolanti”.
Una delle idee di Pera -lo posso testimoniare per averne raccolto qualche volta gli sfoghi- è che Berlusconi abbia mancato l’obiettivo della “rivoluzione liberale” che si era proposto. E che Salvini, nonostante le delusioni procurategli dall’ultimo turno  delle elezioni regionali e soprattutto comunali, non solo al Sud ma anche nella “sua” Lombardia, o proprio a causa di queste delusioni, sembra deciso a proporsi. Il Corriere glielo ha messo in bocca con tanto di virgolette giuste nei titoli dell’intervista seguita ad una “bella chiacchierata” avuta nel suo ufficio al Senato con l’ex sottosegretario alla Presidenza e attuale responsabile dell’ufficio esteri del partito Giancarlo Giorgetti. Di questo incontro è stato riferito da molti giornali con diverse interpretazioni, fra il chiarimento, la tregua e una persistente divergenza di vedute anche o soprattutto sui rapporti della Lega con gli altri partiti europei.
delle elezioni regionali e soprattutto comunali, non solo al Sud ma anche nella “sua” Lombardia, o proprio a causa di queste delusioni, sembra deciso a proporsi. Il Corriere glielo ha messo in bocca con tanto di virgolette giuste nei titoli dell’intervista seguita ad una “bella chiacchierata” avuta nel suo ufficio al Senato con l’ex sottosegretario alla Presidenza e attuale responsabile dell’ufficio esteri del partito Giancarlo Giorgetti. Di questo incontro è stato riferito da molti giornali con diverse interpretazioni, fra il chiarimento, la tregua e una persistente divergenza di vedute anche o soprattutto sui rapporti della Lega con gli altri partiti europei.
“Condivido -ha detto testualmente Salvini- l’idea della necessità di una rivoluzione liberale. Abbiamo bisogno di liberare energie, di sfruttare le potenzialità degli italiani. Sto lavorando anche con Forza Italia”, dove tuttavia molti più che amarlo lo temono. E non gli perdonano di avere elettoralmente sorpassato il partito del Cavaliere strappandogli la “trazione” del centrodestra. Essi non riescono neppure a consolarsi per la concorrenza che, sempre all’interno della coalizione gli sta facendo Giorgia Meloni con i suoi Fratelli d’Italia. Nemmeno la Meloni gode di molta popolarità fra i berlusconiani, che non più tardi di quattro anni fa nelle elezioni comunali di Roma ne contrastarono la candidatura a sindaco, preferendole Alfio Marchini eliminato al primo turno. Nel ballottaggio, per ritorsione sospettando che Berlusconi sotto sotto sperasse nel successo del radicale e piddino Roberto Giachetti, meloniani e un po’ anche leghisti votarono per la grillina Virginia Raggi, aiutandola a conquistare il Campidoglio. Sembra fantascienza, è invece cronaca un po’ stagionata.
Forza Italia”, dove tuttavia molti più che amarlo lo temono. E non gli perdonano di avere elettoralmente sorpassato il partito del Cavaliere strappandogli la “trazione” del centrodestra. Essi non riescono neppure a consolarsi per la concorrenza che, sempre all’interno della coalizione gli sta facendo Giorgia Meloni con i suoi Fratelli d’Italia. Nemmeno la Meloni gode di molta popolarità fra i berlusconiani, che non più tardi di quattro anni fa nelle elezioni comunali di Roma ne contrastarono la candidatura a sindaco, preferendole Alfio Marchini eliminato al primo turno. Nel ballottaggio, per ritorsione sospettando che Berlusconi sotto sotto sperasse nel successo del radicale e piddino Roberto Giachetti, meloniani e un po’ anche leghisti votarono per la grillina Virginia Raggi, aiutandola a conquistare il Campidoglio. Sembra fantascienza, è invece cronaca un po’ stagionata.
Ma torniamo a Salvini e alla staffetta della rivoluzione liberale ch’egli vorrebbe un po’ raccogliere e un po’ strappare al politicamente esangue Berlusconi, riconoscendogli il merito di averla comunque progettata prima di lui. A completamento dell’impressione che in fondo alle riflessioni di Salvini ci sia quel partito liberale di massa anch’esso mancato a Forza Italia c’è il proposito da lui dichiarato, come “punto di partenza” del suo aggiornamento politico, di “allargare i confini del nostro perimetro coinvolgendo imprenditori e professionisti”, come “il capitano” ritiene di essere riuscito a fare nelle Marche diventando il primo partito e strappando la regione al Pd, ma con un candidato dei Fratelli d’Italia -va ricordato- alla presidenza.
aggiornamento politico, di “allargare i confini del nostro perimetro coinvolgendo imprenditori e professionisti”, come “il capitano” ritiene di essere riuscito a fare nelle Marche diventando il primo partito e strappando la regione al Pd, ma con un candidato dei Fratelli d’Italia -va ricordato- alla presidenza.
Bel progetto, bel proposito quello di un partito liberale di massa, non c’è che dire. Nella storia della Repubblica, lasciando quindi perdere i lontanissimi e irripetibili tempi di Giovanni Giolitti, non riuscì neppure a sfiorare le masse quel mastino di Giovanni Malagodi. Che al massimo, cavalcando  la paura della destra liberale per la scelta democristiana del centro-sinistra sotto la guida di Aldo Moro, riuscì nelle elezioni politiche del 1963 a portare il Pli dal 3,82 per cento conquistato nel 1948 da Luigi Einaudi, prima di diventare presidente della Repubblica, al 6,97 per cento alla Camera e 7,52 al Senato.
la paura della destra liberale per la scelta democristiana del centro-sinistra sotto la guida di Aldo Moro, riuscì nelle elezioni politiche del 1963 a portare il Pli dal 3,82 per cento conquistato nel 1948 da Luigi Einaudi, prima di diventare presidente della Repubblica, al 6,97 per cento alla Camera e 7,52 al Senato.
Cinque anni dopo, nel 1968, con Moro che aveva saputo abituare gli italiani al centro-sinistra, o rasserenarli, il Pli malagodiano scese al 5,82 per cento e nel 1972 al 3,89, come nel 1948. Qualche anno dopo, quando Indro Montanelli invitò a votare Dc “turandosi il naso”, pur di non farla sorpassare dal Pci di Enrico Berlinguer, i liberali arrivarono a percentuali da prefisso telefonico, o quasi.
Curiosamemente più è cresciuta la sensazione di essere liberali, per la forza evidentemente del seme liberale, appunto, più si è spento il partito che ne portava il nome. E’ un po’ quello che è accaduto ai socialisti a sinistra, dove tutti si sentono e si dichiarano socialisti, appunto, ma ricorrono ad ogni nome fuorché al socialismo per chiamare i partiti succedutisi alla caduta del comunismo, che ne fu il tradimento e la disgrazia.
I vedovi politici, diciamo così, del liberalismo e del socialismo possono consolarsi vedendo, anzi ammirando l’abbondanza che si fa sul piano culturale del liberalsocialismo predicato nel secolo scorso da Carlo Rosselli, fatto ammazzare dai fascisti in Francia nel 1937.
Vorrei tuttavia passare dal piano culturale e politico a quello più pratico per osservare, a proposito della strada scelta o indicata da Salvini per cercare di trasformare la sua Lega in un partito liberale di massa con l’aiuto dei professori, che i politici di solito su questo terreno toppano rovinosamente. E finiscono per far diventare la creatura che immaginano, o cui contano di approdare, quell’araba fenice di Metastasio: “che ci sia, ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa”. Lo si può dire anche del fantomatico partito di centro, attorno al quale sono in tanti a lavorare e giocare in ogni stagione politica, soprattutto quando non hanno i numeri elettorali e parlamentari per essere davvero e stabilmente al centro, e non solo di centro.
Purtroppo politici riescono difficilmente a stare al passo con i professori. A volte persino il professore che diventa o fa il politico – e ce ne sono stati di importantissimi, già prima di Giuseppe Conte- finisce per dissociarsi, rinunciando o all’una o all’altra delle sue vocazioni. Pure il politico più disponibile, pronto -come ha più volte detto, per esempio, Berlusconi- a farsi convesso o concavo secondo le circostanze e le opportunità, abbandona o è abbandonato dal professore adottato come ispiratore.
Temo che il professore Pera sia destinato a rimanere deluso da Salvini non meno di quanto lo sia stato da Berlusconi. E propendo personalmente a dare in questi tipi di delusione o sconfitta più colpa al politico che al professore.
So di certo – l’interessato può smentirlo, se vuole o lo ritiene opportuno- che il buon Giuliano Urbani con la sua idea del partito liberale  di massa, dell’associazione del buon governo ed altro ancora, fu indirizzato a Berlusconi negli anni Novanta da Gianni Agnelli. Che rimase affascinato dalle sue idee ma non aveva alcuna intenzione di cambiare mestiere e di scendere o salire in politica, forse contento di condizionarla standone a distanza.
di massa, dell’associazione del buon governo ed altro ancora, fu indirizzato a Berlusconi negli anni Novanta da Gianni Agnelli. Che rimase affascinato dalle sue idee ma non aveva alcuna intenzione di cambiare mestiere e di scendere o salire in politica, forse contento di condizionarla standone a distanza.
Per quanto portato anche al governo dal Cavaliere, il professore Urbani alla fine ha buttato la spugna. Non migliore è stata la convivenza politica di altri professori con Berlusconi, come i già citati ma compianti Colletti, Vertone e Melograni: tutti, in verità, staccatisi senza fare scenate.
Ho particolare ammirazione personale e culturale per il professore Antonio Martino, un liberale a 24 carati come il padre Gaetano. Oltre che co-fondatore di Forza Italia, egli è stato ministro degli Esteri e della Difesa nei governi di Berlusconi, ma  pure lui, senza mai profferire critiche e tanto meno attacchi, è andato via via appartandosi, sino a rinunciare volontariamente ad una rielezione alla Camera, non so se più pago o stanco dei 24 anni di deputato, dal 1994 al 2018. Una volta, con la confidenza e la franchezza che solo lui poteva permettersi, scrisse un biglietto al Cavaliere per lamentarsi del fatto ch’egli frequentasse “donne con molto seno e poco senno”.
pure lui, senza mai profferire critiche e tanto meno attacchi, è andato via via appartandosi, sino a rinunciare volontariamente ad una rielezione alla Camera, non so se più pago o stanco dei 24 anni di deputato, dal 1994 al 2018. Una volta, con la confidenza e la franchezza che solo lui poteva permettersi, scrisse un biglietto al Cavaliere per lamentarsi del fatto ch’egli frequentasse “donne con molto seno e poco senno”.
Eh, i professori sono spesso molto più esigenti e tosti di quanto non pensino i politici che se ne lasciano affiancare, o li cercano. Ricordo ancora le delusioni procurate dall’Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini al professore Domenico Fisichella, che pure gli aveva dato una mano -e che mano- nella evoluzione della destra missina: importante sul piano culturale quanto il cosiddetto e conseguente sdoganamento politico effettuato da Berlusconi.
Pubblicato sul Dubbio
Ripreso da www.startmag.it l’11-10-2020
 con lo storico esponente liberale ucciso a bastonate dai fascisti, mi ha colpito il modo in cui al Foglio di Giuliano Ferrara e Claudio Cerasa hanno contrapposto alcune sue parole alla svolta annunciata, adombrata, propostasi -come preferite- da Matteo Salvini. Che, forte dei consigli già ricevuti da Marcello Pera, tentato dalla scommessa sull’evoluzione della Lega dopo le delusioni procurategli da Forza Italia, ha condiviso “la necessità di una rivoluzione liberale”.
con lo storico esponente liberale ucciso a bastonate dai fascisti, mi ha colpito il modo in cui al Foglio di Giuliano Ferrara e Claudio Cerasa hanno contrapposto alcune sue parole alla svolta annunciata, adombrata, propostasi -come preferite- da Matteo Salvini. Che, forte dei consigli già ricevuti da Marcello Pera, tentato dalla scommessa sull’evoluzione della Lega dopo le delusioni procurategli da Forza Italia, ha condiviso “la necessità di una rivoluzione liberale”. aggravata dalla pandemia virale. Ebbene, anche se nell’articolo non si trovano parole di Amendola specificamente
aggravata dalla pandemia virale. Ebbene, anche se nell’articolo non si trovano parole di Amendola specificamente riferite alle posizioni neo-liberali di Salvini e del suo partito, l’auspicio del ministro per ampie convergenze parlamentari sul documento predisposto dal governo è stato contrapposto dal Foglio ad “una nota critica sul Revocery fund” diffusa il 7 ottobre dal gruppo leghista del Parlamento Europeo. Nelle cui “conclusioni” si sostiene che “ci sarà grazie al Recovery un vincolo esterno smile alla Troika per modalità ricattatorie (ti concedo di spendere i tuoi soldi e forse una mancia se fai quello che ti dico io)”.
riferite alle posizioni neo-liberali di Salvini e del suo partito, l’auspicio del ministro per ampie convergenze parlamentari sul documento predisposto dal governo è stato contrapposto dal Foglio ad “una nota critica sul Revocery fund” diffusa il 7 ottobre dal gruppo leghista del Parlamento Europeo. Nelle cui “conclusioni” si sostiene che “ci sarà grazie al Recovery un vincolo esterno smile alla Troika per modalità ricattatorie (ti concedo di spendere i tuoi soldi e forse una mancia se fai quello che ti dico io)”.![]() del Carroccio, di “rivoluzione liberale” e di nuovo approccio leghista
del Carroccio, di “rivoluzione liberale” e di nuovo approccio leghista  all’Europa sarà difficile continuare a parlare con una certa credibilità. Più che a Pera, o al governatore della Banca d’Italia appena espostosi sul Corriere della Sera con un invito a tutti a “cambiare passo”, Salvini rischia di apparire sensibile alla filosofia dell’amico sovranista Paolo Del Debbio. Che sulla Verità ha dato del “matto” a chi “spera nei soldi europei”.
all’Europa sarà difficile continuare a parlare con una certa credibilità. Più che a Pera, o al governatore della Banca d’Italia appena espostosi sul Corriere della Sera con un invito a tutti a “cambiare passo”, Salvini rischia di apparire sensibile alla filosofia dell’amico sovranista Paolo Del Debbio. Che sulla Verità ha dato del “matto” a chi “spera nei soldi europei”.

 a Luca Palamara in una decina di udienze, radiandolo alla fine dall’ordine giudiziario per il traffico di nomine, chiamiamolo così, fatto in veste di sindacalista e di consigliere dello stesso Csm. O, più figurativamente, denudandolo della toga, come lo ha rappresentato Emilio Giannelli nella vignetta di prima pagina del Corriere della Sera.
a Luca Palamara in una decina di udienze, radiandolo alla fine dall’ordine giudiziario per il traffico di nomine, chiamiamolo così, fatto in veste di sindacalista e di consigliere dello stesso Csm. O, più figurativamente, denudandolo della toga, come lo ha rappresentato Emilio Giannelli nella vignetta di prima pagina del Corriere della Sera. di stalinista il processo avrebbe avuto lo stampo se l’imputato, come appunto avveniva nell’Unione Sovietica ai tempi dello spietato dittatore, si fosse dichiarato colpevole assumendosi per intero le responsabilità e facendo quindi il gioco dell’accusa, nella speranza della clemenza per sé, familiari, compagni e quant’altri. E’ ciò che si è rifiutato di fare Palamara, propostosi anzi di ricorrere contro la radiazione in ogni sede, italiana ed europea, e di svolgere azione politica, e moralizzatrice della magistratura, nelle file del Partito Radicale.
di stalinista il processo avrebbe avuto lo stampo se l’imputato, come appunto avveniva nell’Unione Sovietica ai tempi dello spietato dittatore, si fosse dichiarato colpevole assumendosi per intero le responsabilità e facendo quindi il gioco dell’accusa, nella speranza della clemenza per sé, familiari, compagni e quant’altri. E’ ciò che si è rifiutato di fare Palamara, propostosi anzi di ricorrere contro la radiazione in ogni sede, italiana ed europea, e di svolgere azione politica, e moralizzatrice della magistratura, nelle file del Partito Radicale.  consiglieri superiori della magistratura che hanno processato Palamara e deciso la sua radiazione in due ore e mezza di camera di consiglio. Li ha paragonati alla Corte Marziale nazista convocata in tutta fretta nel 1944 dal generale Friedrich Fromm per far condannare e fucilare i due ufficiali autori del fallito attentato ad Hitler. Dei cui preparativi lo stesso Fromm era quanto meno al corrente, cioè complice. E ne pagò le conseguenze venendo poi fucilato pure lui, come a quel punto era giusto, e non solo naturale, che accadesse.
consiglieri superiori della magistratura che hanno processato Palamara e deciso la sua radiazione in due ore e mezza di camera di consiglio. Li ha paragonati alla Corte Marziale nazista convocata in tutta fretta nel 1944 dal generale Friedrich Fromm per far condannare e fucilare i due ufficiali autori del fallito attentato ad Hitler. Dei cui preparativi lo stesso Fromm era quanto meno al corrente, cioè complice. E ne pagò le conseguenze venendo poi fucilato pure lui, come a quel punto era giusto, e non solo naturale, che accadesse. 
 scissione accesa, volente o nolente, dalla coppia Davide Casaleggio-Alessandro Di Battista. Che si è formata, tra interviste e messaggi elettronici, contro la trasformazione poltronistica, diciamo così, dei grillini intenzionati a continuare ad ogni costo l’alleanza col Pd, estendendola a livello locale. E smaniosi di liberarsi dal limite statutario dei due mandati parlamentari, dopo i quali essi dovrebbero tornare a casa per lasciare il posto ad altri, in un continuo ricambio che sarebbe la garanzia contro il professionismo politico alimentato dai partiti tradizionali.
scissione accesa, volente o nolente, dalla coppia Davide Casaleggio-Alessandro Di Battista. Che si è formata, tra interviste e messaggi elettronici, contro la trasformazione poltronistica, diciamo così, dei grillini intenzionati a continuare ad ogni costo l’alleanza col Pd, estendendola a livello locale. E smaniosi di liberarsi dal limite statutario dei due mandati parlamentari, dopo i quali essi dovrebbero tornare a casa per lasciare il posto ad altri, in un continuo ricambio che sarebbe la garanzia contro il professionismo politico alimentato dai partiti tradizionali.  maggioranza di governo, oltre che al suo movimento, per riconoscere al nuovo presidente della Confindustria Carlo Bonomi ciò che gli contesta invece sotto voce il presidente del Consiglio
maggioranza di governo, oltre che al suo movimento, per riconoscere al nuovo presidente della Confindustria Carlo Bonomi ciò che gli contesta invece sotto voce il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e a voce altissima il giornale che più raccoglie e spesso addirittura anticipa gli umori di Palazzo Chigi: Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio.
Giuseppe Conte e a voce altissima il giornale che più raccoglie e spesso addirittura anticipa gli umori di Palazzo Chigi: Il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio.  insieme a Giuseppe Conte e ad altri esponenti del governo, “ha visto tutti gli ingredienti e la road map per evitare tensioni tra mondo produttivo e mondo istituzionale”. Eppure Bonomi aveva pizzicato, diciamo così, il presidente del Consiglio sulla tentazione, secondo lui, di gestire solitariamente, o quasi, la partita dei fondi europei per la ripresa, o la nuova generazione. Di cui sarebbe un peccato se si facesse uso più per fare assistenza, o “debito cattivo”, come lo chiama l’ex presidente della Banca Europea Mario Draghi, che per promuovere sviluppo e ammodernamento.
insieme a Giuseppe Conte e ad altri esponenti del governo, “ha visto tutti gli ingredienti e la road map per evitare tensioni tra mondo produttivo e mondo istituzionale”. Eppure Bonomi aveva pizzicato, diciamo così, il presidente del Consiglio sulla tentazione, secondo lui, di gestire solitariamente, o quasi, la partita dei fondi europei per la ripresa, o la nuova generazione. Di cui sarebbe un peccato se si facesse uso più per fare assistenza, o “debito cattivo”, come lo chiama l’ex presidente della Banca Europea Mario Draghi, che per promuovere sviluppo e ammodernamento.  Luigi Zanda ha riconosciuto, in una intervista al Foglio, che “sta lavorando per conquistare una maturità politica, mentre mi
Luigi Zanda ha riconosciuto, in una intervista al Foglio, che “sta lavorando per conquistare una maturità politica, mentre mi  sembra -ha detto- che Di Battista vada veloce verso forme maggiori di infantilismo politico”. Tuttavia Zanda ha anche avvertito che, dopo avere “aspettato troppo per le modifiche dei decreti Salvini” su immigrazione e sicurezza, “ora il Pd sta aspettando troppo per Mes, Ilva, Autostrade, e per capire che cosa fanno i navigator” della mancata gestione produttiva, e non solo assistenziale, del cosiddetto reddito di cittadinanza.
sembra -ha detto- che Di Battista vada veloce verso forme maggiori di infantilismo politico”. Tuttavia Zanda ha anche avvertito che, dopo avere “aspettato troppo per le modifiche dei decreti Salvini” su immigrazione e sicurezza, “ora il Pd sta aspettando troppo per Mes, Ilva, Autostrade, e per capire che cosa fanno i navigator” della mancata gestione produttiva, e non solo assistenziale, del cosiddetto reddito di cittadinanza.
 da Silvio Berlusconi per la sua Forza Italia, ed esplicitato per primo dal professore
da Silvio Berlusconi per la sua Forza Italia, ed esplicitato per primo dal professore  Giuliano Urbani. Dal quale il Cavaliere di Arcore si lasciò consigliare con altri professori come Antonio Martino e Carlo Scognamiglio Pasini, cui altri poi si sarebbero aggiunti, da Marcello Pera a Lucio Colletti, da Saverio Vertone a Piero Melograni, preparando la sua “discesa in campo” politico, mentre la cosiddetta prima Repubblica tirava le cuoia nelle astanterie giudiziarie.
Giuliano Urbani. Dal quale il Cavaliere di Arcore si lasciò consigliare con altri professori come Antonio Martino e Carlo Scognamiglio Pasini, cui altri poi si sarebbero aggiunti, da Marcello Pera a Lucio Colletti, da Saverio Vertone a Piero Melograni, preparando la sua “discesa in campo” politico, mentre la cosiddetta prima Repubblica tirava le cuoia nelle astanterie giudiziarie. delle elezioni regionali e soprattutto comunali, non solo al Sud ma anche nella “sua” Lombardia, o proprio a causa di queste delusioni, sembra deciso a proporsi. Il Corriere glielo ha messo in bocca con tanto di virgolette giuste nei titoli dell’intervista seguita ad una “bella chiacchierata” avuta nel suo ufficio al Senato con l’ex sottosegretario alla Presidenza e attuale responsabile dell’ufficio esteri del partito Giancarlo Giorgetti. Di questo incontro è stato riferito da molti giornali con diverse interpretazioni, fra il chiarimento, la tregua e una persistente divergenza di vedute anche o soprattutto sui rapporti della Lega con gli altri partiti europei.
delle elezioni regionali e soprattutto comunali, non solo al Sud ma anche nella “sua” Lombardia, o proprio a causa di queste delusioni, sembra deciso a proporsi. Il Corriere glielo ha messo in bocca con tanto di virgolette giuste nei titoli dell’intervista seguita ad una “bella chiacchierata” avuta nel suo ufficio al Senato con l’ex sottosegretario alla Presidenza e attuale responsabile dell’ufficio esteri del partito Giancarlo Giorgetti. Di questo incontro è stato riferito da molti giornali con diverse interpretazioni, fra il chiarimento, la tregua e una persistente divergenza di vedute anche o soprattutto sui rapporti della Lega con gli altri partiti europei. Forza Italia”, dove tuttavia molti più che amarlo lo temono. E non gli perdonano di avere elettoralmente sorpassato il partito del Cavaliere strappandogli la “trazione” del centrodestra. Essi non riescono neppure a consolarsi per la concorrenza che, sempre all’interno della coalizione gli sta facendo Giorgia Meloni con i suoi Fratelli d’Italia. Nemmeno la Meloni gode di molta popolarità fra i berlusconiani, che non più tardi di quattro anni fa nelle elezioni comunali di Roma ne contrastarono la candidatura a sindaco, preferendole Alfio Marchini eliminato al primo turno. Nel ballottaggio, per ritorsione sospettando che Berlusconi sotto sotto sperasse nel successo del radicale e piddino Roberto Giachetti, meloniani e un po’ anche leghisti votarono per la grillina Virginia Raggi, aiutandola a conquistare il Campidoglio. Sembra fantascienza, è invece cronaca un po’ stagionata.
Forza Italia”, dove tuttavia molti più che amarlo lo temono. E non gli perdonano di avere elettoralmente sorpassato il partito del Cavaliere strappandogli la “trazione” del centrodestra. Essi non riescono neppure a consolarsi per la concorrenza che, sempre all’interno della coalizione gli sta facendo Giorgia Meloni con i suoi Fratelli d’Italia. Nemmeno la Meloni gode di molta popolarità fra i berlusconiani, che non più tardi di quattro anni fa nelle elezioni comunali di Roma ne contrastarono la candidatura a sindaco, preferendole Alfio Marchini eliminato al primo turno. Nel ballottaggio, per ritorsione sospettando che Berlusconi sotto sotto sperasse nel successo del radicale e piddino Roberto Giachetti, meloniani e un po’ anche leghisti votarono per la grillina Virginia Raggi, aiutandola a conquistare il Campidoglio. Sembra fantascienza, è invece cronaca un po’ stagionata. aggiornamento politico, di “allargare i confini del nostro perimetro coinvolgendo imprenditori e professionisti”, come “il capitano” ritiene di essere riuscito a fare nelle Marche diventando il primo partito e strappando la regione al Pd, ma con un candidato dei Fratelli d’Italia -va ricordato- alla presidenza.
aggiornamento politico, di “allargare i confini del nostro perimetro coinvolgendo imprenditori e professionisti”, come “il capitano” ritiene di essere riuscito a fare nelle Marche diventando il primo partito e strappando la regione al Pd, ma con un candidato dei Fratelli d’Italia -va ricordato- alla presidenza. la paura della destra liberale per la scelta democristiana del centro-sinistra sotto la guida di Aldo Moro, riuscì nelle elezioni politiche del 1963 a portare il Pli dal 3,82 per cento conquistato nel 1948 da Luigi Einaudi, prima di diventare presidente della Repubblica, al 6,97 per cento alla Camera e 7,52 al Senato.
la paura della destra liberale per la scelta democristiana del centro-sinistra sotto la guida di Aldo Moro, riuscì nelle elezioni politiche del 1963 a portare il Pli dal 3,82 per cento conquistato nel 1948 da Luigi Einaudi, prima di diventare presidente della Repubblica, al 6,97 per cento alla Camera e 7,52 al Senato. di massa, dell’associazione del buon governo ed altro ancora, fu indirizzato a Berlusconi negli anni Novanta da Gianni Agnelli. Che rimase affascinato dalle sue idee ma non aveva alcuna intenzione di cambiare mestiere e di scendere o salire in politica, forse contento di condizionarla standone a distanza.
di massa, dell’associazione del buon governo ed altro ancora, fu indirizzato a Berlusconi negli anni Novanta da Gianni Agnelli. Che rimase affascinato dalle sue idee ma non aveva alcuna intenzione di cambiare mestiere e di scendere o salire in politica, forse contento di condizionarla standone a distanza. pure lui, senza mai profferire critiche e tanto meno attacchi, è andato via via appartandosi, sino a rinunciare volontariamente ad una rielezione alla Camera, non so se più pago o stanco dei 24 anni di deputato, dal 1994 al 2018. Una volta, con la confidenza e la franchezza che solo lui poteva permettersi, scrisse un biglietto al Cavaliere per lamentarsi del fatto ch’egli frequentasse “donne con molto seno e poco senno”.
pure lui, senza mai profferire critiche e tanto meno attacchi, è andato via via appartandosi, sino a rinunciare volontariamente ad una rielezione alla Camera, non so se più pago o stanco dei 24 anni di deputato, dal 1994 al 2018. Una volta, con la confidenza e la franchezza che solo lui poteva permettersi, scrisse un biglietto al Cavaliere per lamentarsi del fatto ch’egli frequentasse “donne con molto seno e poco senno”.
 considerati in
considerati in  missione, comunque giustificati, gli assenti della maggioranza per ragioni sanitarie, essendo in quarantena per contagio o relativi accertamenti. Tutto insomma si è risolto nella classica bolla di sapone. Di cui Libero non ha ritenuto di riferire in prima pagina ai lettori neppure con un rigo, dopo la indignata denuncia, sempre in prima pagina, del giorno prima. E’ come aprire il giornale con l’arresto di qualcuno e ignorarne poi la scarcerazione o l’assoluzione.
missione, comunque giustificati, gli assenti della maggioranza per ragioni sanitarie, essendo in quarantena per contagio o relativi accertamenti. Tutto insomma si è risolto nella classica bolla di sapone. Di cui Libero non ha ritenuto di riferire in prima pagina ai lettori neppure con un rigo, dopo la indignata denuncia, sempre in prima pagina, del giorno prima. E’ come aprire il giornale con l’arresto di qualcuno e ignorarne poi la scarcerazione o l’assoluzione. 
 l’elezione del proprio candidato a sindaco appoggiato dal Pd locale, al presidente americano Donald Trump. Che, a leggere
l’elezione del proprio candidato a sindaco appoggiato dal Pd locale, al presidente americano Donald Trump. Che, a leggere  il buon Federico Rampini su Repubblica, si sente “rinato” nella campagna elettorale per la Casa Bianca dal contagio virale subìto e al tempo stesso sfidato. In verità, i sondaggi danno ancora in testa lo sfidante democratico Joe Biden. Ma i sondaggi, si sa, fanno a Trump i baffi che non ha.
il buon Federico Rampini su Repubblica, si sente “rinato” nella campagna elettorale per la Casa Bianca dal contagio virale subìto e al tempo stesso sfidato. In verità, i sondaggi danno ancora in testa lo sfidante democratico Joe Biden. Ma i sondaggi, si sa, fanno a Trump i baffi che non ha. 
 che con l’amministrazione Trump si lavora molto bene e con Mike Pompeo”, il Segretario di Stato americano venuto recentemente a Roma e accolto anche alla Farnesina, “si è instaurato un legame di amicizia”.
che con l’amministrazione Trump si lavora molto bene e con Mike Pompeo”, il Segretario di Stato americano venuto recentemente a Roma e accolto anche alla Farnesina, “si è instaurato un legame di amicizia”.  inorgoglito se a “quella manciata di piccoli Comuni” impietosamente ricordatagli dall’intervistatore egli ha risposto: “Mi basta che in tutti i Comuni dove ci siamo presentati in coalizione abbiamo vinto: da Pomigliano d’Arco a Matera, passando per Giugliano e Caivano”, dove -si è vantato- “sono andato a sostenere i nostri candidati perché sono persone in carne ed ossa, pulite, con la schiena dritta, con dei valori, a dimostrazione del fatto che il movimento 5 Stelle non rinuncia affatto ai suoi”.
inorgoglito se a “quella manciata di piccoli Comuni” impietosamente ricordatagli dall’intervistatore egli ha risposto: “Mi basta che in tutti i Comuni dove ci siamo presentati in coalizione abbiamo vinto: da Pomigliano d’Arco a Matera, passando per Giugliano e Caivano”, dove -si è vantato- “sono andato a sostenere i nostri candidati perché sono persone in carne ed ossa, pulite, con la schiena dritta, con dei valori, a dimostrazione del fatto che il movimento 5 Stelle non rinuncia affatto ai suoi”. 
 d’appalto “da casta” sulla distribuzione
d’appalto “da casta” sulla distribuzione  della posta del Senato con “pony express in giacca e cravatta”, per guadagnarsi un’intimazione di sfratto addirittura dal mio amico Antonio Padellaro? Che nella redazione del giornale da lui stesso fondato può ben ritenersi un mite rispetto agli altri.
della posta del Senato con “pony express in giacca e cravatta”, per guadagnarsi un’intimazione di sfratto addirittura dal mio amico Antonio Padellaro? Che nella redazione del giornale da lui stesso fondato può ben ritenersi un mite rispetto agli altri.  il Parlamento per i tantissimi decreti legge e decreti presidenziali del governo e per lo stato di incertezza e di
il Parlamento per i tantissimi decreti legge e decreti presidenziali del governo e per lo stato di incertezza e di  confusione che grava sul Paese. Che è così stato tanto avvertito nella stessa maggioranza governativa che si sprecano inviti e proposte di “nuova fase”, “verifica”, “rimpasto”, “tavolo” negoziale, “contratto” e via discorrendo. E ciò per non parlare
confusione che grava sul Paese. Che è così stato tanto avvertito nella stessa maggioranza governativa che si sprecano inviti e proposte di “nuova fase”, “verifica”, “rimpasto”, “tavolo” negoziale, “contratto” e via discorrendo. E ciò per non parlare  della crisi del maggiore movimento della coalizione governativa, sull’orlo
della crisi del maggiore movimento della coalizione governativa, sull’orlo di una scissione da possibili percorsi giudiziari, addirittura. O per non parlare, ancora, dei moniti alla concretezza e pacificazione che si levano continuamente dal Quirinale. Dove Padellaro teme che una come la Casellati possa arrivare un giorno o solo recarvisi come supplente in caso di impedimento momentaneo del presidente della Repubblica.
di una scissione da possibili percorsi giudiziari, addirittura. O per non parlare, ancora, dei moniti alla concretezza e pacificazione che si levano continuamente dal Quirinale. Dove Padellaro teme che una come la Casellati possa arrivare un giorno o solo recarvisi come supplente in caso di impedimento momentaneo del presidente della Repubblica. 
 proroga dello stato di emergenza virale in arrivo dal governo col solito decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, il giornalista principe di una testata libera naturalmente anche di
proroga dello stato di emergenza virale in arrivo dal governo col solito decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, il giornalista principe di una testata libera naturalmente anche di  sbagliare ha liquidato all’ingrosso i circa 100 assenti, di cui una quarantina giustificati tra missioni e preavvisi motivati, come “codardi indegni”, “disertori”, “incapaci di essere all’altezza del ruolo ricoperto” ed altro ancora. E li ha contrapposti ai medici, infermieri e altri dipendenti ospedalieri che, anche a costo di morire, come purtroppo è accaduto davvero, hanno fatto il loro mestiere in questi tempi pericolosi di epidemia virale. Che si è affacciata pure in Parlamento, nonostante le misure cautelative adottate e la destinazione, per esempio, dello storico “transatlantico” di Montecitorio ad appendice dell’aula, per cui giornalisti e deputati interessati a interloquire, diciamo così, debbono distribuirsi fra i corridoi del palazzo e il cortile, solitamente associato per immagine agli animali domestici.
sbagliare ha liquidato all’ingrosso i circa 100 assenti, di cui una quarantina giustificati tra missioni e preavvisi motivati, come “codardi indegni”, “disertori”, “incapaci di essere all’altezza del ruolo ricoperto” ed altro ancora. E li ha contrapposti ai medici, infermieri e altri dipendenti ospedalieri che, anche a costo di morire, come purtroppo è accaduto davvero, hanno fatto il loro mestiere in questi tempi pericolosi di epidemia virale. Che si è affacciata pure in Parlamento, nonostante le misure cautelative adottate e la destinazione, per esempio, dello storico “transatlantico” di Montecitorio ad appendice dell’aula, per cui giornalisti e deputati interessati a interloquire, diciamo così, debbono distribuirsi fra i corridoi del palazzo e il cortile, solitamente associato per immagine agli animali domestici. legislatura
legislatura  in poi; proprio nel momento, dicevo, in cui questo quasi partito perde carrettate di voti e rischia la scissione per scongiurare la quale anticipa al prossimo mese l’apertura a Roma del complesso percorso congressuale dei cosiddetti Stati Generali, e “fisici”, come ha precisato il “reggente” Vito Crimi, comunque destinati a sfociare nella solita soluzione digitale gestita dalla sempre più controversa “piattaforma” privata di Davide Casaleggio, venga rilanciato l’anti-parlamentarismo da un dichiarato avversario o comunque contestatore del grillismo.
in poi; proprio nel momento, dicevo, in cui questo quasi partito perde carrettate di voti e rischia la scissione per scongiurare la quale anticipa al prossimo mese l’apertura a Roma del complesso percorso congressuale dei cosiddetti Stati Generali, e “fisici”, come ha precisato il “reggente” Vito Crimi, comunque destinati a sfociare nella solita soluzione digitale gestita dalla sempre più controversa “piattaforma” privata di Davide Casaleggio, venga rilanciato l’anti-parlamentarismo da un dichiarato avversario o comunque contestatore del grillismo. 
 del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, indicata ironicamente anche con l’acronimo MEAC, per avere rilasciato al Corriere della Sera un’intervista molto preoccupata sulla situazione del Paese e sulle insufficienze, quanto meno, di un governo che alimenta la confusione e l’incertezza anziché ridurle in una crisi, anzi in un’emergenza che è insieme sanitaria, sociale, economica e politica.
del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, indicata ironicamente anche con l’acronimo MEAC, per avere rilasciato al Corriere della Sera un’intervista molto preoccupata sulla situazione del Paese e sulle insufficienze, quanto meno, di un governo che alimenta la confusione e l’incertezza anziché ridurle in una crisi, anzi in un’emergenza che è insieme sanitaria, sociale, economica e politica.  dal vertice di Montecitorio cercò nel 2010 di rovesciare il governo in carica di Silvio Berlusconi, e dimenticando il clamoroso Cesare Merzagora del 1960. Che dalla presidenza del Senato, alla quale fu confermato dopo le dimissioni seguite alle polemiche che aveva suscitato, insorse contro il disordine persino sanguinoso provocato dal governo di Fernando Tambroni sostenuto dall’estrema destra.
dal vertice di Montecitorio cercò nel 2010 di rovesciare il governo in carica di Silvio Berlusconi, e dimenticando il clamoroso Cesare Merzagora del 1960. Che dalla presidenza del Senato, alla quale fu confermato dopo le dimissioni seguite alle polemiche che aveva suscitato, insorse contro il disordine persino sanguinoso provocato dal governo di Fernando Tambroni sostenuto dall’estrema destra.  nei mesi scorsi l’aveva attaccata per avere ostacolato la tattica dilatoria della maggioranza di governo nella procedura di autorizzazione a precedere per sequestro di immigrati sulla nave Gregoretti contro l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Che peraltro è difeso in questa paradossale vicenda giudiziaria dalla pubblica accusa. “Fuori luogo”, si è limitato a dire contro la presidente Casellati il capogruppo dei senatori pentastellati Gianluca Perilli, forse consapevole che fra i suoi colleghi ce ne sono non pochi tanto insoddisfatti del governo Conte da morire dalla voglia di votargli contro.
nei mesi scorsi l’aveva attaccata per avere ostacolato la tattica dilatoria della maggioranza di governo nella procedura di autorizzazione a precedere per sequestro di immigrati sulla nave Gregoretti contro l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Che peraltro è difeso in questa paradossale vicenda giudiziaria dalla pubblica accusa. “Fuori luogo”, si è limitato a dire contro la presidente Casellati il capogruppo dei senatori pentastellati Gianluca Perilli, forse consapevole che fra i suoi colleghi ce ne sono non pochi tanto insoddisfatti del governo Conte da morire dalla voglia di votargli contro. il mezzo scandalo da “Casta” di una gara d’appalto indetta per il servizio di distribuzione della posta del Senato con tanto di pony express, pensate un po’,”in giacca e cravatta”. Ah, benedetta signora Presidente.
il mezzo scandalo da “Casta” di una gara d’appalto indetta per il servizio di distribuzione della posta del Senato con tanto di pony express, pensate un po’,”in giacca e cravatta”. Ah, benedetta signora Presidente.  governo -e dello stato un po’ sofferente, diciamo così, in cu esso ha ridotto il Parlamento con la frequenza dei suoi decreti legge e decreti presidenziali- una partecipazione
governo -e dello stato un po’ sofferente, diciamo così, in cu esso ha ridotto il Parlamento con la frequenza dei suoi decreti legge e decreti presidenziali- una partecipazione  alle feste in corso di Luigi Di Maio e amici, a cominciare da quelli del Fatto, per la strepitosa vittoria -a sentirli- conseguita nei ballottaggi comunali appena conclusi. Che hanno consentito al candidato grillino, con l’appoggio del Pd, di diventare sindaco di Matera, dove Marco Travaglio
alle feste in corso di Luigi Di Maio e amici, a cominciare da quelli del Fatto, per la strepitosa vittoria -a sentirli- conseguita nei ballottaggi comunali appena conclusi. Che hanno consentito al candidato grillino, con l’appoggio del Pd, di diventare sindaco di Matera, dove Marco Travaglio  con l’appoggio del Pd, del grillino Gianluca Del Mastro, insegnante universitario di papirologia, a sindaco di Pomigliano d’Arco, 39 mila e rotti abitanti, alle porte di Napoli, paese di adozione di Luigi Di Maio, nato nella non troppo lontana Avellino. Il governo Conte 2 può tirare un sospiro di sollievo, togliendosi magari la mascherina.
con l’appoggio del Pd, del grillino Gianluca Del Mastro, insegnante universitario di papirologia, a sindaco di Pomigliano d’Arco, 39 mila e rotti abitanti, alle porte di Napoli, paese di adozione di Luigi Di Maio, nato nella non troppo lontana Avellino. Il governo Conte 2 può tirare un sospiro di sollievo, togliendosi magari la mascherina.
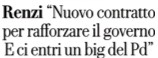 i temi di quella che, tirato per i capelli dalla interlocutrice, ha ammesso di poter chiamare “verifica”, alla vecchia maniera. E anche di poterla vedere
i temi di quella che, tirato per i capelli dalla interlocutrice, ha ammesso di poter chiamare “verifica”, alla vecchia maniera. E anche di poterla vedere sfociare in quello che, sempre alla vecchia maniera, potrebbe essere chiamato “rimpasto” di governo, per quanto la parola faccia inorridire, o piùsemplicemente impaurisca, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Che ancora attribuisce un simile passaggio all’”agenda” dei giornalisti, non sua, già troppo fitta di appuntamenti ed eventi.
sfociare in quello che, sempre alla vecchia maniera, potrebbe essere chiamato “rimpasto” di governo, per quanto la parola faccia inorridire, o piùsemplicemente impaurisca, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Che ancora attribuisce un simile passaggio all’”agenda” dei giornalisti, non sua, già troppo fitta di appuntamenti ed eventi. di vera e propria denuncia dei rischi di paralisi e confusione anche istituzionale in cui viviamo, della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al Corriere della Sera.
di vera e propria denuncia dei rischi di paralisi e confusione anche istituzionale in cui viviamo, della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al Corriere della Sera.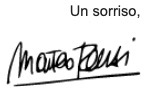 accettasse di entrare nel Consiglio dei Ministri, anziché farsene raccontare le riunioni da altri. A meno che Renzi, magari in un corso accelerato di storia della cosiddetta prima Repubblica, non abbia riscoperto il fascino della vecchia, e sostanzialmente inevasa, proposta di Ugo La Malfa di rafforzare i governi di seconda generazione del centrosinistra, dopo quelli presieduti da Aldo Moro, istituendo un “direttorio” di ministri senza portafoglio nelle persone dei segretari dei partiti della coalizione.
accettasse di entrare nel Consiglio dei Ministri, anziché farsene raccontare le riunioni da altri. A meno che Renzi, magari in un corso accelerato di storia della cosiddetta prima Repubblica, non abbia riscoperto il fascino della vecchia, e sostanzialmente inevasa, proposta di Ugo La Malfa di rafforzare i governi di seconda generazione del centrosinistra, dopo quelli presieduti da Aldo Moro, istituendo un “direttorio” di ministri senza portafoglio nelle persone dei segretari dei partiti della coalizione. il petto per l’ennesima volta nella stessa giornata- l’obbiezione della intervistatrice Annalisa Cuzzocrea su una certa sproporzione che potrebbe apparire agli occhi del pubblico tra le ambizioni, l’attivismo e quant’altro del suo partito Italia Viva e i voti raccolti nelle prime elezioni nelle quali ha voluto o potuto misurarsi.
il petto per l’ennesima volta nella stessa giornata- l’obbiezione della intervistatrice Annalisa Cuzzocrea su una certa sproporzione che potrebbe apparire agli occhi del pubblico tra le ambizioni, l’attivismo e quant’altro del suo partito Italia Viva e i voti raccolti nelle prime elezioni nelle quali ha voluto o potuto misurarsi. fare meglio dei 5 Stelle e diventare il secondo partito della coalizione”, dopo il Pd, bontà sua. Il solito boy scout, avrà commentato il nuovo editore di Repubblica, chissà se anche a proposito della ipotesi, ritenuta da Renzi soltanto poco attuale, di una sua nomina a segretario generale della Nato “nel novembre 2022”, con un presidente degli Stati Uniti diverso naturalmente da Donald Trump.
fare meglio dei 5 Stelle e diventare il secondo partito della coalizione”, dopo il Pd, bontà sua. Il solito boy scout, avrà commentato il nuovo editore di Repubblica, chissà se anche a proposito della ipotesi, ritenuta da Renzi soltanto poco attuale, di una sua nomina a segretario generale della Nato “nel novembre 2022”, con un presidente degli Stati Uniti diverso naturalmente da Donald Trump.