Sicuramente aiutato anche dal fatto di giocare in casa, nella quasi sua Napoli, Luigi Di Maio ha  pareggiato, quanto meno, il bagno di folla fatto
pareggiato, quanto meno, il bagno di folla fatto  il giorno prima da Giuseppe Conte al raduno dei pentastellati, nel decimo anniversario della nascita del movimento di Beppe Grillo. Che, sornione, si è divertito a dare spettacolo fra il suo pubblico tenendosi lontano dal dibattito che lo divide dopo il repentino cambiamento di maggioranza e di alleati seguito, con la sua spinta decisiva, alla crisi agostana di governo provocata da Matteo Salvini.
il giorno prima da Giuseppe Conte al raduno dei pentastellati, nel decimo anniversario della nascita del movimento di Beppe Grillo. Che, sornione, si è divertito a dare spettacolo fra il suo pubblico tenendosi lontano dal dibattito che lo divide dopo il repentino cambiamento di maggioranza e di alleati seguito, con la sua spinta decisiva, alla crisi agostana di governo provocata da Matteo Salvini.
Il dibattito, al netto di tutte le cortine fumogene che sollevano quanti lo vogliono nascondere, fuori e dentro il movimento, è sulla natura tattica o strategica, provvisoria o permanente, straordinaria o sistemica, dell’alleanza col Pd: l’ex partito di Bibbiano, come era stato liquidato sotto le cinque stelle quando il partner di governo era Salvini e all’opposizione stavano Nicola Zingaretti e Matteo Renzi ancora insieme. Come insieme, ma da separati, ciascuno per conto suo, stanno per adesso nella nuova maggioranza
Di Maio, diversamente da Conte e da quella parte consistente del Pd che vorrebbe trasformare in una corazza l’attuale maggioranza, per quanto giù divisa e litigiosa sul bilancio e, più in generale, sui temi dell’economia, tanto da far gridare sulla prima pagina di Repubblica  che “fra i tre litiganti l’Italia non gode”, ha preso come occasione, o pretesto, le difficoltà che emergono progressivamente in periferia per applicarvi lo schema romano, per lanciare questo messaggio: “Quella dell’Umbria non è un’alleanza col Pd, ma un’operazione civica”. Che, in quanto tale, par di capire che non possa essere scambiata per un’operazione nazionale, a meno che non si voglia pensare che anche alle elezioni politiche i partiti vogliano o possano decentemente nascondersi dietro qualche candidatura mascherata, o travestirsi.
che “fra i tre litiganti l’Italia non gode”, ha preso come occasione, o pretesto, le difficoltà che emergono progressivamente in periferia per applicarvi lo schema romano, per lanciare questo messaggio: “Quella dell’Umbria non è un’alleanza col Pd, ma un’operazione civica”. Che, in quanto tale, par di capire che non possa essere scambiata per un’operazione nazionale, a meno che non si voglia pensare che anche alle elezioni politiche i partiti vogliano o possano decentemente nascondersi dietro qualche candidatura mascherata, o travestirsi.
Ancora più chiaramente il capo ancòra del movimento grillino ha spiegato così al suo pubblico i rapporti col nuovo, principale alleato: “Allora -mi chiederete- non possiamo più parlare male del Pd? E io vi rispondo: sì che potrai farlo, ma sei sicuro che serve ancora parlare male degli altri?”. E quindi -debbo presumere- anche dei leghisti? Coi quali i grillini hanno governato per 14 mesi e potrebbero tornare a farlo se col Pd non si riuscisse ad andare sempre d’accordo, par di capire -ripeto- dal ragionamento di Di Maio. E ciò, vista anche la premura con la quale egli ha rivendicato il ruolo ormai centrale del suo movimento, una volta che è stata salvata la legislatura uscita dalle urne l’anno scorso, in Parlamento i gruppi pentastellati detengono la maggioranza relativa e vendono il loro pane a chiunque, persino rovesciando la parabola andreottiana dei due forni ai tempi della Dc. Che si offriva modestamente, a suo modo, da cliente e non da fornaio.
La reversibilità delle alleanze rivendicata da Di Maio nella versione non più “rabbiosa” ma buonista, starei per dire, del suo movimento ormai evoluto, o stanco di dieci anni di improperi a tutti e per tutto, si è casualmente e immediatamente incrociata con una svolta almeno lessicale proprio del leader leghista
lessicale proprio del leader leghista Matteo Salvini in una lunga intervista al Foglio raccolta da Annalisa Chirico. Che Giuliano Ferrara, il fondatore del giornale, si diverte a chiamare Chirichessa perdonandole le incursioni nei campi da lui considerati nemici. E’ un’intervista che parla da sola già nei titoli: “Prove di Salvini 2.0” in prima pagina e “Idee per una Lega non truce” all’interno. Non male, editorialmente, bisogna ammetterlo.
Matteo Salvini in una lunga intervista al Foglio raccolta da Annalisa Chirico. Che Giuliano Ferrara, il fondatore del giornale, si diverte a chiamare Chirichessa perdonandole le incursioni nei campi da lui considerati nemici. E’ un’intervista che parla da sola già nei titoli: “Prove di Salvini 2.0” in prima pagina e “Idee per una Lega non truce” all’interno. Non male, editorialmente, bisogna ammetterlo.
A parte una contestazione di Conte aspra e sistematica, comprensibile d’altronde dopo tutto quello che si è sentito dire ancora da ministro dell’Interno nell’aula del Senato nel mese di agosto dal  presidente
presidente 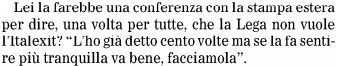 del Consiglio, e uno sfottò -diciamo così- a Di Maio come ministro degli Esteri per l’improvviso approccio a competenze obiettivamente estranee alla sua esperienza politica, Salvini si è prestato di buon grado a tutte le occasioni generosamente offertegli dall’intervistatrice per farsi apprezzare, o scoprire, dai cultori delle buone maniere, dagli europeisti e dagli atlantisti. anche se Donald Trump in questi giorni -va detto con tutta onestà- sta un po’ troppo pasticciando con i valori occidentali. Egli è arrivato a rimproverare ai curdi di non avere partecipato allo sbarco in Normandia, quasi per giustificare la carneficina che ne vuole fare ora in Siria il sultano della Turchia.
del Consiglio, e uno sfottò -diciamo così- a Di Maio come ministro degli Esteri per l’improvviso approccio a competenze obiettivamente estranee alla sua esperienza politica, Salvini si è prestato di buon grado a tutte le occasioni generosamente offertegli dall’intervistatrice per farsi apprezzare, o scoprire, dai cultori delle buone maniere, dagli europeisti e dagli atlantisti. anche se Donald Trump in questi giorni -va detto con tutta onestà- sta un po’ troppo pasticciando con i valori occidentali. Egli è arrivato a rimproverare ai curdi di non avere partecipato allo sbarco in Normandia, quasi per giustificare la carneficina che ne vuole fare ora in Siria il sultano della Turchia.
In veste di ormai ex Truce, con la maiuscola applicatagli da Giuliano Ferrara, che peraltro sa essere truce pure lui quando prende di mira uno che gli sta soltanto antipatico, Salvini si è in qualche modo scusato anche di quei “pieni poteri” reclamati sulle spiagge nella intempestiva campagna 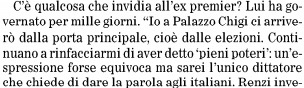 elettorale d’agosto. Egli ha ammesso che è stata ed è “un’espressione forse equivoca”, che gli è costata il governo. Dove comunque egli ottimisticamente conta di tornare guidandolo, con l’ingresso a Palazzo Chigi “dal portone principale”, e senza bisogno di chiedere o guadagnarsi gli oracoli dell’inquilino di turno alla Casa Bianca. Ogni allusione a Conte, e al “Giuseppi” di Trump, è naturalmente voluta.
elettorale d’agosto. Egli ha ammesso che è stata ed è “un’espressione forse equivoca”, che gli è costata il governo. Dove comunque egli ottimisticamente conta di tornare guidandolo, con l’ingresso a Palazzo Chigi “dal portone principale”, e senza bisogno di chiedere o guadagnarsi gli oracoli dell’inquilino di turno alla Casa Bianca. Ogni allusione a Conte, e al “Giuseppi” di Trump, è naturalmente voluta.
Ripreso da http://www.startmag.it e http://www.policymakermag.it


 apparso come il vero capo del quasi partito che in campagna elettorale, non più tardi di un anno e mezzo fa, lo aveva adottato solo come candidato a ministro di quella che una volta si chiamava riforma burocratica. Essa veniva affidata ai principianti, anche se non mancarono, fra quelli, alcuni votati a una grande carriera, come Francesco Cossiga. Che scalando scalando arrivò al Ministero dell’Interno, alla Presidenza del Consiglio, alla Presidenza del Senato e infine alla Presidenza della Repubblica, fermandosi lì perché, almeno in Italia, non c’era altra vetta più alta da raggiungere.
apparso come il vero capo del quasi partito che in campagna elettorale, non più tardi di un anno e mezzo fa, lo aveva adottato solo come candidato a ministro di quella che una volta si chiamava riforma burocratica. Essa veniva affidata ai principianti, anche se non mancarono, fra quelli, alcuni votati a una grande carriera, come Francesco Cossiga. Che scalando scalando arrivò al Ministero dell’Interno, alla Presidenza del Consiglio, alla Presidenza del Senato e infine alla Presidenza della Repubblica, fermandosi lì perché, almeno in Italia, non c’era altra vetta più alta da raggiungere.  di voler fondare un suo partito, per quanto certi sondaggi già gli attribuiscano poco meno o più del venti per cento dei voti. Che è poi il livello al quale il movimento grillino è ridotto adesso nelle cosiddette intenzioni di voto, risalendo di qualche punto dal 17 cui l’aveva calato Matteo Salvini, nelle elezioni europee del 26 maggio scorso, dopo meno di un anno di governo gialloverde: quasi la metà del 32 per cento e rotti delle elezioni politiche del 4 marzo 2018.
di voler fondare un suo partito, per quanto certi sondaggi già gli attribuiscano poco meno o più del venti per cento dei voti. Che è poi il livello al quale il movimento grillino è ridotto adesso nelle cosiddette intenzioni di voto, risalendo di qualche punto dal 17 cui l’aveva calato Matteo Salvini, nelle elezioni europee del 26 maggio scorso, dopo meno di un anno di governo gialloverde: quasi la metà del 32 per cento e rotti delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. defenestrando Enrico Letta da Palazzo Chigi nel 2014, il suo nuovo alleato Matteo Renzi. Col quale peraltro il capo pur contestato del movimento grillino sembra avere instaurato un rapporto davvero imprevisto e curioso di affinità. Essi hanno appena condotto insieme nel nuovo governo, mettendo alle corde Conte, il ministro dell’Economia, il Pd e la sinistra radicale dei D’Alema, Bersani, Grasso e altri, la battaglia contro l’aumento o la cosiddetta rimodulazione dell’Iva. E hanno fatto spallucce a quanti -dentro la già assai variopinta maggioranza realizzatasi per scongiurare le elezioni anticipate che Salvini si aspettava dalla crisi avendo preso per buona la postazione pro-voto poi abbandonata dal segretario del Pd Nicola Zingaretti- si sono messi a ironizzare sulla strana coppia costituita appunto da loro due.
defenestrando Enrico Letta da Palazzo Chigi nel 2014, il suo nuovo alleato Matteo Renzi. Col quale peraltro il capo pur contestato del movimento grillino sembra avere instaurato un rapporto davvero imprevisto e curioso di affinità. Essi hanno appena condotto insieme nel nuovo governo, mettendo alle corde Conte, il ministro dell’Economia, il Pd e la sinistra radicale dei D’Alema, Bersani, Grasso e altri, la battaglia contro l’aumento o la cosiddetta rimodulazione dell’Iva. E hanno fatto spallucce a quanti -dentro la già assai variopinta maggioranza realizzatasi per scongiurare le elezioni anticipate che Salvini si aspettava dalla crisi avendo preso per buona la postazione pro-voto poi abbandonata dal segretario del Pd Nicola Zingaretti- si sono messi a ironizzare sulla strana coppia costituita appunto da loro due. 
 fra una bandiera e l’altra che gli sventolano quotidianamente accanto per i suoi impegni istituzionali, il presidente della Canera Roberto Fico. Il quale, rispettosamente intervistato dal Corriere della Sera, ha aggiunto al compiacimento
fra una bandiera e l’altra che gli sventolano quotidianamente accanto per i suoi impegni istituzionali, il presidente della Canera Roberto Fico. Il quale, rispettosamente intervistato dal Corriere della Sera, ha aggiunto al compiacimento 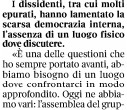 per la “crescita” del movimento, sicuramente anagrafica se non vogliamo stare a immiserirci con i voti perduti a maggio, il rammarico che non ci sia “un luogo dove poter discutere anche le critiche” e liberare così le potenzialità insiste nelle “differenze di vedute”, cioè nei contrasti che dividono, dilaniano e quant’altro un partito, o quasi partito, vista la ritrosia a chiamarlo così, che pure è rimasto quello di maggioranza relativa dopo lo scampato pericolo dello scioglimento anticipato delle Camere.
per la “crescita” del movimento, sicuramente anagrafica se non vogliamo stare a immiserirci con i voti perduti a maggio, il rammarico che non ci sia “un luogo dove poter discutere anche le critiche” e liberare così le potenzialità insiste nelle “differenze di vedute”, cioè nei contrasti che dividono, dilaniano e quant’altro un partito, o quasi partito, vista la ritrosia a chiamarlo così, che pure è rimasto quello di maggioranza relativa dopo lo scampato pericolo dello scioglimento anticipato delle Camere. 
 dei sostenitori del referendum contro una legge approvata a così larga maggioranza dal Parlamento, festeggiando come i tacchini il Natale, e festeggiata in piazza dai grillini nella convinzione della sua popolarità per la carica anti-casta che contiene. Si è un po’ ripetuto davanti a Montecitorio lo spettacolo di Luigi Di Maio affacciatosi l’anno scorso al balcone di Palazzo Chigi per festeggiare la sconfitta della povertà.
dei sostenitori del referendum contro una legge approvata a così larga maggioranza dal Parlamento, festeggiando come i tacchini il Natale, e festeggiata in piazza dai grillini nella convinzione della sua popolarità per la carica anti-casta che contiene. Si è un po’ ripetuto davanti a Montecitorio lo spettacolo di Luigi Di Maio affacciatosi l’anno scorso al balcone di Palazzo Chigi per festeggiare la sconfitta della povertà.
 ormai per i grillini è cambiato, per quanti vantaggi essi possano ancora ricavare dall’attuale -e per giunta disprezzata, ripeto- consistenza del Parlamento. E Giachetti, ma non solo lui, con la sua vecchia scuola radicale alle spalle, e nell’acquario renziano in cui ha deciso di continuare a nuotare, potrebbe davvero trovarsi nei panni di chi sembra pazzo ma non lo è per niente.
ormai per i grillini è cambiato, per quanti vantaggi essi possano ancora ricavare dall’attuale -e per giunta disprezzata, ripeto- consistenza del Parlamento. E Giachetti, ma non solo lui, con la sua vecchia scuola radicale alle spalle, e nell’acquario renziano in cui ha deciso di continuare a nuotare, potrebbe davvero trovarsi nei panni di chi sembra pazzo ma non lo è per niente.
 presidente americano alle prese col suo Russiagate, Conte non deve avere molto gradito le distanze, a dir poco, che è sembrato prendere da lui il presidente appena eletto dell’organismo bicamerale: l’ex sottosegretario leghista alla Difesa Raffaele Volpi. “Non è lui a decidere i nostri tempi”, ha avvertito Volpi parlando appunto di Conte e delle fretta che sembra avere.
presidente americano alle prese col suo Russiagate, Conte non deve avere molto gradito le distanze, a dir poco, che è sembrato prendere da lui il presidente appena eletto dell’organismo bicamerale: l’ex sottosegretario leghista alla Difesa Raffaele Volpi. “Non è lui a decidere i nostri tempi”, ha avvertito Volpi parlando appunto di Conte e delle fretta che sembra avere. 
 buoni argomenti per criticarla. Sono rimasto, per esempio,
buoni argomenti per criticarla. Sono rimasto, per esempio, letteralmente esterrefatto nel sentire l’amico Vittorio Sgarbi gridare nell’aula di Montecitorio allo “stupro” che sarebbe stato compiuto contro il Parlamento dai grillini e dai loro nuovi alleati di governo, come se i vecchi passati all’opposizione -i leghisti di Matteo Salvini- fossero stati contrari, e non favorevoli pure loro.
letteralmente esterrefatto nel sentire l’amico Vittorio Sgarbi gridare nell’aula di Montecitorio allo “stupro” che sarebbe stato compiuto contro il Parlamento dai grillini e dai loro nuovi alleati di governo, come se i vecchi passati all’opposizione -i leghisti di Matteo Salvini- fossero stati contrari, e non favorevoli pure loro. Renata Polverini, ormai in transito da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, quando spegne l’entusiasmo o solo la fiducia di chi si prepara al referendum di verifica sulla riduzione dei parlamentari dicendo di sentire nel Paese “un vento che non ammette riflessioni, resistenze, pensieri ostili” ai tagli appena approvati. È ciò anche se i grillini hanno sparato, a loro favore, risparmi stellari ridotti, o demoliti, da chi sa fare di conto allo 0,007% delle spese annuali dello Stato, e forse anche meno.
Renata Polverini, ormai in transito da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, quando spegne l’entusiasmo o solo la fiducia di chi si prepara al referendum di verifica sulla riduzione dei parlamentari dicendo di sentire nel Paese “un vento che non ammette riflessioni, resistenze, pensieri ostili” ai tagli appena approvati. È ciò anche se i grillini hanno sparato, a loro favore, risparmi stellari ridotti, o demoliti, da chi sa fare di conto allo 0,007% delle spese annuali dello Stato, e forse anche meno. stesso presidente del Consiglio. Il giorno in cui dovesse essere completata davvero questa riforma, che cosa onestamente rimarrà di valido, di attuale, di legittimo in un Parlamento eletto nel 2018, con le vecchie regole, nella vecchia composizione? Non mi sembra francamente una domanda peregrina, specie pensando alla fretta, se non alla frenesia, con la quale nel 1994 furono sciolte le Camere elette meno di due anni prima perché delegittimate -disse l’allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro- dalla sopraggiunta approvazione di una nuova legge elettorale.
stesso presidente del Consiglio. Il giorno in cui dovesse essere completata davvero questa riforma, che cosa onestamente rimarrà di valido, di attuale, di legittimo in un Parlamento eletto nel 2018, con le vecchie regole, nella vecchia composizione? Non mi sembra francamente una domanda peregrina, specie pensando alla fretta, se non alla frenesia, con la quale nel 1994 furono sciolte le Camere elette meno di due anni prima perché delegittimate -disse l’allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro- dalla sopraggiunta approvazione di una nuova legge elettorale.
 e altrove, tra striscioni, forbici e poltrone da rottamare, presente quello stesso Luigi Di Maio che l’anno scorso, di questi tempi, si affacciò al balcone di Palazzo Chigi come vice presidente del Consiglio e pluriministro per annunciare gioiosamente e prematuramente addirittura la fine della povertà; con tutto questo, ripeto, c’è francamente ben poco da dire, e tanto meno da scommettere su un referendum che possa riesumare i 345 seggi parlamentari tagliati fra Camera e Senato.
e altrove, tra striscioni, forbici e poltrone da rottamare, presente quello stesso Luigi Di Maio che l’anno scorso, di questi tempi, si affacciò al balcone di Palazzo Chigi come vice presidente del Consiglio e pluriministro per annunciare gioiosamente e prematuramente addirittura la fine della povertà; con tutto questo, ripeto, c’è francamente ben poco da dire, e tanto meno da scommettere su un referendum che possa riesumare i 345 seggi parlamentari tagliati fra Camera e Senato.  della coalizione, nonché ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che quanto più si dovesse mettere davvero mano alle modifiche costituzionali, legislative e regolamentari imposte -per loro stessa ammissione- dal taglio dei parlamentari, tanto più si avvicinerebbe non la scadenza ma la decadenza di fatto di questo Parlamento. Che già vive -non dimentichiamo neppure questo- nella non felice condizione di rappresentare un quadro politico -quello uscito dalle urne del 4 marzo 2018- letteralmente sconvolto dai risultati delle elezioni europee del 24 maggio scorso e dalle precedenti, non poche né irrilevanti elezioni regionali.
della coalizione, nonché ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che quanto più si dovesse mettere davvero mano alle modifiche costituzionali, legislative e regolamentari imposte -per loro stessa ammissione- dal taglio dei parlamentari, tanto più si avvicinerebbe non la scadenza ma la decadenza di fatto di questo Parlamento. Che già vive -non dimentichiamo neppure questo- nella non felice condizione di rappresentare un quadro politico -quello uscito dalle urne del 4 marzo 2018- letteralmente sconvolto dai risultati delle elezioni europee del 24 maggio scorso e dalle precedenti, non poche né irrilevanti elezioni regionali. 
 o senza tatuaggi.
o senza tatuaggi.  Invece il presidente del Consiglio ha voluto appena fornire di sé, alle prese con i problemi e le polemiche di questa stagione politica forse più calda di quanto gli avesse lasciato prevedere la più larga estensione della sua nuova maggioranza giallorossa, l’immagine di un uomo forte, attrezzato in tutti i sensi.
Invece il presidente del Consiglio ha voluto appena fornire di sé, alle prese con i problemi e le polemiche di questa stagione politica forse più calda di quanto gli avesse lasciato prevedere la più larga estensione della sua nuova maggioranza giallorossa, l’immagine di un uomo forte, attrezzato in tutti i sensi. 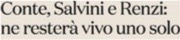 al successore Marco Travaglio, non foss’altro per ragioni di esperienza, avendone il primo ben più del secondo. “Conte, Salvini e Renzi: ne resterà vivo uno solo”, ha scritto e vaticinato Padellaro persino nel titolo. Vedremo chi sopravviverà, e con quale alleanza funesta fra gli altri due, naturalmente.
al successore Marco Travaglio, non foss’altro per ragioni di esperienza, avendone il primo ben più del secondo. “Conte, Salvini e Renzi: ne resterà vivo uno solo”, ha scritto e vaticinato Padellaro persino nel titolo. Vedremo chi sopravviverà, e con quale alleanza funesta fra gli altri due, naturalmente.
 sua Torrita Tiberina e Leone nella cappella di famiglia a Napoli dove è scolpita la frase di San Paolo riferita al Corriere da donna Vittoria: “Vita mutatur, non tollitur”. Vi fu sepolto
sua Torrita Tiberina e Leone nella cappella di famiglia a Napoli dove è scolpita la frase di San Paolo riferita al Corriere da donna Vittoria: “Vita mutatur, non tollitur”. Vi fu sepolto  dopo aver potuto giustamente vantarsi, come ha detto la vedova, di essere stato “l’unico democristiano non maledetto da Moro nelle sue drammatiche lettere” dalla prigione, dove probabilmente l’ostaggio seppe anche della grazia che il presidente della Repubblica stava per concedere di propria autonoma iniziativa per una detenuta, Paola Besuschio, non macchiata di reati di sangue, inclusa nell’elenco dei tredici “prigioniieri” con i quali i brigatisti rossi avevano chiesto di scambiare Moro.
dopo aver potuto giustamente vantarsi, come ha detto la vedova, di essere stato “l’unico democristiano non maledetto da Moro nelle sue drammatiche lettere” dalla prigione, dove probabilmente l’ostaggio seppe anche della grazia che il presidente della Repubblica stava per concedere di propria autonoma iniziativa per una detenuta, Paola Besuschio, non macchiata di reati di sangue, inclusa nell’elenco dei tredici “prigioniieri” con i quali i brigatisti rossi avevano chiesto di scambiare Moro.  politicamente la fine di Leone, costretto dopo qualche settimana alle dimissioni, sei mesi prima della scadenza del suo mandato, con ridicole motivazioni di facciata: addirittura per ridare vitalità alle istituzioni mortificate dalla conferma stentata della legge sul finanziamento pubblico dei partiti nel referendum abrogativo promosso dai radicali. E per chiudere una campagna scandalistica per traffico di grazie e affari contro il capo dello Stato destinata a risolversi poi nella condanna giudiziaria della sua autrice, Camilla Cederna.
politicamente la fine di Leone, costretto dopo qualche settimana alle dimissioni, sei mesi prima della scadenza del suo mandato, con ridicole motivazioni di facciata: addirittura per ridare vitalità alle istituzioni mortificate dalla conferma stentata della legge sul finanziamento pubblico dei partiti nel referendum abrogativo promosso dai radicali. E per chiudere una campagna scandalistica per traffico di grazie e affari contro il capo dello Stato destinata a risolversi poi nella condanna giudiziaria della sua autrice, Camilla Cederna.