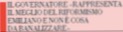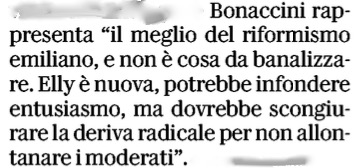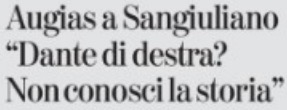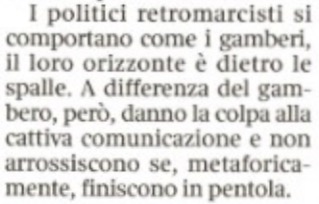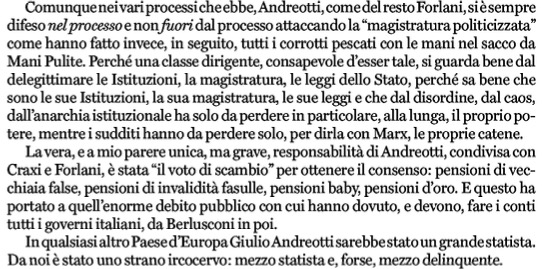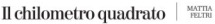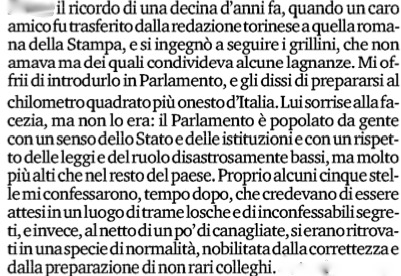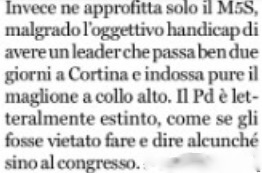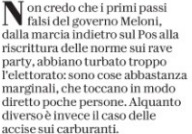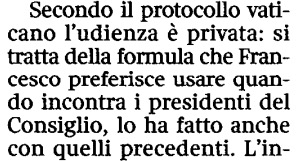Di ritorno da Palermo, dov’era giustamente volata per partecipare alla festa dello Stato per la cattura, finalmente, del superboss mafioso Matteo Messina Denaro, e compiacersi di un’operazione dichiaratamente condotta grazie anche alle intercettazioni e senza trattative, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata sentita mormorare: “E’ una vittoria che tutto il mondo vede, tranne alcuni dell’opposizione”.

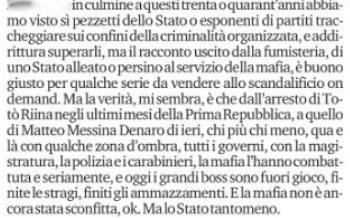
Infatti questa mattina dai banchi dell’opposizione culturale, chiamiamola così, fiancheggiatrice di quel discorso di sfiducia al governo pronunciato in Senato dall’ex procuratore generale della Procura di Palermo Roberto Scarpinato, ora parlamentare grillino, lo scrittore Roberto Saviano ha gridato in una intervista alla Stampa: “Il governo non è anti-mafia”. Gli ha per fortuna risposto sulla stessa prima pagina Mattia Feltri scrivendo, fra l’altro: “Dall’arresto di Totò Riina negli ultimi mesi della Prima Repubblica a quello di Matteo Messina Denaro di ieri, chi più chi meno, qua e là con qualche zona d’ombra, tutti i governi, con la magistratura, la polizia e i carabinieri, la mafia l’hanno combattuta e seriamente. E oggi i grandi boss sono fuori gioco, finite le stragi, finiti gli ammiccamenti. E la mafia non è stata ancora sconfitta, ok. Ma lo Stato tantomeno”. Altro che “alleato o persino al servizio della mafia”, ha scritto Mattia in un altro passaggio del suo articolo contro certa “fumisteria buona giusto per qualche serie da vendere allo scandalificio on demand”.

Con la solita bravura nella confezione dei titoli di cosiddetta copertina, mettendo semplicemente al minuscolo la località della più eclatante strage della mafia, che nel 1992 costò la vita, fra gli altri, al mitico magistrato Giovanni Falcone, il manifesto ha presentato la notizia della cattura di Denaro scolpendo:“Erano capaci”. In quel passato c’è tutto, o abbastanza. Ah, se intellettuali e politici di sinistra, vecchia o nuova, o nuovissima, avessero la stessa arguzia e misura di quei benedetti “eretici” espulsi nel 1969 dal Pci.
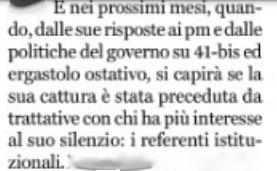
Ai lettori in buona parte grillini che pendono dalle sue riflessioni il direttore del Fatto Quotidiano ha oggi raccomandato di non affrettare sollievi per l’arresto di Denaro perché solo “nei prossimi mesi, dalle sue risposte ai pm e dalle politiche del governo su 41-bis ed ergastolo ostativo, si capirà se la sua cattura è stata preceduta da trattative con chi ha più interesse al suo silenzio: i referenti istituzionali”. Eppure qd altre “trattative” sono stati intitolati processi che dovrebbero fare arrossire, per i loro risultati, inquirenti e cronisti fiancheggiatori.

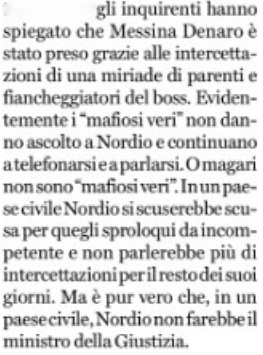
Nel caso ancora fresco della cattura di Denaro Il Fatto ha già indicato chi dovrebbe arrossire, e magari dimettersi o essere rimosso: il guardasigilli Carlo Nordio per il proposito di limitare e disciplinare meglio le intercettazioni. Delle quali evidentemente non si abusa mai abbastanza, visti i miracoli che possono produrre fra tante immondizie.
Ripreso da http://www.startmag.it e http://www.policymakermag.it