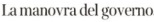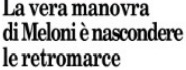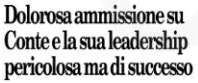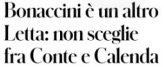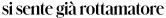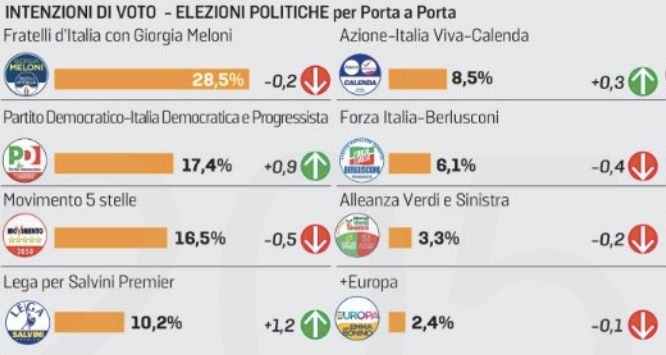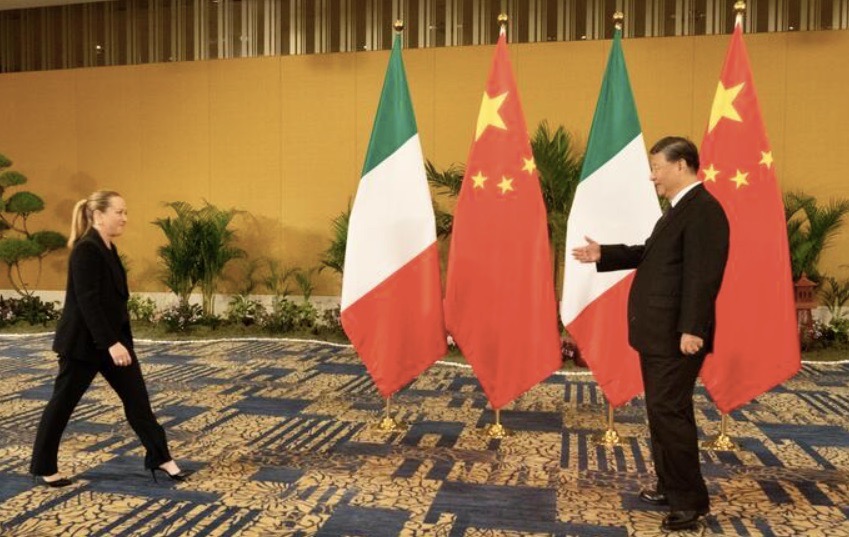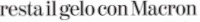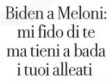Fra le particolarità della manovra adottata dal governo di Giorgia Meloni con la legge di bilancio, oltre ad essere la prima e molto probabilmente non ultima dell’esecutivo destra-centro, vi è anche quella di essere l’unica nella storia dedicata ad un morto. Lo ha fatto il ministro leghista dell’Economia Giancarlo Giorgetti ricordando l’amico e collega di partito Roberto Maroni appena scomparso prematuramente, già ministro nei governi di Silvio Berlusconi e presidente della regione Lombardia: “il barbaro gentile” nel felice titolo della Nazione e degli altri giornali del gruppo Riffeser Monti.


Potrebbe sembrare lì per lì una intestazione irriguardosa per il defunto, considerando ciò che le opposizioni gridano contro la manovra organizzando ciascuna, almeno sino a questo momento, una manifestazione di piazza. Pertanto il segretario del Pd Enrico Letta potrà risparmiarsi il 17 dicembre di partecipare a quella non ancora indetta da Giuseppe Conte, evitando così di ripetere lo spettacolo quanto meno imbarazzante della recente manifestazione a Roma per la pace. Dal cui corteo, diversamente da un Conte festeggiato , il segretario piddino dovette sfilarsi, o fuggire, per le contestazioni subite. Della manovra Meloni -o Maroni, come Giorgetti vorrebbe chiamarla, ridotto ridicolmente da Emilio Giannelli nella vignetta del Corriere della Sera nei panni ristretti della premier- il meno che si sia gridato è quelle “Botte ai poveri e niente più” del Riformista di Piero Sansonetti.


“Relitto di cittadinanza”, ha tradotto il manifesto da delitto di cittadinanza com’era prima dell’intervento del governo, Che ai non “occupabili” lo ridurrà a otto mensilità nel 2023 per abolirlo nel 2024. “Abbiamo ripristinato la povertà”, ha fatto sarcasticamente gridare il vignettista del Foglio alla Meloni dal balcone di Palazzo Chigi per capovolgere la “sconfitta della povertà” annunciata sullo stesso balcone quattro anni fa dall’allora vice presidente leghista del Consiglio Luigi Di Maio celebrando l’istituzione appunto di quel reddito. Non immaginava, l’incauto, che ne avrebbe pagato personalmente le spese nel 2022 ricandidandosi alla Camera praticamente col Pd su posizioni rovesciate, dopo l’uscita dal MoVimento 5 Stelle, e venendo bocciato. Ora lavorerà -per sua fortuna, grazie ad un ombrello apertogli sulla testa dall’ex presidente del Consiglio Mario Draghi- come “inviato”dell’Unione Europea nel Golfo Persico: a remunerazione -credo- competitiva con quella conseguita alla fine della scorsa legislatura da deputato e ministro degli Esteri.

Per tornare alla dedica della manovra al compianto Maroni da parte del ministro dell’Economia, l’iniziativa di Giorgetti si presta anche ad una lettura retroscenista tutta interna alla Lega. Dove Maroni, nonostante i suoi brillanti trascorsi politici sul Carroccio, era ormai stato ridotto nelle retrovie politiche dal suo successore alla guida del movimento, cioè Matteo Salvini. Che dalla manovra Meloni o Maroni, come preferite, esce alquanto ridimensionato per avere certamente ottenuto qualcosa ma avere ancor più dovuto rinunciare, piegato dai rifiuti di maggiori spese oppostigli dal collega di partito responsabile dei conti del governo.


Ai margini della manovra e della conferenza stampa illustrativa va infine registrato un certo nervosismo cui si è abbandonata la premier riducendo al minimo le domande e accusando i giornalisti -spalleggiata poi dalla Verità di Maurizio Belpietro- di essere “mastini” con lei dopo essere stati “a cuccia con Draghi”. No, cara la nostra signora presidente del Consiglio. Queste uscite -“A chi girano i Meloni”, ha titolato Libero– non sono utili a chi si ripromette di rimanere a Palazzo Chigi per cinque anni. Sono difetti di comunicazione, diciamo così, da evitare.
Ripreso da http://www.startmag.it e http://www.policymakermag.it