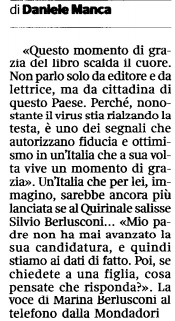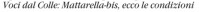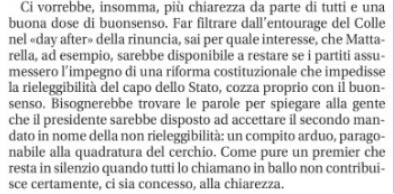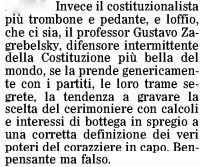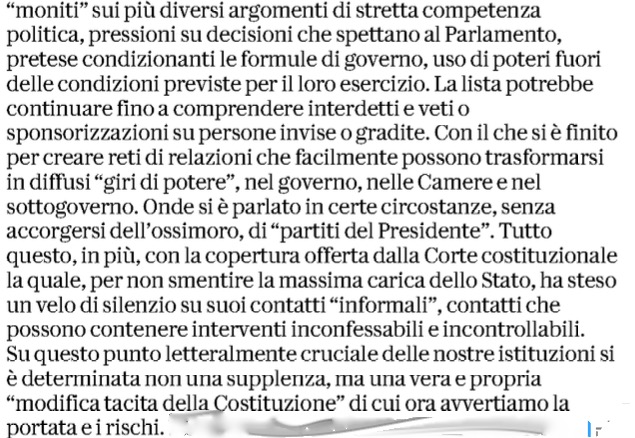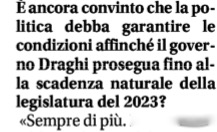Carissima donna Vittoria, come i più anziani -oggi- fra noi giornalisti ci abituammo a chiamarLa con gradita deferenza scrivendone quando già a 18 anni sposò il deputato dell’Assemblea Costituente Giovanni Leone, a 28 fu la moglie del presidente della Camera, a 36 la consorte del presidente del Consiglio e a 44 la first lady della Repubblica. Suo marito fu eletto infatti capo dello Stato il 23 dicembre del 1971, al secondo scrutinio su di lui, ventitreesimo di una serie in cui si era bruciata col fuoco dei “franchi tiratori” la candidatura del collega di partito Amintore Fanfani. E non era riuscita ad arrivare neppure nell’aula di Montecitorio la candidatura pur attesa dell’altro “cavallo di razza” della Dc. Che era Aldo Moro, amico personale, oltre che collega di partito, di Suo marito, tanto da lasciarsi andare con pochi altri come con lui nel vezzo che aveva -e gli riusciva benissimo- di imitare nella voce e nei gesti i politici che più o meno esplicitamente lo contrastavano.
Non Le scrivo, carissima donna Vittoria, certamente per ricordarle queste cose, ma per esprimerLe tutta la mia solidarietà e ammirazione per le dure prove che a distanza di vent’anni dalla morte di Suo marito, appena commemorato nel Palazzo del Quirinale con la partecipazione di Sergio Mattarella, deve ancora provare vedendolo solo in parte ripagato del grandissimo torto subito nel 1978. Allora i vertici della politica, che si riconoscevano nella formula della solidarietà nazionale realizzata dallo stesso Moro due anni prima attorno ad un governo monocolore democristiano presieduto da Giulio Andreotti, pretesero e ottennero il sacrificio del presidente della Repubblica con dimissioni anticipate di sei mesi rispetto alla scadenza del mandato.

Ancora oggi quando se ne parla in sedi e occasioni istituzionali, come è appena accaduto al Quirinale, dove l’ho vista con forte commozione tanto inevitabilmente invecchiata nelle foto col presidente della Repubblica, si riconosce, si ammette e si denuncia la odiosa e infondata campagna moralistica di diffamazione contro Leone condotta mediaticamente prima di quel doloroso e gravissimo passaggio istituzionale, in particolare dall’Espresso e da Camilla Cederna, poi condannata in tribunale. Ma sempre, dico sempre, anche quindi nella commemorazione recentissima sul Colle, nonostante le scuse formulate a Leone fortunatamente ancora in vita da molti che lo avevano criticato, a cominciare da Marco Pannella, si è mai riconosciuto e deplorato anche l’uso strumentale fatto di quella campagna dai vertici -ripeto- della politica di allora per spingere fuori dal Quirinale il presidente della Repubblica. Questa è una cosa che deve finire. E deve invece cominciare un’altra storia, stavolta davvero riparatrice, che ristabilisca la verità su quello strappo infame alla verità, quanto meno.
Ad imbarazzare i vertici della politica in quel tragico 1978, dopo un referendum contro il finanziamento pubblico dei partiti letto a sinistra come allarmante per il margine troppo ristretto in cui era stata sconfitta la richiesta di abrogazione, non fu la campagna mediatica contro Leone. Fu il coraggio avuto dal Presidente della Repubblica dopo il sequestro dell’amico Moro, la mattina del 16 marzo, di far conoscere -cominciando col segretario del proprio partito Benigno Zaccagnini, appositamente convocato al Quirinale- il proprio dissenso di cristiano e di giurista dalla cosiddetta linea della fermezza pubblicamente annunciata. Che peraltro era destinata ad essere gestita nel peggiore dei modi, tra impreparazioni, improvvisazioni, doppi giochi, infedeltà istituzionali, depistaggi, smarrimenti di materiale fotografico, perquisizioni mancati, indirizzi sbagliati, accreditamenti addirittura di sedute spiritiche e quant’altro.
A tutto questo incredibile pasticcio Leone oppose la sua umanità, la sua discrezione, la sua professionalità giuridica, la sua esperienza di avvocato -direi, quello fra tutti gli avvocati che più a lungo e più in alto ha servito lo Stato- cercando di salvare la vita di Moro nell’unico modo che gli sembrò possibile, visto il fallimento delle ricerche o dei tentativi, se davvero ci furono, di un assalto alla prigione e di una soluzione di forza, con tutti i rischi connessi temuti anche dai familiari.
Egli individuò personalmente, con l’aiuto di esperti e di amici davvero fidati, fra i 13 “prigionieri” con i quali le brigate rosse avevano proposto di scambiare l’ostaggio una posizione su cui intervenire con l’istituto presidenziale della grazia. Fu quella di Paola Besuschio, condannata per terrorismo senza fatti di sangue a suo carico e ammalata. Ma il Presidente non ebbe il tempo, dannatamente, per le informazioni di cui i terroristi evidentemente disponevano, di firmare in tempo il provvedimento di fronte al quale i macellai di via Fani, dove la scorta di Moro era stata sterminata, avrebbero dovuto assumersi la responsabilità di completare quella mattanza uccidendo lo stesso il presidente della Dc.

Leone insomma pagò con trattamento che gli fu successivamente riservato sul piano politico e istituzionale quella sua pur sfortunata generosità e umanità. La seconda vittima della mal gestita- ripeto- linea della fermezza fu lui, dopo Moro.
Colgo l’occasione, carissima donna Vittoria, anche per ringraziarla di quella presenza attiva all’intervista che Suo marito, nel ventesimo anniversario del sequestro di Moro, nella vostra casa volle concedermi per Il Foglio ricostruendo quei tragici giorni, fra carte ed agende, e raccontandomi quindi per filo e per segno tutti i tentativi compiuti, pur nell’isolamento in cui si sentiva confinato nel Quirinale in quel periodo così drammatico, per compiere fino in fondo e davvero le sue funzioni di un umano e cristiano presidente della Repubblica. Grazie ancora, e un bacio anche per me al primo ritratto di Suo marito che ha a portata di mano.
Pubblicato sul Dubbio