Formidabile quell’Altan, sulla prima pagina di Repubblica, che reclama in questi tempi di epidemia virale i distanziamenti sul tram affollato di Mario Draghi. Il povero Sergio Mattarella al Quirinale si sentirà un po’ in colpa per avere messo nella circolazione politica un mezzo così pericoloso per i ![]() contagi cui si espongono i passeggeri. Dalla fila, in effetti, si è passati in pochi giorni alla ressa lamentata in rosso dal Fatto Quotidiano davanti alla metaforica porta dell’ex presidente della Banca Centrale Europea. Che è stato incaricato di formare il nuovo governo al di fuori delle formule e degli schemi sperimentati in questa legislatura sempre più abbinabile a quel maggiolino matto del cinema per le strade di San Francisco.
contagi cui si espongono i passeggeri. Dalla fila, in effetti, si è passati in pochi giorni alla ressa lamentata in rosso dal Fatto Quotidiano davanti alla metaforica porta dell’ex presidente della Banca Centrale Europea. Che è stato incaricato di formare il nuovo governo al di fuori delle formule e degli schemi sperimentati in questa legislatura sempre più abbinabile a quel maggiolino matto del cinema per le strade di San Francisco.
Un fotomontaggio del giornale diretto da Marco Travaglio con le immagini, a scalare da sinistra a destra, di Nicola Zingaretti, i due Mattei -Renzi e Salvini- e Silvio Berlusconi ha cercato di coprire di sarcasmo “il governo di alto profilo” affidato  dal Quirinale alla sartoria, diciamo così, di Draghi. Ma per reticenza manca un attore in quel fotomontaggio: Beppe Grillo. Dal quale Travaglio deve essersi sentito pugnalato come Cesare da Bruto, pur ad età invertita, prima per la lunga telefonata col
dal Quirinale alla sartoria, diciamo così, di Draghi. Ma per reticenza manca un attore in quel fotomontaggio: Beppe Grillo. Dal quale Travaglio deve essersi sentito pugnalato come Cesare da Bruto, pur ad età invertita, prima per la lunga telefonata col  presidente incaricato, poi coll’improvviso viaggio a Roma per cercare di controllare di persona quell’inferno che è diventato il Movimento 5 Stelle e guidarne come “garante”, “elevato” e quant’altro la delegazione con la quale Draghi ha voluto chiudere il suo primo giro di incontri o consultazioni. E ciò nelle sale messegli a disposizione dal presidente, guarda caso grillino, della Camera Roberto Fico, della cui esplorazione Mattarella si è servito per archiviare l’aspirazione di Giuseppe Conte a formare un suo terzo governo, in meno di tre anni, quanti non ne sono ancora passati dalle elezioni del 2018.
presidente incaricato, poi coll’improvviso viaggio a Roma per cercare di controllare di persona quell’inferno che è diventato il Movimento 5 Stelle e guidarne come “garante”, “elevato” e quant’altro la delegazione con la quale Draghi ha voluto chiudere il suo primo giro di incontri o consultazioni. E ciò nelle sale messegli a disposizione dal presidente, guarda caso grillino, della Camera Roberto Fico, della cui esplorazione Mattarella si è servito per archiviare l’aspirazione di Giuseppe Conte a formare un suo terzo governo, in meno di tre anni, quanti non ne sono ancora passati dalle elezioni del 2018.
Ora Conte, per quanto resosi forse disponibile a entrare pure lui nel governo Draghi per continuare ad esserci, come ha promesso dietro al tavolino allestito in tutta fretta in Piazza Colonna, fra Palazzo Chigi e Montecitorio, fa bella mostra di sé fra le statuine in terracotta aggiornate durante la crisi da Genny Di Virgilio, l’artigiano  dell’arte del presepe di via San Gregorio Armeno, nella Napoli di Fico. Per Conte il povero Travaglio aveva progetti più ambiziosi, e se ne sarà sentito tradito non meno che da Grillo, Vito Crimi, Luigi Di Maio e altri ancora votatisi ormai al “suicidio assistito”, che peraltro non mi sembra estraneo alla sensibilità del direttore del giornale sicuramente fra i più letti sotto le cinque stelle.
dell’arte del presepe di via San Gregorio Armeno, nella Napoli di Fico. Per Conte il povero Travaglio aveva progetti più ambiziosi, e se ne sarà sentito tradito non meno che da Grillo, Vito Crimi, Luigi Di Maio e altri ancora votatisi ormai al “suicidio assistito”, che peraltro non mi sembra estraneo alla sensibilità del direttore del giornale sicuramente fra i più letti sotto le cinque stelle.
Temo che Travaglio sia ormai in caduta immunitaria così libera da meritare la precedenza nella campagna di vaccinazione in corso antipandemica. Lo desumo dalla speranza che ha appena espresso  che in un sussulto di dignità, coerenza e chissà cos’altro i grillini, convocati dalla solita piattaforma Rousseau di Davide Casaleggio, facciano ancora in tempo a rifugiarsi almeno nell’astensione verso il governo Draghi e a proporre la nomina dell’ormai pensionato Piercamillo Davigo a ministro della Giustizia, visto che la conferma di Alfonso Bonafede è difficile anche da immaginare. Davigo, si sa, è quello che ritiene gli assolti, nei processi, soltanto scampati ad una più meritata condanna.
che in un sussulto di dignità, coerenza e chissà cos’altro i grillini, convocati dalla solita piattaforma Rousseau di Davide Casaleggio, facciano ancora in tempo a rifugiarsi almeno nell’astensione verso il governo Draghi e a proporre la nomina dell’ormai pensionato Piercamillo Davigo a ministro della Giustizia, visto che la conferma di Alfonso Bonafede è difficile anche da immaginare. Davigo, si sa, è quello che ritiene gli assolti, nei processi, soltanto scampati ad una più meritata condanna.
Ripreso da http://www.startmag.it e http://www.policymakermag.it


 nelle ore successive e scusarsi del divieto impostogli da medici e familiari di muoversi dalla villa in Provenza. Dove la figlia Marina lo ha affettuosamente e metaforicamente chiuso a chiave per proteggerlo dal Covid.
nelle ore successive e scusarsi del divieto impostogli da medici e familiari di muoversi dalla villa in Provenza. Dove la figlia Marina lo ha affettuosamente e metaforicamente chiuso a chiave per proteggerlo dal Covid. con diffidenza che con simpatia, preferendo spesso interloquire direttamente col presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sino a metterlo qualche volta in imbarazzo. Ma, per carità, non ditelo al Cavaliere, convinto di essere stato lui, e soltanto lui, l’artefice di quel trasferimento di Draghi a Francoforte.
con diffidenza che con simpatia, preferendo spesso interloquire direttamente col presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sino a metterlo qualche volta in imbarazzo. Ma, per carità, non ditelo al Cavaliere, convinto di essere stato lui, e soltanto lui, l’artefice di quel trasferimento di Draghi a Francoforte. A proposito del quale Berlusconi non perse un istante per vantarsi di averlo voluto, da presidente esordiente del Consiglio nel 1994, a rappresentare l’Italia con Emma Bonino nella Commissione Europea. Anche Monti era in qualche modo “suo”, e continuava ad esserlo anche dopo essere stato confermato a Bruxelles dai governi successivi, di segno politico opposto.
A proposito del quale Berlusconi non perse un istante per vantarsi di averlo voluto, da presidente esordiente del Consiglio nel 1994, a rappresentare l’Italia con Emma Bonino nella Commissione Europea. Anche Monti era in qualche modo “suo”, e continuava ad esserlo anche dopo essere stato confermato a Bruxelles dai governi successivi, di segno politico opposto. davvero allontanato, col progressivo logoramento del secondo governo di
davvero allontanato, col progressivo logoramento del secondo governo di Giuseppe Conte. E’ un Berlusconi di cui non si capacita -giustamente dal suo punto di vista- il pugnace Marco Travaglio. Che ieri sul Fatto Quotidiano, nervoso anche coi pentastellati refrattari ai suoi consigli e ormai prenotatisi, secondo lui, al “suicidio assistito”, si chiedeva se davvero Draghi e persino Beppe Grillo, con tanto di fotomontaggio, si apprestassero a “governare con lo Psiconano”. Che naturalmente è diventato nel testo dell’editoriale, non bastando il dileggio fisico, il solito “pregiudicato amico dei mafiosi”.
Giuseppe Conte. E’ un Berlusconi di cui non si capacita -giustamente dal suo punto di vista- il pugnace Marco Travaglio. Che ieri sul Fatto Quotidiano, nervoso anche coi pentastellati refrattari ai suoi consigli e ormai prenotatisi, secondo lui, al “suicidio assistito”, si chiedeva se davvero Draghi e persino Beppe Grillo, con tanto di fotomontaggio, si apprestassero a “governare con lo Psiconano”. Che naturalmente è diventato nel testo dell’editoriale, non bastando il dileggio fisico, il solito “pregiudicato amico dei mafiosi”.
 grillini -non si può ancora sapere quanti esattamente- che resistono ancora alla svolta ordinata, autorizzata, suggerita, come preferite, da Beppe Grillo in persona, col supporto del presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte. Che è sceso in piazza a incoraggiare Draghi parlando dietro un tavolino, sullo sfondo di Montecitorio, che forse lo ha fatto scambiare da qualche passante per un venditore di pentole, o di microfoni.
grillini -non si può ancora sapere quanti esattamente- che resistono ancora alla svolta ordinata, autorizzata, suggerita, come preferite, da Beppe Grillo in persona, col supporto del presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte. Che è sceso in piazza a incoraggiare Draghi parlando dietro un tavolino, sullo sfondo di Montecitorio, che forse lo ha fatto scambiare da qualche passante per un venditore di pentole, o di microfoni.  del Corriere Luciano Fontana- ha messo particolarmente in crisi Marco Travaglio. Che sul suo Fatto Quotidiano ha protestato
del Corriere Luciano Fontana- ha messo particolarmente in crisi Marco Travaglio. Che sul suo Fatto Quotidiano ha protestato  nel quale lo ha scritto. Diavoli di amici, non hanno seguito il suo consiglio di opporre a Draghi quel “no cortese ma fermo” che sarebbe stato necessario almeno per salvare un po’ della faccia originaria, dopo tutte le giravolte seguite alle elezioni del 2018.
nel quale lo ha scritto. Diavoli di amici, non hanno seguito il suo consiglio di opporre a Draghi quel “no cortese ma fermo” che sarebbe stato necessario almeno per salvare un po’ della faccia originaria, dopo tutte le giravolte seguite alle elezioni del 2018.  del Consiglio incaricato per salire a bordo del suo governo, secondo lo spietato titolo del manifesto. D’altronde solo gli sprovveduti, nelle condizioni in cui si trova un Paese stretto fra varie emergenze, potevano prevedere qualcosa di diverso da ciò che si sta verificando attorno alla decisione del capo dello Stato di ricorrere alla riserva maggiore della Repubblica. Che solo un pazzo avrebbe potuto
del Consiglio incaricato per salire a bordo del suo governo, secondo lo spietato titolo del manifesto. D’altronde solo gli sprovveduti, nelle condizioni in cui si trova un Paese stretto fra varie emergenze, potevano prevedere qualcosa di diverso da ciò che si sta verificando attorno alla decisione del capo dello Stato di ricorrere alla riserva maggiore della Repubblica. Che solo un pazzo avrebbe potuto  lasciare inoperosa, dopo la storica presidenza della Banca Centrale Europea, nell’ufficio onorifico di governatore emerito della Banca d’Italia o nella lista dei consulenti, o quasi, del Papa come esponente della Pontificia Accademia delle scienze sociali.
lasciare inoperosa, dopo la storica presidenza della Banca Centrale Europea, nell’ufficio onorifico di governatore emerito della Banca d’Italia o nella lista dei consulenti, o quasi, del Papa come esponente della Pontificia Accademia delle scienze sociali.  e all’immagine dei partiti destinati ad appoggiarlo in Parlamento, permettetemi di includere il ritorno del vegliardo Eugenio Scalfari all’interesse per la crisi. Dai cui sviluppi solo qualche giorno fa egli aveva preso a tal punto le distanze da scrivere con toccante sconforto della “fine del viaggio” che avvertiva avvicinandosi la sua 97.ma primavera. La chiamata di Draghi ha felicemente sorpreso pure lui, che si era accontentato di auspicare, prima della sconfortante visione della morte, il ricorso di Mattarella a Paolo Gentiloni, richiamandolo dalla Commissione Europea di Bruxelles. Egli ha ottenuto e visto ben di più.
e all’immagine dei partiti destinati ad appoggiarlo in Parlamento, permettetemi di includere il ritorno del vegliardo Eugenio Scalfari all’interesse per la crisi. Dai cui sviluppi solo qualche giorno fa egli aveva preso a tal punto le distanze da scrivere con toccante sconforto della “fine del viaggio” che avvertiva avvicinandosi la sua 97.ma primavera. La chiamata di Draghi ha felicemente sorpreso pure lui, che si era accontentato di auspicare, prima della sconfortante visione della morte, il ricorso di Mattarella a Paolo Gentiloni, richiamandolo dalla Commissione Europea di Bruxelles. Egli ha ottenuto e visto ben di più.
 vincitore di turno, o addirittura del trionfatore, come potrebbe risultare alla fine di questa crisi di governo il prestigioso Mario Draghi.
vincitore di turno, o addirittura del trionfatore, come potrebbe risultare alla fine di questa crisi di governo il prestigioso Mario Draghi. Casalino, che non ho avuto la ventura di conoscere ma di cui vedo che non basta più lamentare il passato televisivo al “Grande fratello” e l’abitudine, che riconosco nociva per il suo capo, di usare il telefonino come una mezza clava per protestare contro giornalisti e altri ancora spintisi, ai suoi occhi, troppo in avanti con le critiche e gli attacchi al suo “principe” inteso in senso machiavellico.
Casalino, che non ho avuto la ventura di conoscere ma di cui vedo che non basta più lamentare il passato televisivo al “Grande fratello” e l’abitudine, che riconosco nociva per il suo capo, di usare il telefonino come una mezza clava per protestare contro giornalisti e altri ancora spintisi, ai suoi occhi, troppo in avanti con le critiche e gli attacchi al suo “principe” inteso in senso machiavellico. di metri di distanza, nel suo ufficio a Palazzo Chigi, proponendosi di non avere “mai più” rapporti con l’ormai ex alleato, anzi di “asfaltarlo” al Senato con un bel po’ di parlamentari in uscita dalle opposizioni. Alcuni dei quali erano già in sosta nel purgatorio del gruppo misto, in attesa di altri con cui costituire una formazione buona a rendere superflui i voti sino ad allora determinanti dei renziani.
di metri di distanza, nel suo ufficio a Palazzo Chigi, proponendosi di non avere “mai più” rapporti con l’ormai ex alleato, anzi di “asfaltarlo” al Senato con un bel po’ di parlamentari in uscita dalle opposizioni. Alcuni dei quali erano già in sosta nel purgatorio del gruppo misto, in attesa di altri con cui costituire una formazione buona a rendere superflui i voti sino ad allora determinanti dei renziani. Non facciamo Rocco, e i suoi fratelli, disponendo lui di un bel gruppo di collaboratori, più influente di quanto non possa essere stato su un avvocato e un professore non certo degli ultimi, per quanto approdato in politica per caso quasi tre anni fa. E subito in una posizione di rilievo come quella di capo del governo, dopo che i suoi sostenitori non lo avevano programmato per una postazione superiore a quella di un ministro della Funzione Pubblica.
Non facciamo Rocco, e i suoi fratelli, disponendo lui di un bel gruppo di collaboratori, più influente di quanto non possa essere stato su un avvocato e un professore non certo degli ultimi, per quanto approdato in politica per caso quasi tre anni fa. E subito in una posizione di rilievo come quella di capo del governo, dopo che i suoi sostenitori non lo avevano programmato per una postazione superiore a quella di un ministro della Funzione Pubblica. di pendere dalle labbra o dal cellulare, fra o sopra gli altri, di Goffredo Bettini. Che ad un certo punto era diventato nelle cronache giornalistiche, fra retroscena e interviste, un mezzo segretario ombra del Pd: il secondo partito della coalizione di governo e primo della sinistra certificata all’anagrafe politica.
di pendere dalle labbra o dal cellulare, fra o sopra gli altri, di Goffredo Bettini. Che ad un certo punto era diventato nelle cronache giornalistiche, fra retroscena e interviste, un mezzo segretario ombra del Pd: il secondo partito della coalizione di governo e primo della sinistra certificata all’anagrafe politica. sempre di più da Renzi, lo aveva abbandonato al suo destino e incoraggiato Conte a studiare il modo di liberarsene definitivamente, anche a costo di rimanere con un impossibile tavolo a due gambe.
sempre di più da Renzi, lo aveva abbandonato al suo destino e incoraggiato Conte a studiare il modo di liberarsene definitivamente, anche a costo di rimanere con un impossibile tavolo a due gambe. esponenti della direzione, è sembrato alla fine arrendersi ad una realtà sfuggitagli di mano. Egli infatti ha lasciato silenziosamente inserire Bettini negli immancabili articoli sul toto-ministri come un nuovo esponente di un secondo governo Conte rimpastato o di un terzo.
esponenti della direzione, è sembrato alla fine arrendersi ad una realtà sfuggitagli di mano. Egli infatti ha lasciato silenziosamente inserire Bettini negli immancabili articoli sul toto-ministri come un nuovo esponente di un secondo governo Conte rimpastato o di un terzo.
 il manifesto ha
il manifesto ha  Giorgetti. Che vede giustamente nel passaggio di Draghi un’occasione irripetibile per sciacquare nelle acque dell’ex presidente della Banca Centrale Europea, come Alessandro Manzoni nell’Arno per la lingua italiana, il sovranismo ormai logoro o comunque superato della Lega, dopo la svolta solidaristica imposta all’Europa dall’emergenza pandemica.
Giorgetti. Che vede giustamente nel passaggio di Draghi un’occasione irripetibile per sciacquare nelle acque dell’ex presidente della Banca Centrale Europea, come Alessandro Manzoni nell’Arno per la lingua italiana, il sovranismo ormai logoro o comunque superato della Lega, dopo la svolta solidaristica imposta all’Europa dall’emergenza pandemica.  lungo anche per le resistenze alla sua apertura opposte dal presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte. Che ora fa l’offeso, oltre che il deluso, e minaccia di non accettare eventuali offerte del successore, fosse anche quella quasi d’abitudine del Ministero degli Esteri che si fa a chi esce da Palazzo Chigi.
lungo anche per le resistenze alla sua apertura opposte dal presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte. Che ora fa l’offeso, oltre che il deluso, e minaccia di non accettare eventuali offerte del successore, fosse anche quella quasi d’abitudine del Ministero degli Esteri che si fa a chi esce da Palazzo Chigi.  del Secolo XIX, titolata questa volta “Ad occhio e croce” per dire che così, appunto, tornano i conti delle loro posizioni e del loro modo di vedere lo sviluppo in un mondo che dovrebbe fare a meno delle banche e dei banchieri. Proprio oggi sul Fatto Quotidiano il vignettista Vauro Senesi satireggia
del Secolo XIX, titolata questa volta “Ad occhio e croce” per dire che così, appunto, tornano i conti delle loro posizioni e del loro modo di vedere lo sviluppo in un mondo che dovrebbe fare a meno delle banche e dei banchieri. Proprio oggi sul Fatto Quotidiano il vignettista Vauro Senesi satireggia  contro Draghi perché metterebbe “al sicuro la democrazia in banca”. Gli si contrappone sul Riformista l’ex compagno di partito Sergio Staino indicando in Draghi la felice smentita dell’assunto grillino dell’”uno vale uno”.
contro Draghi perché metterebbe “al sicuro la democrazia in banca”. Gli si contrappone sul Riformista l’ex compagno di partito Sergio Staino indicando in Draghi la felice smentita dell’assunto grillino dell’”uno vale uno”.  e scelte in base alle nostre convinzioni, senza pregiudizi né positivi né negativi”. Ma non più tardi di ieri lo stesso Travaglio ha reagito alla notizia dell’incarico a Draghi chiedendo ai grillini e al Pd di opporre “un no gentile”, bontà sua, abituato com’è a insolentire gli interlocutori che non
e scelte in base alle nostre convinzioni, senza pregiudizi né positivi né negativi”. Ma non più tardi di ieri lo stesso Travaglio ha reagito alla notizia dell’incarico a Draghi chiedendo ai grillini e al Pd di opporre “un no gentile”, bontà sua, abituato com’è a insolentire gli interlocutori che non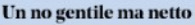 gli piacciono,”ma netto”. Netto come il percorso di sostegno, indirizzo e quant’altro dei grillini, e ora anche del povero Pd, seguito con ostinazione dal Fatto strappato alla memoria dell’inconsapevole e incolpevole Enzo Biagi, titolare di un’omonima e celebre trasmissione televisiva.
gli piacciono,”ma netto”. Netto come il percorso di sostegno, indirizzo e quant’altro dei grillini, e ora anche del povero Pd, seguito con ostinazione dal Fatto strappato alla memoria dell’inconsapevole e incolpevole Enzo Biagi, titolare di un’omonima e celebre trasmissione televisiva.
 ha dovuto eseguire sulla politica commissariandola, come si sono lamentati dalle parti del manifesto, col ricorso a Mario Draghi per chiudere la crisi di governo.
ha dovuto eseguire sulla politica commissariandola, come si sono lamentati dalle parti del manifesto, col ricorso a Mario Draghi per chiudere la crisi di governo. Mattarella ha ribadito di fronte all’esito negativo dell’esplorazione affidata al presidente della Camera. Anziché coinvolgerle, Conte cercò subito di dividere le opposizioni, pensando ai vantaggi che potevano derivarne all’interno del Pd, dove esistevano tendenze più o meno esplicite a coinvolgere Silvio Berlusconi in un gioco utile a cautelarsi dai primi segnali di insofferenza di Matteo Renzi.
Mattarella ha ribadito di fronte all’esito negativo dell’esplorazione affidata al presidente della Camera. Anziché coinvolgerle, Conte cercò subito di dividere le opposizioni, pensando ai vantaggi che potevano derivarne all’interno del Pd, dove esistevano tendenze più o meno esplicite a coinvolgere Silvio Berlusconi in un gioco utile a cautelarsi dai primi segnali di insofferenza di Matteo Renzi. e dal Pd con minore forza. Le riunioni di politici ed esperti erano tanto frequenti quanto inutili, e alla fine neppure più frequenti.
e dal Pd con minore forza. Le riunioni di politici ed esperti erano tanto frequenti quanto inutili, e alla fine neppure più frequenti. ricorrendo allo scioglimento delle Camere e alle elezioni anticipate. La cosa in effetti ha funzionato per un po’ come deterrente a favore di Conte e di una sua ricerca di senatori “responsabili, europeisti, volenterosi” e quant’altro con cui sostituire i renziani nella maggioranza, specialmente al Senato. Dove gli “italoviventi”, dal nome del partito di Renzi, erano e sono rimasti determinanti anche nella votazione di fiducia cercata da Conte dopo le dimissioni delle due ministre fedelissime dell’ex sindaco di Firenze.
ricorrendo allo scioglimento delle Camere e alle elezioni anticipate. La cosa in effetti ha funzionato per un po’ come deterrente a favore di Conte e di una sua ricerca di senatori “responsabili, europeisti, volenterosi” e quant’altro con cui sostituire i renziani nella maggioranza, specialmente al Senato. Dove gli “italoviventi”, dal nome del partito di Renzi, erano e sono rimasti determinanti anche nella votazione di fiducia cercata da Conte dopo le dimissioni delle due ministre fedelissime dell’ex sindaco di Firenze. un’intesa programmatica, ci hanno ripensato sulla promessa del reggente Vito Crimi di soprassedere alle questioni “divisive”, riducendole al solo ricorso ai finanziamenti europei per il rafforzamento del servizio sanitario. E hanno poi opposto barricate quando gli altri hanno sollevato i problemi, per esempio, della giustizia e del troppo costoso reddito di cittadinanza. Ma oltre a questo i pentastellati hanno tentato di blindare i loro ministri più esposti, a cominciare dal guardasigilli Alfonso Bonafede, scambiando la formazione di un nuovo governo per un piccolo e indolore rimpasto di quello dimissionario.
un’intesa programmatica, ci hanno ripensato sulla promessa del reggente Vito Crimi di soprassedere alle questioni “divisive”, riducendole al solo ricorso ai finanziamenti europei per il rafforzamento del servizio sanitario. E hanno poi opposto barricate quando gli altri hanno sollevato i problemi, per esempio, della giustizia e del troppo costoso reddito di cittadinanza. Ma oltre a questo i pentastellati hanno tentato di blindare i loro ministri più esposti, a cominciare dal guardasigilli Alfonso Bonafede, scambiando la formazione di un nuovo governo per un piccolo e indolore rimpasto di quello dimissionario. per un governo di “alto profilo”, ben oltre le formule e gli schieramenti formatisi in questa anomala diciottesima legislatura. A metà del cui percorso sono state bruciate già due maggioranze di segno opposto.
per un governo di “alto profilo”, ben oltre le formule e gli schieramenti formatisi in questa anomala diciottesima legislatura. A metà del cui percorso sono state bruciate già due maggioranze di segno opposto. da quelli del Fatto Quotidiano di “negare il voto sempre evocato”, ha preferito scommettere sulla responsabilità delle Camere attuali, alle cui forze rappresentate ha chiesto di dare la fiducia al governo Conte. D’altronde l’articolo 88 della Costituzione affida alla sola e insindacabile valutazione del presidente della Repubblica la praticabilità delle elezioni anticipate.
da quelli del Fatto Quotidiano di “negare il voto sempre evocato”, ha preferito scommettere sulla responsabilità delle Camere attuali, alle cui forze rappresentate ha chiesto di dare la fiducia al governo Conte. D’altronde l’articolo 88 della Costituzione affida alla sola e insindacabile valutazione del presidente della Repubblica la praticabilità delle elezioni anticipate.
 o il coraggio, come preferite, di affidarne la soluzione al prestigioso Mario Draghi. Che negli otto anni di presidenza della Banca Centrale Europea ha fatto onore a un’Italia pur attraversata da un’ondata antistorica di sovranismo in cui -ricordiamolo bene- si è avuta la crescita non solo della Lega, da qualche parte considerata il male assoluto, specie dopo l’incauta ambizione ai “pieni poteri” confessata da Matteo Salvini, ma anche del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Che è arrivato nel 2018 con più del 32 per cento dei voti al ruolo centrale, in Parlamento, che fu della Democrazia Cristiana.
o il coraggio, come preferite, di affidarne la soluzione al prestigioso Mario Draghi. Che negli otto anni di presidenza della Banca Centrale Europea ha fatto onore a un’Italia pur attraversata da un’ondata antistorica di sovranismo in cui -ricordiamolo bene- si è avuta la crescita non solo della Lega, da qualche parte considerata il male assoluto, specie dopo l’incauta ambizione ai “pieni poteri” confessata da Matteo Salvini, ma anche del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Che è arrivato nel 2018 con più del 32 per cento dei voti al ruolo centrale, in Parlamento, che fu della Democrazia Cristiana.  del governo giallorosso. Che ha potuto giovarsi della paura delle urne – in un Parlamento che già di suo ha un terzo dei seggi soprannumero dopo i tagli voluti dai grillini dalla prossima edizione- per resistere in quella specie di fortilizio in cui Conte aveva trasformato Palazzo Chigi. E addirittura per aprire una campagna, peraltro fallita, di arruolamento di senatori “responsabili, europeisti, volenterosi” e quant’altro sostitutivi degli scomodissimi renziani, infine fuorusciti dal governo. Ciò ha oggettivamente allungato i tempi della crisi e persino intossicato di più i rapporti politici.
del governo giallorosso. Che ha potuto giovarsi della paura delle urne – in un Parlamento che già di suo ha un terzo dei seggi soprannumero dopo i tagli voluti dai grillini dalla prossima edizione- per resistere in quella specie di fortilizio in cui Conte aveva trasformato Palazzo Chigi. E addirittura per aprire una campagna, peraltro fallita, di arruolamento di senatori “responsabili, europeisti, volenterosi” e quant’altro sostitutivi degli scomodissimi renziani, infine fuorusciti dal governo. Ciò ha oggettivamente allungato i tempi della crisi e persino intossicato di più i rapporti politici. con molta franchezza ed efficacia davanti alle telecamere per scartare le elezioni anticipate. E per mettere in pista con Draghi un governo di “alto profilo”, scommettendo sul senso di responsabilità, questa volta vera, del Parlamento chiamato costituzionalmente a dargli la fiducia, al di là delle “formule” e degli schieramenti sviluppatisi in questa legislatura. Alla irresponsabilità, permettetemi
con molta franchezza ed efficacia davanti alle telecamere per scartare le elezioni anticipate. E per mettere in pista con Draghi un governo di “alto profilo”, scommettendo sul senso di responsabilità, questa volta vera, del Parlamento chiamato costituzionalmente a dargli la fiducia, al di là delle “formule” e degli schieramenti sviluppatisi in questa legislatura. Alla irresponsabilità, permettetemi  di dirlo, si sono già prenotati i fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ed altri, per esempio fra i grillini e il solito Fatto Quotidiano,, che anche a Draghi preferirebbero le elezioni anticipate, come se a disporne fossero loro e non il presidente della Repubblica in via esclusiva, per dettato costituzionale e non per capriccio.
di dirlo, si sono già prenotati i fratelli d’Italia di Giorgia Meloni ed altri, per esempio fra i grillini e il solito Fatto Quotidiano,, che anche a Draghi preferirebbero le elezioni anticipate, come se a disporne fossero loro e non il presidente della Repubblica in via esclusiva, per dettato costituzionale e non per capriccio. a disposizione dal Quirinale i compagni di partito dell’esploratore. Essi si sono arroccati su alcuni temi cosiddetti divisivi del programma di un terzo governo Conte e hanno reclamato l’inamovibilità non solo del presidente dimissionario del Consiglio ma anche di alcuni ministri quanto meno logorati, come quelli pentastellati della Giustizia e dell’Istruzione.
a disposizione dal Quirinale i compagni di partito dell’esploratore. Essi si sono arroccati su alcuni temi cosiddetti divisivi del programma di un terzo governo Conte e hanno reclamato l’inamovibilità non solo del presidente dimissionario del Consiglio ma anche di alcuni ministri quanto meno logorati, come quelli pentastellati della Giustizia e dell’Istruzione. 
 durezza o vivacità, ma il destinatario principale delle proteste ha scrollato le spalle, scambiando la signora per una rompiscatole non a caso proveniente dall’opposizione di centrodestra. L’ideale sarebbe stata la provenienza della presidente del Senato dalla Lega di Matteo Salvini o dai fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, e non invece dalla Forza Italia di quel Silvio Berlusconi che in certi passaggi di questa crisi è stato sognato come un possibile liberatore da mezzo Pd a voce alta e da una parte addirittura dei grillini a voce bassissima, quasi impercettibile.
durezza o vivacità, ma il destinatario principale delle proteste ha scrollato le spalle, scambiando la signora per una rompiscatole non a caso proveniente dall’opposizione di centrodestra. L’ideale sarebbe stata la provenienza della presidente del Senato dalla Lega di Matteo Salvini o dai fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, e non invece dalla Forza Italia di quel Silvio Berlusconi che in certi passaggi di questa crisi è stato sognato come un possibile liberatore da mezzo Pd a voce alta e da una parte addirittura dei grillini a voce bassissima, quasi impercettibile.  rospi al movimento che lo ha portato a Palazzo Chigi, quello delle 5 Stelle, ma sarà pur sempre e ancora il presidente del Consiglio, meno ossessionato almeno per qualche mese dal fantasma di Mario Draghi. Che Renzi si prende il gusto ogni tanto di citare ed elogiare in coincidenza con auspici e sollecitazioni di altre parti politiche, compreso il pur odiato Salvini.
rospi al movimento che lo ha portato a Palazzo Chigi, quello delle 5 Stelle, ma sarà pur sempre e ancora il presidente del Consiglio, meno ossessionato almeno per qualche mese dal fantasma di Mario Draghi. Che Renzi si prende il gusto ogni tanto di citare ed elogiare in coincidenza con auspici e sollecitazioni di altre parti politiche, compreso il pur odiato Salvini. 
 di giornalista di dissentire dalle sue analisi, sollecitazioni e giudizi, mi è venuta la pelle d’oca per
di giornalista di dissentire dalle sue analisi, sollecitazioni e giudizi, mi è venuta la pelle d’oca per  l’emozione e la simpatia alle prese con l’articolo in cui Eugenio Scalfari, scrivendo -credo di proposito- per un numero feriale e non domenicale, come d’abitudine, della Repubblica di carta da lui fondata 45 anni fa, ha voluto raccontare ciò che avverte nel momento in cui si sente alla “fine di un viaggio” cominciato per lui quasi 97 anni fa. E mi scuso per questa lunga, lunghissima frase. Che in un’altra occasione avrei accorciata o spezzata con espedienti che non mancano a chi usa scrivere, ma che in questa circostanza lascio come mi è venuta perché tutto rimanga spontaneo nella reazione ad un articolo così toccante e, direi, istruttivo.
l’emozione e la simpatia alle prese con l’articolo in cui Eugenio Scalfari, scrivendo -credo di proposito- per un numero feriale e non domenicale, come d’abitudine, della Repubblica di carta da lui fondata 45 anni fa, ha voluto raccontare ciò che avverte nel momento in cui si sente alla “fine di un viaggio” cominciato per lui quasi 97 anni fa. E mi scuso per questa lunga, lunghissima frase. Che in un’altra occasione avrei accorciata o spezzata con espedienti che non mancano a chi usa scrivere, ma che in questa circostanza lascio come mi è venuta perché tutto rimanga spontaneo nella reazione ad un articolo così toccante e, direi, istruttivo. e quant’altro del bambino, poi ragazzo, poi adolescente avvertendo in questo ritorno al passato “il segno” di un futuro troppo corto. Mi metto, peraltro, nei panni della figlia Donata, con la quale ebbi il piacere di lavorare dirigendo il primo telegiornale dell’allora Fininvest che veniva trasmesso in differita e si chiamava Dentro la notizia. E provo a immaginare e condividere amichevolmente le lacrime che leggendo il padre le saranno venute agli occhi, o che avrà fatto una fatica immane a trattenere.
e quant’altro del bambino, poi ragazzo, poi adolescente avvertendo in questo ritorno al passato “il segno” di un futuro troppo corto. Mi metto, peraltro, nei panni della figlia Donata, con la quale ebbi il piacere di lavorare dirigendo il primo telegiornale dell’allora Fininvest che veniva trasmesso in differita e si chiamava Dentro la notizia. E provo a immaginare e condividere amichevolmente le lacrime che leggendo il padre le saranno venute agli occhi, o che avrà fatto una fatica immane a trattenere. il famoso saggio a quattro mani del leader socialista e di Luciano Pellicani inneggiante al socialismo umanitario e ottocentesco di Pierre Joseph Proudhon, auguro sinceramente a Scalfari di averte avvertito male i segnali sul suo viaggio. E ai suoi lettori di non avere letto né l’ultimo, né il penultimo né uno degli ultimi articoli del fondatore del giornale preferito.
il famoso saggio a quattro mani del leader socialista e di Luciano Pellicani inneggiante al socialismo umanitario e ottocentesco di Pierre Joseph Proudhon, auguro sinceramente a Scalfari di averte avvertito male i segnali sul suo viaggio. E ai suoi lettori di non avere letto né l’ultimo, né il penultimo né uno degli ultimi articoli del fondatore del giornale preferito. ai tempi del Giornale. Di cui cui ero notista politico e poi editorialista, prima della rottura consumatasi per la valutazione di un personaggio -Craxi- su cui Indro finì per riconoscersi curiosamente nel giudizio critico di Eugenio. E quando glielo rinfacciai amichevolmente, diciamo così, Montanelli non fece una piega rispondendomi: “Può capitare”.
ai tempi del Giornale. Di cui cui ero notista politico e poi editorialista, prima della rottura consumatasi per la valutazione di un personaggio -Craxi- su cui Indro finì per riconoscersi curiosamente nel giudizio critico di Eugenio. E quando glielo rinfacciai amichevolmente, diciamo così, Montanelli non fece una piega rispondendomi: “Può capitare”. come quelle con Barbara Spinelli e con Guastavo Zagrebelsky. E prima ancora egli aveva intrecciato con l’allora segretario del Pd e presidente del Consiglio rapporti di consulenza, diciamo così, culturale indicandogli i libri da leggere e controllandone gli effetti con appositi interrogatori, come un maestro con l’allievo.
come quelle con Barbara Spinelli e con Guastavo Zagrebelsky. E prima ancora egli aveva intrecciato con l’allora segretario del Pd e presidente del Consiglio rapporti di consulenza, diciamo così, culturale indicandogli i libri da leggere e controllandone gli effetti con appositi interrogatori, come un maestro con l’allievo. Chigi, dallo stesso Gentiloni consegnato nel 2018 a Giuseppe Conte con risultati evidentemente inferiori alle aspettative del fondatore di Repubblica. Ma sembra che per la testa dei signori della crisi, compreso l’esploratore della crisi Roberto Fico, per quanto Gentiloni calzi a pennello col problema dell’utilizzo dei fondi comunitari della ripresa, urgente quanto quello della lotta al Covid, passino ben altre idee o progetti.
Chigi, dallo stesso Gentiloni consegnato nel 2018 a Giuseppe Conte con risultati evidentemente inferiori alle aspettative del fondatore di Repubblica. Ma sembra che per la testa dei signori della crisi, compreso l’esploratore della crisi Roberto Fico, per quanto Gentiloni calzi a pennello col problema dell’utilizzo dei fondi comunitari della ripresa, urgente quanto quello della lotta al Covid, passino ben altre idee o progetti.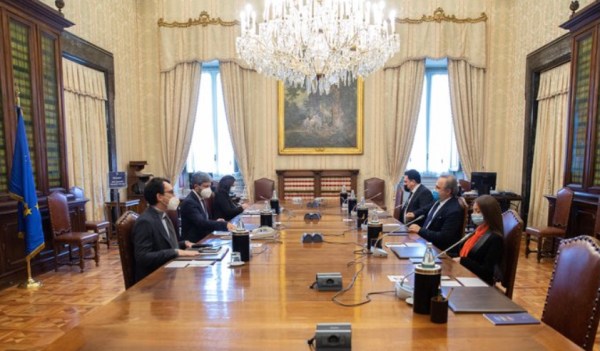
 ormai a “dribblare la Costituzione” secondo Michele Ainis su Libero, non aveva molta voglia di trattenerli, anche se ogni tanto mostrava il contrario solo per cortesia verso il presidente della Repubblica prodigatosi, come al solito, in consigli alla prudenza, al dialogo, al confronto e a tutte quelle altre che la buonanima di Amintore Fanfani chiamava “parole magiche” accusando Aldo Moro, l’altro “cavallo di razza” della Democrazia Cristiana, di farne troppo uso per rendere “irreversibile” la scelta del centro-sinistra.
ormai a “dribblare la Costituzione” secondo Michele Ainis su Libero, non aveva molta voglia di trattenerli, anche se ogni tanto mostrava il contrario solo per cortesia verso il presidente della Repubblica prodigatosi, come al solito, in consigli alla prudenza, al dialogo, al confronto e a tutte quelle altre che la buonanima di Amintore Fanfani chiamava “parole magiche” accusando Aldo Moro, l’altro “cavallo di razza” della Democrazia Cristiana, di farne troppo uso per rendere “irreversibile” la scelta del centro-sinistra.  l’allora presidente aretino del Senato aveva offerto una sponda, pur avendo preceduto Moro nella politica dell’apertura a sinistra mentre ancora durava l’esperienza del centrismo di tradizione degasperiana. Era stato lui, Fanfani, a formare nel 1960, dopo la caduta di Fernando Tambroni nelle piazze, il primo governo sostenuto esternamente con l’astensione dal Psi di Pietro Nenni.
l’allora presidente aretino del Senato aveva offerto una sponda, pur avendo preceduto Moro nella politica dell’apertura a sinistra mentre ancora durava l’esperienza del centrismo di tradizione degasperiana. Era stato lui, Fanfani, a formare nel 1960, dopo la caduta di Fernando Tambroni nelle piazze, il primo governo sostenuto esternamente con l’astensione dal Psi di Pietro Nenni.  uscente affidata dal capo dello Stato al presidente della Camera. Che, prima di mettere oggi tutti attorno allo stesso tavolo per discutere del programma, ha regolarmente
uscente affidata dal capo dello Stato al presidente della Camera. Che, prima di mettere oggi tutti attorno allo stesso tavolo per discutere del programma, ha regolarmente incontrato i “sedotti e abbandonati”, appunto, di quell’area europeista, moderata ed ex grillina cui il presidente del Consiglio si era rivolto nelle settimane scorse per cercare di liberarsi dai condizionamenti di Renzi, e di spaccargli pure partito e gruppi parlamentari per ridurlo alla inconsistenza politica. L’operazione, come si sa, è miseramente fallita tra aspetti anche di una certa comicità, come il senatore uscito e rientrato in Forza Italia dalla sera alla mattina, o la senatrice Alessandrina Lonardo, moglie di Clemente Mastella, che non ha aderito al gruppo autonomo allestito apposta a Palazzo Madama dal sottosegretario agli Esteri Riccardo Merlo, del Movimento associativo degli italiani all’estero (Maie), per
incontrato i “sedotti e abbandonati”, appunto, di quell’area europeista, moderata ed ex grillina cui il presidente del Consiglio si era rivolto nelle settimane scorse per cercare di liberarsi dai condizionamenti di Renzi, e di spaccargli pure partito e gruppi parlamentari per ridurlo alla inconsistenza politica. L’operazione, come si sa, è miseramente fallita tra aspetti anche di una certa comicità, come il senatore uscito e rientrato in Forza Italia dalla sera alla mattina, o la senatrice Alessandrina Lonardo, moglie di Clemente Mastella, che non ha aderito al gruppo autonomo allestito apposta a Palazzo Madama dal sottosegretario agli Esteri Riccardo Merlo, del Movimento associativo degli italiani all’estero (Maie), per l’assenza di “Noi campani”, la formazione di famiglia, dall’intestazione limitata agli “europeisti”, al Maie e al “Centro democratico” di
l’assenza di “Noi campani”, la formazione di famiglia, dall’intestazione limitata agli “europeisti”, al Maie e al “Centro democratico” di  Bruno Tabacci. Che proviene come Mastella dalla Dc e, più in particolare, dalla sinistra demitiana chiamata “Base”, ma non è molto gradito -da quel che si è capito- al sindaco di Benevento. Sono cose che capitano, specie nelle diaspore.
Bruno Tabacci. Che proviene come Mastella dalla Dc e, più in particolare, dalla sinistra demitiana chiamata “Base”, ma non è molto gradito -da quel che si è capito- al sindaco di Benevento. Sono cose che capitano, specie nelle diaspore.  rianimazioni poi tentate da reduci e simili. Ed ho capito il fastidio che mostra un ex democristiano o ancora democristiano doc come Pier Ferdinando Casini ogni volta che parla di questi “amici” alle televisioni o ai giornali che lo intervistano da senatore indipendente rieletto l’ultima volta nelle liste del Pd nella sua Bologna.
rianimazioni poi tentate da reduci e simili. Ed ho capito il fastidio che mostra un ex democristiano o ancora democristiano doc come Pier Ferdinando Casini ogni volta che parla di questi “amici” alle televisioni o ai giornali che lo intervistano da senatore indipendente rieletto l’ultima volta nelle liste del Pd nella sua Bologna.