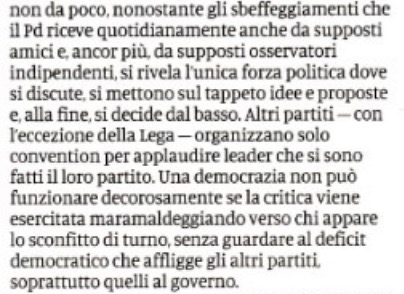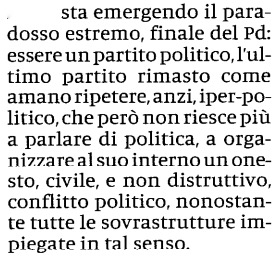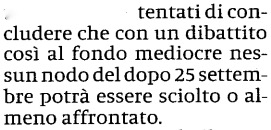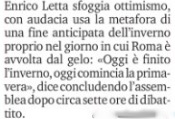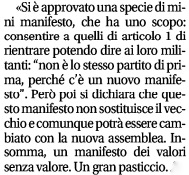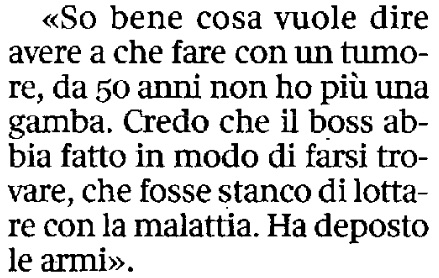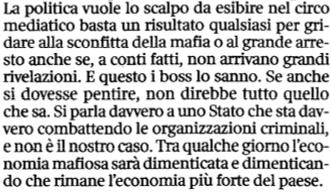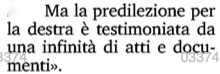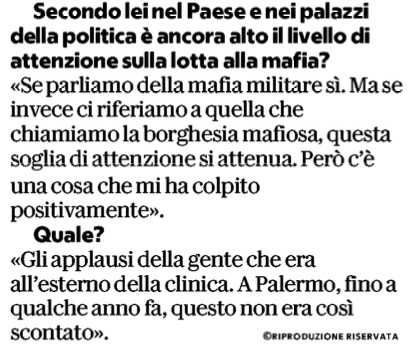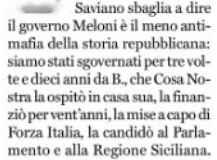Ho molto esitato prima di decidermi a scrivere della fiction televisiva sul prefetto di Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa morto sul campo della lotta alla mafia –Il nostro generale- sentendomi un pò parte in causa per il torto che ritengo gli sia stato fatto. E ciò pur tra i tanti meriti giustamente riconosciutigli, specie quelli acquisti nella lotta alle brigate rosse e poi sommersi, nella memoria, dalle emozioni per il tragico esito della sua ultima missione al servizio dello Stato.
Mi sono alla fine deciso a scriverne con un compromesso con me stesso: quello di non raccontare come e perché sono parte interessata all’omissione che ho avvertito nella ricostruzione degli ultimi mesi, direi anche giorni di vita del generale. Che non furono contrassegnati soltanto dagli incresciosi rapporti polemici col ministro democristiano dell’Interno Virginio Rognoni, un pò renitente ai maggiori poteri che il prefetto rivendicava per svolgere al massimo delle sue capacità le funzioni finalizzate alla lotta alla mafia. Nei cui riguardi il generale temeva di apparire debole, nonostante il prestigio di cui godeva nel Paese: debole, ripeto, ma soprattutto solo. Che è la condizione peggiore in cui si possa trovare un combattente contro la criminalità organizzata di quel tipo.
In questa ricerca persino “ossessiva” di maggiori poteri -come una volta si lasciò scappare lo stesso Rognoni parlandone col presidente del Consiglio Giovanni Spadolini- il prefetto chiese ed ottenne anche l’aiuto mediatico di Giorgio Bocca con quell’intervista a Repubblica opportunamente ricostruita e valorizzata nella fiction televisiva. Che, purtroppo per il generale, finì però per ottenere l’effetto opposto a Roma perché al Viminale ebbero la sensazione di un eccesso di personalizzazione del problema.

Ebbene, proprio in quei giorni, e in quelli immediatamente successivi, oltre che per i suoi poteri personalie per le misure legislative che avrebbero dovuto supportarli, il generale si prodigò perché fosse sperimentata un’applicazione alla lotta alla mafia della legislazione cosiddetta premiale adottata con successo nella lotta al terrorismo. Che non si sarebbe certamente vinta senza il contributo dei pentiti, a cominciare dal più famoso che fu Patrizio Peci. Il quale peraltro, destinato a perdere barbaramente per ritorsione il fratello Roberto, era stato convinto a parlare proprio dal generale dalla Chiesa. Che si vantava di averlo convinto, dopo la cattura, parlandogli -diceva ai sottoposti- “da militare a militare”. E rivelandogli le scorrettezze e persino i tradimenti riservatigli dai compagni di lotta.

Nel sostenere l’adozione di una legislazione premiale anche per i pentiti di mafia, sopraggiunta di molto alla morte del generale ma completamente ignorata nella fiction televisiva chissà per quale ragione, il prefetto avvertiva tuttavia il rischio -date le diverse condizioni sociali in cui i due fenomeni si erano sviluppati e operavano, i terroristi peraltro tenendosi ben lontani dalla Sicilia- di non ripetere l’esperienza di chi, pur avendo parlato senza legislazione premiale, era finito in manicomio. E il prefetto ne fece anche il nome: il palermitano Leonardo Vitale , consegnatosi nel 1973, all’età di 32 anni, nelle mani dell’allora commissario di Polizia Bruno Contrada confessando due omicidi e il tentativo di un terzo.
Il primo pentito di mafia consentì con le sue rivelazioni una quarantina di arresti, ma il processo o i processi che ne conseguirono si conclusero fallimentarmente per lui. Gli accusati furono assolti per l’ancora fortissima omertà che copriva i mafiosi, e lui condannato a 25 anni di carcere, in gran parte scontati in manicomi criminali perché considerato pazzo.
L’ultima detenzione di Vitale, proveniente da Barcellona Pozzo di Gotto, fu a Parma. Da dove uscì nel 1984, circa due anni dopo l’assassinio del prefetto di Palermo. Ma ne uscì per poco perché la mafia si vendicò del suo ormai lontano tradimento, dagli effetti giudiziari peraltro contenuti, uccidendolo il 12 dicembre, prima che l’anno della liberazione passasse. Fu un’esecuzione di pena per la vittima, in applicazione delle leggi della mafia, e un avvertimento per gli altri intenzionati ad avvalersi delle norme premiali avvertite come probabili e sostenute dal generale. Che però aveva saputo seminare abbastanza nel pur poco tempo trascorso a Palermo da prefetto, e ancor più altrove nella lotta al terrorismo, per far crescere il pentitismo, pur nelle degenerazioni prodotte -bisogna ammetterlo- da una cattiva gestione del fenomeno. All’ombra del quale , con uomini ben diversi dalla stazza morale di Carlo Alberto dalla Chiesa, sono accadute nell’intreccio fra politica e mafia, o fra cronache giudiziarie e politiche, cose da pazzi: di una follia vera, non quella attribuita al povero Leonardo Vitale.
Pubblicato sul Dubbio