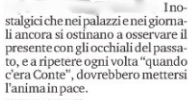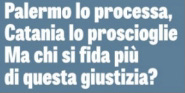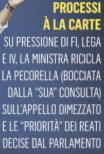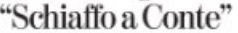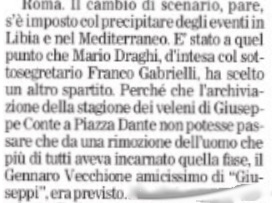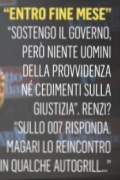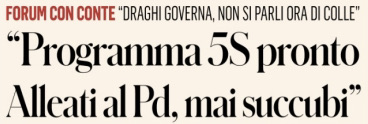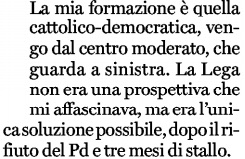Se non a Berlino, rileggendo Bertolt Brecht o Enrico Broglio, secondo altri, Silvio Berlusconi ha trovato un giudice a Strasburgo leggendo più modestamente oggi sul Corriere della Sera Giovanni Bianconi. Che riferisce della decisione presa pur con molto comodo dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo di non ritenere infondato il ricorso presentato nel 2014 dai difensori dell’ex presidente del Consiglio contro la condanna definitiva per frode fiscale. Che gli aveva procurato l’anno prima la pratica dei servizi sociali, sostitutiva di tre anni di detenzione, e la decadenza da senatore, per non parlare delle implicazioni politiche. Esse furono la spaccatura del Pdl nel governo di Enrico Letta, l’indebolimento della maggioranza faticosamente formatasi all’inizio della legislatura e nel 2014 la crisi azionata dal nuovo segretario del Pd Matteo Renzi. Che peraltro succedendo a Letta non avvertì alcun imbarazzo a concordare col “pregiudicato”, decaduto e quant’altro Berlusconi un percorso di riforme addirittura costituzionale ed elettorale.
Nel togliere la polvere dal fascicolo giudiziario del 2014, a dimostrazione -dirà qualche magistrato contrario alla riforma del processo penale- che i tempi della giustizia non sono troppo lunghi solo in Italia, la Corte di Strasburgo ha chiesto al governo italiano di rispondere entro il 15 settembre a dieci domande per chiarire bene se Berlusconi ebbe più di sette anni fa un processo davvero giusto, col rispetto di tutti i diritti della sua difesa, e non subì invece forzature o violazioni funzionali alla sua condanna. Fra cui, per esempio, il rifiuto di alcune testimonianze, il mancato riconoscimento dell’impedimento a partecipare ad alcune udienze che pertanto dovevano essere rinviate, con effetti sulla prescrizione, e altro ancora.

Non dimentichiamo infine che sulla credibilità, diciamo così, della sentenza definitiva di condanna emessa da una sezione feriale -cioè estiva- della Cassazione, pesa una confessione registrata del giudice relatore, il compianto Amedeo Franco, di una decisione presa praticamente per partito preso.
Forse, per carità, a metà settembre il governo Draghi e, più in particolare, la Guardasigilli Marta Cartabia risponderanno alla Corte di Strasburgo difformemente da quanto si aspettino i difensori di Berlusconi, ma è ugualmente significativo, a dir poco, che alla Corte europea siano sorti quanto meno dei dubbi sul trattamento riservato all’ex presidente del Consiglio, nel frattempo “riabilitato”, eletto al Parlamento europeo e partecipe della maggioranza di governo in Italia, preferito dal Pd e forse persino dai grillini ad altri partner come Matteo Salvini.
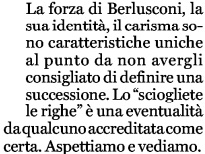

Ironia della sorte, questa “svolta”, come l’ha definita il Corriere riferendo del giudice trovato dal Cavaliere a Strasburgo, è stata “bucata” -come si dice in gergo tecnico- sulla prima pagina del Giornale di famiglia nel giorno in cui, accomiatandosi dalla direzione perché attirato da altre avventure professionali, Alessandro Sallusti ha espresso la convinzione che “prima o poi la storia riconoscerà a Berlusconi i meriti” che gli spettano “in tutti i campi” in cui si è cimentato come “uno dei due o tre straordinari uomini che il nostro secolo ci ha regalato”. Che poi sarebbero due: il Novecento e il Duemila, durante i quali l’unico errore commesso da Berlusconi, secondo la sua sondaggista di fiducia Alessandra Ghisleri in una intervista al Fatto Quotidiano, sarebbe quello di non avere “definito una successione”, tanto si ritiene unico nel suo “carisma”.
Ripreso da http://www.startmag.it e http://www.policymakermag.it