Anche se il figlio Marco in una lettera agli azionisti della sua Gedit ne ha appena voluto rivendicare leadership coprendo il 20 per cento del mercato editoriale, la serietà della crisi della Repubblica di carta fondata nel 1976 da Eugenio Scalfari è rimasta scolpita nello scontro improvviso e durissimo fra Carlo De Benedetti e i suoi discendenti. Che, a cominciare dal primogenito Rodolfo, sono stati accusati dall’anziano ma ancora vitalissimo genitore di scarsa o nessuna passione e competenza nella gestione dell’azienda editoriale a loro ceduta negli anni scorsi.
Non è stato il primo, e credo che non sarà neppure l’ultimo scontro tra genitori e figli nel mondo imprenditoriale. E merita -a mio avviso- tutto il rispetto dovuto a simili vicende, senza sguazzare nello sciacallaggio, come purtroppo ho visto fare in questa occasione da qualche giornale interessato a trarne vantaggio per cercare di risalire dalle posizioni attuali, pensando di avere occupato o di potere occupare le posizioni politiche ed editoriali che Repubblica avrebbe lasciato o, peggio ancora, tradito. Non faccio nomi, né di testate né di direttori, per carità professionale, diciamo così.
Ogni giornale che entra in crisi, o l’aggrava, o chiude e scompare dalle edicole, che già diminuiscono per effetto delle difficoltà dell’intero settore editoriale, è una perdita per la libertà d’informazione e di opinione cui tutti dovremmo tenere, a prescindere dalla tutela garantita dalla Costituzione. E che recentemente, per esempio con l’attacco a Radio Radicale, ho visto minacciata persino da un governo, fortunatamente caduto almeno sotto questo profilo.
Sarebbe tuttavia un errore liquidare la crisi di Repubblica – come ho avvertito tra le righe della stessa sofferenza, o insofferenza, di Carlo De Benedetti in precedenti sortite televisive, e persino nel documento diffuso dalla redazione del giornale giustamente preoccupata della sua sorte e desiderosa di rassicurazioni- al direttore che ha avuto la sventura, prima ancora della responsabilità, di avere ereditato o di avere mantenuto durante tutta o una parte della sua avventura perdite più o meno consistenti di copie. Non ho mai avuto il piacere di conoscere, e tanto meno di lavorare, con Mario Calabresi, ma trovo ingeneroso il trattamento riservatogli nel brusco licenziamento da lui stesso raccontato con una franchezza neppure tanto recriminatoria che gli fa onore.
La Repubblica, come altre testate analoghe, paga gli effetti di un certo modo di fare e di creare i giornali, e di gestirli conseguentemente. I giornali non possono fare e tanto meno sostituirsi ai partiti senza condannarsi all’effimero o alla instabilità della politica, specie ora che sono cadute, o si ritiene che siano cadute le ideologie, e i partiti proliferano come funghi dopo la pioggia.
Eugenio Scalfari -non se ne vorrà se lo ricordo- fondò il suo quotidiano nel 1976 anche o soprattutto per reazione alla nascita, due anni prima, del Giornale fondato da Indro Montanelli contro la deriva di sinistra che egli avvertì nel Corriere della Sera con il passaggio della direzione da Giovanni Spadolini a Piero Ottone.
per reazione alla nascita, due anni prima, del Giornale fondato da Indro Montanelli contro la deriva di sinistra che egli avvertì nel Corriere della Sera con il passaggio della direzione da Giovanni Spadolini a Piero Ottone.
Ho lavorato a lungo dall’esordio al Giornale, e non da semplice cronista. So bene, quindi, di che cosa sto scrivendo. Uscimmo per contrastare  i progetti d’alleanza politica, e persino d’intese parziali o eccezionali, fra la Dc e il Pci come antipasto del “compromesso storico” teorizzato da Enrico Berlinguer nel 1973 per evitare -egli scrisse- alternative di sinistra alla maniera del Cile, dove il potere finì nelle mani dei generali e nel sangue.
i progetti d’alleanza politica, e persino d’intese parziali o eccezionali, fra la Dc e il Pci come antipasto del “compromesso storico” teorizzato da Enrico Berlinguer nel 1973 per evitare -egli scrisse- alternative di sinistra alla maniera del Cile, dove il potere finì nelle mani dei generali e nel sangue.
In occasione delle campagne elettorali segnalavamo ai lettori i partiti per cui votare e, al loro interno, essendoci le preferenze, i candidati più affidabili. Montanelli ruppe col suo amico di lunga data Ugo La Malfa, dandogli del matto e rifiutandogli la mia testa, che il leader repubblicano aveva chiesto per un articolo in cui avevo raccontato di un suo incontro con alcuni corrispondenti di giornali stranieri da Roma, per avere considerato “inevitabile”, ed anche utile, un momentaneo accordo con i comunisti. Che fu poi realizzato nel 1976 con la formula della “solidarietà nazionale” e l’appoggio dei comunisti ad un governo monocolore democristiano affidato astutamente all’uomo dello scudo crociato forse più lontano dal Pci, che era Giulio Andreotti. E che non si sentì molto a disagio, diciamo così, nel ruolo affidatogli in particolare da Aldo Moro, il presidente della Dc che sembrava destinato a diventare due anni dopo capo dello Stato., alla scadenza del mandato di Giovanni Leone. E vi sarebbe sicuramente riuscito se non fosse stato nel frattempo sequestrato, fra il sangue della sua scorta sgominata in via Fani il 16 marzo 1978, e infine ucciso pure lui, dopo 55 giorni di drammatica prigionia.
Fu proprio nel 1976, alla vigilia o in vista della stagione della “solidarietà nazionale”, che Scalfari fece uscire la sua Repubblica, sostenendo la linea opposta a quella del Giornale, e rischiando la chiusura, fra il dispiacere -ve lo assicuro- di Montanelli, sino a quando non intervenne a salvarlo come editore proprio Carlo De Benedetti. Che dopo molti anni avrebbe avuto il cattivo gusto di rinfacciare a Scalfari la “pacchettata” di soldi versatigli per diventare appunto il suo editore.
Nello scontro avuto adesso con i figli, lasciandosi intervistare da Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, l’ormai ex editore deciso a riprendersi in qualche modo la sua creatura per evitare che i figli la vendano, secondo lui, a chi ne farebbe un cattivo uso, ha orgogliosamente detto che “tante cose sono avvenute su Repubblica, e tante sono avvenute a causa di Repubblica”. E’ vero. Non è possibile dargli torto. Decisivo, per esempio, ancor più del Giornale di Montanelli, dove ad un certo punto dovetti andarmene in ferie per non condividerne la linea, fu l’apporto di Repubblica alla “fermezza” imposta al governo e alla Dc dal Pci di Berlinguer, ma anche dal Pri di La Malfa, alla gestione del sequestro Moro.
Altrettanto decisivo, e infine condizionante anche per il Giornale di Montanelli, dal quale proprio per questo ce ne andammo nel 1983 Enzo Bettiza e io, fu l’anticraxismo di Repubblica. Che sin dall’arrivo del segretario socialista a Palazzo Chigi ne anticipò o auspicò la crisi un giorno sì e l’altro pure, sino a quando il segretario della Dc Ciriaco De Mita non si decise ad accontentarla sfrattandolo nel 1987 per andare alle elezioni anticipate.
I giornali-partito o di Palazzo, come preferite, hanno finito così per svuotare e infine uccidere, assorbendone lettori e personale, specie per quanto riguardava Repubblica, dotata di maggiori mezzi ed anche -perché negarlo?- di maggiore fantasia e capacità gestionale, i giornali di partito che facevano il loro onesto e trasparente lavoro: dall’Avanti all’Unitò, dal Popolo alla Giustizia, dalla Voce Repubblicana a Liberazione. Ma ciò, con l’aiuto della maggiore enfasi e penetrazione elettronica e quant’alltro, era destinato, come si è visto proprio con la clamorosa ammissione di De Benedetti nello scontro con i figli, a non portare fortuna ai giornali. E neppure ai partiti, visto come sono ridotti anche loro, ancor peggio dei giornali che spesso cercano di pilotarli. Per cui può accadere, per esempio, a Davide
loro, ancor peggio dei giornali che spesso cercano di pilotarli. Per cui può accadere, per esempio, a Davide  Casaleggio -in curiosa coincidenza con le voci o notizie che gli attribuiscono resistenze o scetticismo sull’alleanza col Pd- di ritrovarsi oggetto di un’inchiesta giornalistica da “fuoco amico”, condotta da un giornale non certo ostile ai grillini, sui reali o potenziali “conflitti d’interesse” derivanti da consulenze per “centinaia di migliaia di euro” fornite a “lobby del tabacco, delle scommesse e dei trasporti” usualmente o geneticamente “contestati” dal Movimento delle 5 Stelle.
Casaleggio -in curiosa coincidenza con le voci o notizie che gli attribuiscono resistenze o scetticismo sull’alleanza col Pd- di ritrovarsi oggetto di un’inchiesta giornalistica da “fuoco amico”, condotta da un giornale non certo ostile ai grillini, sui reali o potenziali “conflitti d’interesse” derivanti da consulenze per “centinaia di migliaia di euro” fornite a “lobby del tabacco, delle scommesse e dei trasporti” usualmente o geneticamente “contestati” dal Movimento delle 5 Stelle.
Pubblicato su Il Dubbio
Ripreso da http://www.startmag.it il 26 ottobre 2019


 nei pre-vertici, vertici e quant’altro svoltisi nelle ultime 24 ore a Palazzo Chigi e dintorni alla ricerca, da parte di Giuseppe Conte, di una composizione dei contrasti nella maggioranza
nei pre-vertici, vertici e quant’altro svoltisi nelle ultime 24 ore a Palazzo Chigi e dintorni alla ricerca, da parte di Giuseppe Conte, di una composizione dei contrasti nella maggioranza  giallorossa sulla manovra finanziaria. Che è peraltro la stessa sulla quale dalla Commissione dell’Unione Europea sono stati chiesti chiarimenti eufemisticamente definiti tecnici, cioè sui “numeri”. Ma che il vignettista del Secolo XIX Stefano Rolli ha tradotto, con la solita ironia coniugata con la chiarezza, in questa domanda: “Chi comanda lì da voi?”.
giallorossa sulla manovra finanziaria. Che è peraltro la stessa sulla quale dalla Commissione dell’Unione Europea sono stati chiesti chiarimenti eufemisticamente definiti tecnici, cioè sui “numeri”. Ma che il vignettista del Secolo XIX Stefano Rolli ha tradotto, con la solita ironia coniugata con la chiarezza, in questa domanda: “Chi comanda lì da voi?”. Prima Repubblica: quella seguita all’esperienza degasperiana di centro e contrassegnata dal centro-sinistra, col trattino, di Amintore Fanfani, Aldo Moro, Mariano Rumor, che sostituirono nella maggioranza e poi nel governo i liberali con i socialisti, prima che gli uni e gli altri si ritrovassero insieme, grazie a Craxi, nelle edizioni del già citato pentapartito.
Prima Repubblica: quella seguita all’esperienza degasperiana di centro e contrassegnata dal centro-sinistra, col trattino, di Amintore Fanfani, Aldo Moro, Mariano Rumor, che sostituirono nella maggioranza e poi nel governo i liberali con i socialisti, prima che gli uni e gli altri si ritrovassero insieme, grazie a Craxi, nelle edizioni del già citato pentapartito. 
 l’Italia che Matteo Renzi si è proposto di guidare, e sulla quale vola come un gabbiano nel simbolo che i militanti hanno scelto per il nuovo movimento, ma l’ex segretario del Pd, ex presidente del Consiglio, ex sindaco di Firenze, ex “senatore semplice di Scandicci”, visto che adesso è uno dei soci decisivi dalla nuova maggioranza giallorossa di governo, almeno a Palazzo Madama, dove i numeri sono notoriamente avari per qualsiasi combinazione ministeriale; il tante volte ex, dicevo, ha voluto chiudere il raduno della ormai sua “Leopolda” chiudendo gli occhi.
l’Italia che Matteo Renzi si è proposto di guidare, e sulla quale vola come un gabbiano nel simbolo che i militanti hanno scelto per il nuovo movimento, ma l’ex segretario del Pd, ex presidente del Consiglio, ex sindaco di Firenze, ex “senatore semplice di Scandicci”, visto che adesso è uno dei soci decisivi dalla nuova maggioranza giallorossa di governo, almeno a Palazzo Madama, dove i numeri sono notoriamente avari per qualsiasi combinazione ministeriale; il tante volte ex, dicevo, ha voluto chiudere il raduno della ormai sua “Leopolda” chiudendo gli occhi.  a prendersela col Matteo Salvini esasperatamente sovranista, antieuropeista, l’uomo insomma del Papeete. Così lo chiama Renzi inchiodandolo alllo stabilimento balnerare che gli è, tutto sommato, costato il Ministero dell’Interno, e tutto ciò che il Viminale rappresentava per la sua Lega.
a prendersela col Matteo Salvini esasperatamente sovranista, antieuropeista, l’uomo insomma del Papeete. Così lo chiama Renzi inchiodandolo alllo stabilimento balnerare che gli è, tutto sommato, costato il Ministero dell’Interno, e tutto ciò che il Viminale rappresentava per la sua Lega.  appena definito “lo spariglio” di Salvini. Il quale usando lo stesso Foglio digerita la crisi d’agosto, ha fatto “professione di fedeltà all’euro”, per usare sempre le parole di Maroni: un euro definito “irreversibile”, anzi gridato come tale perché tutti lo potessero ascoltare, a cominciare -ha avvertito Salvini- dai leghisti ancora tentati di parlarne alla vecchia maniera, utile appunto alla propaganda dei suoi avversari. A capo dei quali Renzi vorrebbe rimanere perché è nel suo interesse farlo, anche se “l’ostilità” fra i mondi dell’Italia Viva e della Coalizione degli italiani, come Salvini ha appena anticipato al Corriere della Sera di voler chiamare la nuova edizione del centrodestra che ha preso corpo davanti alla Basilica capitolina di San Giovanni, più che reale è forse solo “apparente”. Che è l’aggettivo usato proprio da Maroni sul Foglio per descrivere lo scontro fra i due Mattei della politica italiana.
appena definito “lo spariglio” di Salvini. Il quale usando lo stesso Foglio digerita la crisi d’agosto, ha fatto “professione di fedeltà all’euro”, per usare sempre le parole di Maroni: un euro definito “irreversibile”, anzi gridato come tale perché tutti lo potessero ascoltare, a cominciare -ha avvertito Salvini- dai leghisti ancora tentati di parlarne alla vecchia maniera, utile appunto alla propaganda dei suoi avversari. A capo dei quali Renzi vorrebbe rimanere perché è nel suo interesse farlo, anche se “l’ostilità” fra i mondi dell’Italia Viva e della Coalizione degli italiani, come Salvini ha appena anticipato al Corriere della Sera di voler chiamare la nuova edizione del centrodestra che ha preso corpo davanti alla Basilica capitolina di San Giovanni, più che reale è forse solo “apparente”. Che è l’aggettivo usato proprio da Maroni sul Foglio per descrivere lo scontro fra i due Mattei della politica italiana.  scorso, proprio mentre rischiava di perdere Palazzo Chigi, e con tutti gli abiti che indossa celebrando defunti di ogni colore politico, proponendosi ai cattolici come continuatore di Aldo Moro e alla sinistra come promotore di una “rivoluzione culturale” di memoria maoista, potremmo ben trovarcelo sul palcoscenico del 2022, alla scadenza del mandato di Mattarella, come candidato al Quirinale. Renzi non avrebbe l’età, prima ancora dei voti. Tanto meno Di Maio.
scorso, proprio mentre rischiava di perdere Palazzo Chigi, e con tutti gli abiti che indossa celebrando defunti di ogni colore politico, proponendosi ai cattolici come continuatore di Aldo Moro e alla sinistra come promotore di una “rivoluzione culturale” di memoria maoista, potremmo ben trovarcelo sul palcoscenico del 2022, alla scadenza del mandato di Mattarella, come candidato al Quirinale. Renzi non avrebbe l’età, prima ancora dei voti. Tanto meno Di Maio. 
 domenica prossima -di cui peraltro ha voluto allo stesso tempo testimoniare l’importanza ed escludere un valore di test per la maggioranza giallorossa riprodottasi sul posto attorno ad una candidatura civica alla presidenza- che “chi non fa squadra è fuori dal governo”. Sono state e sono parole francamente al vento, pronunciate peraltro dopo che lo stesso Conte aveva dovuto accettare la richiesta di un vertice della maggioranza avanzata da Di Maio come capo ancora del suo movimento dopo un incontro con i ministri pentastellati. Che il capo ancòra del movimento aveva chiamato a rapporto per farsi raccontare bene, per filo e per segno, la riunione del governo sulla manovra finanziaria approvata con “riserva d’intesa”, cui lui non aveva potuto partecipare perché impegnato col capo dello Stato nella visita alla Casa Bianca.
domenica prossima -di cui peraltro ha voluto allo stesso tempo testimoniare l’importanza ed escludere un valore di test per la maggioranza giallorossa riprodottasi sul posto attorno ad una candidatura civica alla presidenza- che “chi non fa squadra è fuori dal governo”. Sono state e sono parole francamente al vento, pronunciate peraltro dopo che lo stesso Conte aveva dovuto accettare la richiesta di un vertice della maggioranza avanzata da Di Maio come capo ancora del suo movimento dopo un incontro con i ministri pentastellati. Che il capo ancòra del movimento aveva chiamato a rapporto per farsi raccontare bene, per filo e per segno, la riunione del governo sulla manovra finanziaria approvata con “riserva d’intesa”, cui lui non aveva potuto partecipare perché impegnato col capo dello Stato nella visita alla Casa Bianca.  Che, diversamente dalla rassegnazione di Eugenio Scalfari, su Repubblica, a vivere in “un Purgatorio senza Paradiso”,
Che, diversamente dalla rassegnazione di Eugenio Scalfari, su Repubblica, a vivere in “un Purgatorio senza Paradiso”,  si è chiesto se “si può continuare così”. E, di fronte ad “uno spettacolo per alcuni aspetti suicida” ha smesso di elogiare o scommettere sulle doti di “mediatore” del presidente del Consiglio, al quale piuttosto ha rimproverato di avere annunciato “una rivoluzione che non c’è” con la manovra finanziaria contestata, evidentemente non a torto, o almeno non del tutto a torto, da Di Maio e Renzi.
si è chiesto se “si può continuare così”. E, di fronte ad “uno spettacolo per alcuni aspetti suicida” ha smesso di elogiare o scommettere sulle doti di “mediatore” del presidente del Consiglio, al quale piuttosto ha rimproverato di avere annunciato “una rivoluzione che non c’è” con la manovra finanziaria contestata, evidentemente non a torto, o almeno non del tutto a torto, da Di Maio e Renzi.  socio della sua maggioranza Matteo Renzi completava a Firenze i riti leopoldini della formazione della sua Italia Viva vestendola di un simbolo, o bandiera, e faceva liquidare anche lui il Pd, al pari del Cavaliere, come “il partito delle tasse”.
socio della sua maggioranza Matteo Renzi completava a Firenze i riti leopoldini della formazione della sua Italia Viva vestendola di un simbolo, o bandiera, e faceva liquidare anche lui il Pd, al pari del Cavaliere, come “il partito delle tasse”. 
 con più entusiasmo, impegno e quant’altro sostiene Conte: Il Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio. Che, oltre a minimizzare con un richiamino la “provocazione”, cioè l’autorete, di Beppe Grillo in persona sul diritto di voto da togliere agli anziani, presumibilmente sopra gli 80 anni, avendone il comico 71 e volendo forse continuare a votare ancora per un po’, ha dovuto montare la prima pagina contro la indigesta coppia Di Maio-Renzi, in ordine rigorosamente alfabetico, uniti praticamente nella difesa degli evasori dalla guerra dichiarata loro da un Conte smanioso di mandarli tutti in galera, o ammanettati negli stadi, vista la insufficienza delle prigioni esistenti in Italia già per altri reati, figuriamoci per questo.
con più entusiasmo, impegno e quant’altro sostiene Conte: Il Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio. Che, oltre a minimizzare con un richiamino la “provocazione”, cioè l’autorete, di Beppe Grillo in persona sul diritto di voto da togliere agli anziani, presumibilmente sopra gli 80 anni, avendone il comico 71 e volendo forse continuare a votare ancora per un po’, ha dovuto montare la prima pagina contro la indigesta coppia Di Maio-Renzi, in ordine rigorosamente alfabetico, uniti praticamente nella difesa degli evasori dalla guerra dichiarata loro da un Conte smanioso di mandarli tutti in galera, o ammanettati negli stadi, vista la insufficienza delle prigioni esistenti in Italia già per altri reati, figuriamoci per questo.  di Roma il sabato si raccoglie l’umido”. O si dovrebbe raccogliere, visto lo stato in cui la sindaca pentastellata Virginia Raggi, anch’essa molto cara al Fatto Quotidiano, che la difende in ogni occasione possibile e impossibile, ha ridotto la città e, in particolare, il settore di quella che una volta si chiamava Nettezza Urbana, oggi più propriamente Monnezza Urbana, per non dire peggio.
di Roma il sabato si raccoglie l’umido”. O si dovrebbe raccogliere, visto lo stato in cui la sindaca pentastellata Virginia Raggi, anch’essa molto cara al Fatto Quotidiano, che la difende in ogni occasione possibile e impossibile, ha ridotto la città e, in particolare, il settore di quella che una volta si chiamava Nettezza Urbana, oggi più propriamente Monnezza Urbana, per non dire peggio.
 non so se al telefono o a quattr’occhi davvero egli ha detto testualmente: “Oggi parte una rivoluzione culturale”. Che, consultando Wikipedia per la dannata abitudine presa navigando in internet, ci porta dritto a quella di Mao nel decennio trascorso fra il 1966 e il 1976.
non so se al telefono o a quattr’occhi davvero egli ha detto testualmente: “Oggi parte una rivoluzione culturale”. Che, consultando Wikipedia per la dannata abitudine presa navigando in internet, ci porta dritto a quella di Mao nel decennio trascorso fra il 1966 e il 1976.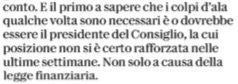 nelle ultime settimane”, e “non solo a causa della legge finanziaria”, approvata peraltro -ripeto- con la consueta “riserva d’intesa”, senza bisogno -ha poi avvertito lo stesso capo del governo- di farla ripassare per un’altra riunione del Consiglio dei Ministri, come invece si aspettava qualche componente della maggioranza, Che ha reagito alla precisazione di Conte annunciando o rafforzando il proposito di rivalersi in Parlamento con la solita scorribanda degli emendamenti.
nelle ultime settimane”, e “non solo a causa della legge finanziaria”, approvata peraltro -ripeto- con la consueta “riserva d’intesa”, senza bisogno -ha poi avvertito lo stesso capo del governo- di farla ripassare per un’altra riunione del Consiglio dei Ministri, come invece si aspettava qualche componente della maggioranza, Che ha reagito alla precisazione di Conte annunciando o rafforzando il proposito di rivalersi in Parlamento con la solita scorribanda degli emendamenti. scorse settimane il nuovo governo, nel salotto televisivo di Lilli Gruber, prima ancora di vederlo all’opera. Per valutarlo gli era evidentemente bastato osservarne il modo in cui era nato, con quella che uno dei suoi stessi artefici, Matteo Renzi, ha imprudentemente definito, nello scontro televisivo con Salvini a Porta a Porta, “un’operazione machiavellica di palazzo”. Per favore, con la minuscola, anche se l’ex segretario del Pd, ex presidente del Consiglio, ex sindaco di Firenze e ora leader di Italia Viva pensava alla maiuscola, vantandosene col capo della Lega.
scorse settimane il nuovo governo, nel salotto televisivo di Lilli Gruber, prima ancora di vederlo all’opera. Per valutarlo gli era evidentemente bastato osservarne il modo in cui era nato, con quella che uno dei suoi stessi artefici, Matteo Renzi, ha imprudentemente definito, nello scontro televisivo con Salvini a Porta a Porta, “un’operazione machiavellica di palazzo”. Per favore, con la minuscola, anche se l’ex segretario del Pd, ex presidente del Consiglio, ex sindaco di Firenze e ora leader di Italia Viva pensava alla maiuscola, vantandosene col capo della Lega.
 ministro dei beni culturali e capo della delegazione piddina nel secondo governo di Giuseppe Conte, o Bisconte. E’ proprio lui: quello che, prima ancora della svolta di Matteo Renzi già in procinto peraltro di andarsene dal partito, aveva proposto nel Pd di offrirsi a Grillo per sostituire la Lega e il suo truce capitano.
ministro dei beni culturali e capo della delegazione piddina nel secondo governo di Giuseppe Conte, o Bisconte. E’ proprio lui: quello che, prima ancora della svolta di Matteo Renzi già in procinto peraltro di andarsene dal partito, aveva proposto nel Pd di offrirsi a Grillo per sostituire la Lega e il suo truce capitano. candidandosi alle primarie per la successione a Franceschini. Il quale, informato del progetto dallo stesso Grillo a mezzo stampa, ovviamente non gradì. Ancor meno gradì Pier Luigi Bersani, deciso a subentrargli, come poi avvenne, per rimettere a posto a suo modo “la ditta”, come il simpatico emiliano chiamava il partito dai tempi del Pci.
candidandosi alle primarie per la successione a Franceschini. Il quale, informato del progetto dallo stesso Grillo a mezzo stampa, ovviamente non gradì. Ancor meno gradì Pier Luigi Bersani, deciso a subentrargli, come poi avvenne, per rimettere a posto a suo modo “la ditta”, come il simpatico emiliano chiamava il partito dai tempi del Pci. inutilmente aiuto per la formazione di un governo “di minoranza e combattimento”, e battendo clamorosamente cinque anni dopo il Pd dell'”ebetino” Renzi, cui nel frattempo aveva già fatto perdere il referendum sulla riforma costituzionale.
inutilmente aiuto per la formazione di un governo “di minoranza e combattimento”, e battendo clamorosamente cinque anni dopo il Pd dell'”ebetino” Renzi, cui nel frattempo aveva già fatto perdere il referendum sulla riforma costituzionale.
 numerosi dei lettori del Fatto Quotidiano, nella consapevolezza di un Travaglio forse proprio per questo più agitato- ripeto- del solito, vi dirò che mi ha stupito la gravità con la quale l’ha recepito e raccontato su tutta la sua prima pagina il pur smaliziato Libero di Vittorio Feltri col titolo “Botte da orbi”. Ma quali botte?
numerosi dei lettori del Fatto Quotidiano, nella consapevolezza di un Travaglio forse proprio per questo più agitato- ripeto- del solito, vi dirò che mi ha stupito la gravità con la quale l’ha recepito e raccontato su tutta la sua prima pagina il pur smaliziato Libero di Vittorio Feltri col titolo “Botte da orbi”. Ma quali botte?  un fuoco a salve, per fare rumore più che per farsi davvero del male.
un fuoco a salve, per fare rumore più che per farsi davvero del male. 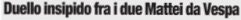 Renzi e Salvini -sempre in ordine rigorosamente alfabetico, anche se i rapporti di forza parlamentari sono rovesciati, per non parlare di quelli elettorali solo perché il toscano non si è ancora misurato nelle urne con la sua Italia Viva- sono due furbi della Madonna, con tutte le scuse che la Madonna
Renzi e Salvini -sempre in ordine rigorosamente alfabetico, anche se i rapporti di forza parlamentari sono rovesciati, per non parlare di quelli elettorali solo perché il toscano non si è ancora misurato nelle urne con la sua Italia Viva- sono due furbi della Madonna, con tutte le scuse che la Madonna  ha il diritto di chiedermi e di ottenere. Essi hanno in fondo bisogno l’uno dell’altro per vivere e crescere politicamente, e all’occorrenza anche per
ha il diritto di chiedermi e di ottenere. Essi hanno in fondo bisogno l’uno dell’altro per vivere e crescere politicamente, e all’occorrenza anche per mettersi insieme, come si sono ritrovati nello stesso duello televisivo reclamando le dimissioni e la liquidazione della sindaca pentastellata di Roma Virginia Raggi. Cui invece Zingaretti, sia in veste di segretario del Pd per non compromettere i rapporti con i grillini, sia in veste di presidente della regione Lazio per non cadere anzitempo, ha mostrato di voler dare una mano.
mettersi insieme, come si sono ritrovati nello stesso duello televisivo reclamando le dimissioni e la liquidazione della sindaca pentastellata di Roma Virginia Raggi. Cui invece Zingaretti, sia in veste di segretario del Pd per non compromettere i rapporti con i grillini, sia in veste di presidente della regione Lazio per non cadere anzitempo, ha mostrato di voler dare una mano.  “irreversibile”, pubblicata sul Foglio con una insofferenza neppure tanto nascosta dal fondatore Giuliano Ferrara. Che, tanto per tenere il punto contro il “Truce”, con la maiuscola, pur riconoscendo a Salvini di avere parlato in “renzismo purissimo”, ha dovuto il giorno dopo firmare il proprio dissenso addirittura dal compianto Winston Churchill. Che, da Machiavelli in salsa britannica, alla luce anche della propria non disprezzabile e lunga carriera politica, definì “una dieta molto nutriente” quella della “parola rimangiata”.
“irreversibile”, pubblicata sul Foglio con una insofferenza neppure tanto nascosta dal fondatore Giuliano Ferrara. Che, tanto per tenere il punto contro il “Truce”, con la maiuscola, pur riconoscendo a Salvini di avere parlato in “renzismo purissimo”, ha dovuto il giorno dopo firmare il proprio dissenso addirittura dal compianto Winston Churchill. Che, da Machiavelli in salsa britannica, alla luce anche della propria non disprezzabile e lunga carriera politica, definì “una dieta molto nutriente” quella della “parola rimangiata”. 
 professore si è calato con la solita scientificità nei panni del cattolico impegnato in politica.
professore si è calato con la solita scientificità nei panni del cattolico impegnato in politica.  Egli non ha avvertito alcun imbarazzo a parlare davanti a quello che l’inviato del Corriere della Sera Francesco Verderami ha felicemente chiamato “il sinedrio ex Dc”, composto da Ciriaco De Mita, Nicola Mancino, Gerardo Bianco, Giuseppe Gargani e naturalmente Rotondi, il più entusiasta alla fine dell’intervento, spiacente solo di non poter consegnare all’ospite la tessera della Dc perché il partito non c’è più. E Conte gli ha risparmiato il dispiacere di ricordargli che il posto dello scudo crociato, o della “Balena Bianca”, secondo Giampaolo Pansa, ritiene di averlo ormai preso proprio il movimento grillino, non foss’altro per la cosiddetta centralità della sua forza parlamentare, salvata dal presidente della Repubblica nella crisi d’agosto fidandosi della nuova maggioranza giallorossa e scartando la strada delle elezioni anticipate su cui Salvini si era imprudentemente già avviato con comizi anche sulle spiagge.
Egli non ha avvertito alcun imbarazzo a parlare davanti a quello che l’inviato del Corriere della Sera Francesco Verderami ha felicemente chiamato “il sinedrio ex Dc”, composto da Ciriaco De Mita, Nicola Mancino, Gerardo Bianco, Giuseppe Gargani e naturalmente Rotondi, il più entusiasta alla fine dell’intervento, spiacente solo di non poter consegnare all’ospite la tessera della Dc perché il partito non c’è più. E Conte gli ha risparmiato il dispiacere di ricordargli che il posto dello scudo crociato, o della “Balena Bianca”, secondo Giampaolo Pansa, ritiene di averlo ormai preso proprio il movimento grillino, non foss’altro per la cosiddetta centralità della sua forza parlamentare, salvata dal presidente della Repubblica nella crisi d’agosto fidandosi della nuova maggioranza giallorossa e scartando la strada delle elezioni anticipate su cui Salvini si era imprudentemente già avviato con comizi anche sulle spiagge.  Berlusconi in persona alla manifestazione organizzata da Salvini contro il governo per sabato prossimo nella storica piazza romana della sinistra, a San Giovanni, che “se sarà necessario faremo qualcosa perché resti a lungo premier”.
Berlusconi in persona alla manifestazione organizzata da Salvini contro il governo per sabato prossimo nella storica piazza romana della sinistra, a San Giovanni, che “se sarà necessario faremo qualcosa perché resti a lungo premier”.  Il quale, pur temendo che possa essere aiutato “dalla miseria di ciò che lo circonda”, e riconoscendogli la qualità del “ragazzo furbo”, ha mandato a Conte uno dei suoi messaggi urticanti. “Se si sale spesso su un palco senza avere la memoria del suono si rischia solo di fare rumore”, ha detto ammonendolo a non improvvisare troppo. Per uno che si era appena fatto riprendere come direttore d’orchestra, a pochi metri di distanza, diciamo così, non è stato proprio un augurio. Lo è stato alla maniera, appunto, di De Mita.
Il quale, pur temendo che possa essere aiutato “dalla miseria di ciò che lo circonda”, e riconoscendogli la qualità del “ragazzo furbo”, ha mandato a Conte uno dei suoi messaggi urticanti. “Se si sale spesso su un palco senza avere la memoria del suono si rischia solo di fare rumore”, ha detto ammonendolo a non improvvisare troppo. Per uno che si era appena fatto riprendere come direttore d’orchestra, a pochi metri di distanza, diciamo così, non è stato proprio un augurio. Lo è stato alla maniera, appunto, di De Mita. 
 collaborazione politica, come ha appena fatto in una lunga ed anche toccante intervista a Walter Veltroni sul Corriere della Sera. La difficoltà nasce dalla conoscenza personale che ho avuto della particolarità del loro rapporto. Che era simile per certi versi a quello che il leader socialista aveva con Silvio Berlusconi.
collaborazione politica, come ha appena fatto in una lunga ed anche toccante intervista a Walter Veltroni sul Corriere della Sera. La difficoltà nasce dalla conoscenza personale che ho avuto della particolarità del loro rapporto. Che era simile per certi versi a quello che il leader socialista aveva con Silvio Berlusconi. onorevole soluzione della crisia favore di Giulio Andreotti. Che peraltro era in quel momento il suo ministro degli Esteri, con reciproca stima e amicizia seguite agli anni in cui Craxi sognava la “volpe” Andreotti in “pellicceria”: magari, quella situata nel piano sottostante a quello dell’ufficio dello stesso Andreotti in Piazza San Lorenzo in Lucina.
onorevole soluzione della crisia favore di Giulio Andreotti. Che peraltro era in quel momento il suo ministro degli Esteri, con reciproca stima e amicizia seguite agli anni in cui Craxi sognava la “volpe” Andreotti in “pellicceria”: magari, quella situata nel piano sottostante a quello dell’ufficio dello stesso Andreotti in Piazza San Lorenzo in Lucina. in Parlamento. “Che ti frega di tenerti Andreotti per un anno” a Palazzo Chigi di fronte a queste concessioni ?, ha raccontato Martelli di avere detto in quell’occasione a Craxi, peraltro seccato che lui si fosse “occupato” della crisi.
in Parlamento. “Che ti frega di tenerti Andreotti per un anno” a Palazzo Chigi di fronte a queste concessioni ?, ha raccontato Martelli di avere detto in quell’occasione a Craxi, peraltro seccato che lui si fosse “occupato” della crisi. del Consiglio e lo scioglimento anticipato delle Camere, il cui mandato ordinario scadeva l’anno successivo. Le elezioni furono gestite da un governo monocolore democristiano di Amintore Fanfani cui i deputati del suo partito negarono la fiducia, astenendosi, perché il presidente della Repubblica Francesco Cossiga non potesse sottrarsi al dovere di trarne le conseguenze sciogliendo le Camere. Lo ricordo per la cronaca, o per la storia con la minuscola, perché quella con la maiuscola non dovrebbe neppure contemplare una vicenda così poco ortodossa, a dir poco, sul piano istituzionale e persino etico.
del Consiglio e lo scioglimento anticipato delle Camere, il cui mandato ordinario scadeva l’anno successivo. Le elezioni furono gestite da un governo monocolore democristiano di Amintore Fanfani cui i deputati del suo partito negarono la fiducia, astenendosi, perché il presidente della Repubblica Francesco Cossiga non potesse sottrarsi al dovere di trarne le conseguenze sciogliendo le Camere. Lo ricordo per la cronaca, o per la storia con la minuscola, perché quella con la maiuscola non dovrebbe neppure contemplare una vicenda così poco ortodossa, a dir poco, sul piano istituzionale e persino etico.