Inseguito di nuovo dal segretario del Pd in persona Nicola Zingaretti, questa volta senza che si scomodasse pure Matteo Renzi, Dario Franceschini si è fermamente proposto di coinvolgere i grillini anche a livello locale per strappare ad una temuta vittoria del centrodestra a trazione leghista, al netto di quel che bolle nella pentola di Silvio Berlusconi, le regioni storiche della sinistra dove si voterà nei prossimi mesi, a cominciare dal 27 ottobre in Umbria. Dove la debolezza del Pd è aggravata dalle disavventure giudiziarie, a dir poco, in cui è incorsa l’amministrazione uscente nella gestione della sanità.
Per quanto i rapporti col capo -ancòra- del movimento delle 5 stelle Luigi Di Maio siano facilitati dal fatto che adesso partecipino entrambi allo stesso governo, lui come ministro dei beni  culturali e capo della delegazione del Pd e l’altro non più vice presidente del Consiglio e pluriministro ma pur sempre ministro degli Esteri, quotidianamente sfottuto in internet per le sue gaffe in geografia e rapporti internazionali, Franceschini non ha raccolto risultati concreti. La diffidenza dell’interlocutore, ma anche la spregiudicata disinvoltura e franchezza del battistrada ormai del Pd sono state ben rappresentate sulla vignetta del Foglio. Che li rappresenta su una panchina in corteggiamento politico non ancora concluso, né nelle intenzioni di Franceschini né forse nelle chiusure momentanee di Di Maio. Che non vorrebbe esagerare sulla strada delle provocazioni alla base del suo movimento, per quanto abbia sinora disposto al momento opportuno del soccorso di Davide Casaleggio sulla sua piattaforma elettronica Rousseau, Ma Di Maio conosce anche bene la posta in gioco per il Pd, che è troppo alta perché lui possa aggirarla del tutto, o a cuor leggero.
culturali e capo della delegazione del Pd e l’altro non più vice presidente del Consiglio e pluriministro ma pur sempre ministro degli Esteri, quotidianamente sfottuto in internet per le sue gaffe in geografia e rapporti internazionali, Franceschini non ha raccolto risultati concreti. La diffidenza dell’interlocutore, ma anche la spregiudicata disinvoltura e franchezza del battistrada ormai del Pd sono state ben rappresentate sulla vignetta del Foglio. Che li rappresenta su una panchina in corteggiamento politico non ancora concluso, né nelle intenzioni di Franceschini né forse nelle chiusure momentanee di Di Maio. Che non vorrebbe esagerare sulla strada delle provocazioni alla base del suo movimento, per quanto abbia sinora disposto al momento opportuno del soccorso di Davide Casaleggio sulla sua piattaforma elettronica Rousseau, Ma Di Maio conosce anche bene la posta in gioco per il Pd, che è troppo alta perché lui possa aggirarla del tutto, o a cuor leggero.
Un collasso del Pd a livello locale metterebbe in guai irrimediabili Zingaretti e lo stesso Franceschini, già vittima recentemente di un rovescio nella sua Ferrara. Esso si porterebbe appresso il governo e, questa volta, davvero la legislatura appena salvata nella crisi di agosto col repentino cambiamento di maggioranza e la rivalutazione, da parte dei grillini, persino di Renzi. Che, dal canto suo, non si sta facendo coinvolgere più di tanto dal nuovo corso che pure ha voluto. Egli ha infatti ripreso a tessere, se mai aveva smesso di farlo, la tela di una sua uscita dal Pd per creare un’area di centro con l’aiuto di un ritorno al sistema elettorale proporzionale, dopo tutto il male che se n’è detto per una trentina d’anni, sino ad addebitargli la colpa dell’ingente debito pubblico italiano per via dei governi spendaccioni succedutisi alla sua ombra nella cosiddetta prima Repubblica.
Le difficoltà locali del Pd sono dimostrate dalle ultime notizie provenienti dall’Umbria e non a caso raccolte e rilanciate dal Fatto Quotidiano. Sono in corso di studio espedienti per facilitare un ripensamento o riallineamento dei grillini.  Ai quali, in particolare, si offrirebbe la rinuncia del Pd a presentarsi in proprio, col simbolo e il nome, per coprirsi dietro qualche soluzione “civica”. I candidati “indipendenti” alla presidenza della regione da schierare contro Donatella Tesei, messa in campo da Salvini, che ha cominciato con largo anticipo la sua campagna elettorale sul posto, sarebbe il pur recalcitrante “re del cachemire” Brunello Cucinelli o l’ex presidente della Confcooperative regionali Andrea Fora, un cattolico molto ben visto o introdotto nella Chiesa locale.
Ai quali, in particolare, si offrirebbe la rinuncia del Pd a presentarsi in proprio, col simbolo e il nome, per coprirsi dietro qualche soluzione “civica”. I candidati “indipendenti” alla presidenza della regione da schierare contro Donatella Tesei, messa in campo da Salvini, che ha cominciato con largo anticipo la sua campagna elettorale sul posto, sarebbe il pur recalcitrante “re del cachemire” Brunello Cucinelli o l’ex presidente della Confcooperative regionali Andrea Fora, un cattolico molto ben visto o introdotto nella Chiesa locale.
Ripreso da http://www.startmag,it e policymakermag.it


 le notizie giunte dalla capitale belga, e dell’Unione Europea, non sono proprio
le notizie giunte dalla capitale belga, e dell’Unione Europea, non sono proprio  incoraggianti per chi si aspettava e si aspetta un grande cambiamento di passo, ora che nel governo italiano accanto ai grillini non ci sono più i leghisti del sovranista Matteo Salvini ma il Pd e la sinistra radicale dei “liberi e uguali” Massimo D’Alema, Pier Luigi Bersani, Pietro Grasso e via rosseggiando.
incoraggianti per chi si aspettava e si aspetta un grande cambiamento di passo, ora che nel governo italiano accanto ai grillini non ci sono più i leghisti del sovranista Matteo Salvini ma il Pd e la sinistra radicale dei “liberi e uguali” Massimo D’Alema, Pier Luigi Bersani, Pietro Grasso e via rosseggiando.  un presidente del Consiglio costretto ad “accantonare” nella sua missione bruxellese la riforma del cosiddetto patto di stabilità chiesta, ipotizzata e quant’altro nelle dichiarazioni programmatiche alle Camere. E anche il nuovo commissario agli affari economici della Commissione Europea presieduta dall’ex ministra tedesca della Difesa, l’italiano Paolo Gentiloni, potrà praticare e chiedere per Roma una “flessibilità” molto relativa con tutti gli occhi vigilanti che ha addosso, a cominciare da quelli del vice presidente “esecutivo”, il rigorista lettone Valdis Dombrovskis, messogli sopra deliberatamente, per quanto Conte abbia scorto smagliature fra le sue deleghe.
un presidente del Consiglio costretto ad “accantonare” nella sua missione bruxellese la riforma del cosiddetto patto di stabilità chiesta, ipotizzata e quant’altro nelle dichiarazioni programmatiche alle Camere. E anche il nuovo commissario agli affari economici della Commissione Europea presieduta dall’ex ministra tedesca della Difesa, l’italiano Paolo Gentiloni, potrà praticare e chiedere per Roma una “flessibilità” molto relativa con tutti gli occhi vigilanti che ha addosso, a cominciare da quelli del vice presidente “esecutivo”, il rigorista lettone Valdis Dombrovskis, messogli sopra deliberatamente, per quanto Conte abbia scorto smagliature fra le sue deleghe. 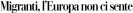 anche su questo terreno, è stato invece avvertito da Conte sul fronte dell’immigrazione negli incontri con gli uscenti ed entranti vertici comunitari, visto che si ì avventurato a parlare poi con i giornalisti di multe ed altre penalità da poter applicare ai paesi dell’Unione che dovessero sottrarsi ad una equa distribuzione di quanti continueranno a sbarcare sulle coste italiane.
anche su questo terreno, è stato invece avvertito da Conte sul fronte dell’immigrazione negli incontri con gli uscenti ed entranti vertici comunitari, visto che si ì avventurato a parlare poi con i giornalisti di multe ed altre penalità da poter applicare ai paesi dell’Unione che dovessero sottrarsi ad una equa distribuzione di quanti continueranno a sbarcare sulle coste italiane. 
 si ricandidò di fatto al Quirinale nel 1991, per quanto avesse litigato un po’ con tutti nella fase conclusiva del suo mandato, quella delle “picconate”, offrendosi come un presidente di transizione e di garanzia per accompagnare la legislatura che sarebbe nata nel 1992 sulla strada di un’ampia e radicale riforma costituzionale, di stampo persino presidenziale. Ma ciò bastò e avanzò per sbarrargli ancora di più le porte di una rielezione. Che egli aveva un po’ furbescamente cercato di aprirsi anche con la improvvisa decisione di anticipare di qualche settimana, con le dimissioni, la conclusione del suo primo mandato per risparmiarsi la gestione della crisi di governo in apertura della nuova legislatura: una gestione che, in linea con gli accordi raggiunti già prima del voto fra democristiani e socialisti, lo avrebbe costretto a dare l’incarico di presidente del Consiglio all’amico Bettino Craxi, odiatissimo dai comunisti e già lambito dalle indagini giudiziarie su Tangentopoli.
si ricandidò di fatto al Quirinale nel 1991, per quanto avesse litigato un po’ con tutti nella fase conclusiva del suo mandato, quella delle “picconate”, offrendosi come un presidente di transizione e di garanzia per accompagnare la legislatura che sarebbe nata nel 1992 sulla strada di un’ampia e radicale riforma costituzionale, di stampo persino presidenziale. Ma ciò bastò e avanzò per sbarrargli ancora di più le porte di una rielezione. Che egli aveva un po’ furbescamente cercato di aprirsi anche con la improvvisa decisione di anticipare di qualche settimana, con le dimissioni, la conclusione del suo primo mandato per risparmiarsi la gestione della crisi di governo in apertura della nuova legislatura: una gestione che, in linea con gli accordi raggiunti già prima del voto fra democristiani e socialisti, lo avrebbe costretto a dare l’incarico di presidente del Consiglio all’amico Bettino Craxi, odiatissimo dai comunisti e già lambito dalle indagini giudiziarie su Tangentopoli. e dalle fallite scalate di Franco Marini e di Romano Prodi al Colle più alto di Roma, cercò di animare o rianimare come costituente la legislatura cominciata così affannosamente. Egli lo fece con un discorso persino sferzante alle Camere in occasione della conferma al vertice dello Stato. Le difficoltà incontrate su questa strada dal governo delle cosiddette larghe intese presieduto da Enrico Letta e l’irruenza con la quale Matteo Renzi lo sostituì resero Napolitano ancora più diffidente di quanto l’età avanzata non gli suggerisse di suo e lo indussero alla rinuncia, due anni dopo, per conclamate ragioni di stanchezza fisica.
e dalle fallite scalate di Franco Marini e di Romano Prodi al Colle più alto di Roma, cercò di animare o rianimare come costituente la legislatura cominciata così affannosamente. Egli lo fece con un discorso persino sferzante alle Camere in occasione della conferma al vertice dello Stato. Le difficoltà incontrate su questa strada dal governo delle cosiddette larghe intese presieduto da Enrico Letta e l’irruenza con la quale Matteo Renzi lo sostituì resero Napolitano ancora più diffidente di quanto l’età avanzata non gli suggerisse di suo e lo indussero alla rinuncia, due anni dopo, per conclamate ragioni di stanchezza fisica. propria stagione costituente come peggio non si poteva, francamente: con la bocciatura referendaria, nel 2016, della sua riforma costituzionale, e poi con la scissione e la durissima sconfitta del Pd nelle elezioni politiche dell’anno scorso.
propria stagione costituente come peggio non si poteva, francamente: con la bocciatura referendaria, nel 2016, della sua riforma costituzionale, e poi con la scissione e la durissima sconfitta del Pd nelle elezioni politiche dell’anno scorso. d’accordo con l’opposizione guidata da Silvio Berlusconi. Ebbene, prima naufragò la commissione e poi il governo del professore emiliano, sostituito acrobaticamente proprio da D’Alema con un cambio di maggioranza subitaneo, grazie al soccorso degli “straccioni” transfughi del centrodestra arruolati con orgogliosa baldanza da Cossiga.
d’accordo con l’opposizione guidata da Silvio Berlusconi. Ebbene, prima naufragò la commissione e poi il governo del professore emiliano, sostituito acrobaticamente proprio da D’Alema con un cambio di maggioranza subitaneo, grazie al soccorso degli “straccioni” transfughi del centrodestra arruolati con orgogliosa baldanza da Cossiga. varando una riforma della Costituzione di stampo federalista, almeno a parole. Che però fu bocciata nel 2006 dopo una campagna referendaria condotta da Oscar Luigi Scalfaro, che già dal Quirinale, come presidente della Repubblica, aveva dato filo da torcere al Cavaliere di Arcore.
varando una riforma della Costituzione di stampo federalista, almeno a parole. Che però fu bocciata nel 2006 dopo una campagna referendaria condotta da Oscar Luigi Scalfaro, che già dal Quirinale, come presidente della Repubblica, aveva dato filo da torcere al Cavaliere di Arcore.
 del quotidiano la Repubblica– l’impegno di assegnare nella nuova Commissione la delega degli affari economici all’italiano Paolo Gentiloni. Egli infatti è stato non affiancato ma sottoposto ad una specie di sorveglianza del vice presidente esecutivo Valdis Dombrovskis: un lettone rigorista, cui i tedeschi molte volte affidano il compito di dire e fare ciò che essi preferiscono non dire e fare in prima persona.
del quotidiano la Repubblica– l’impegno di assegnare nella nuova Commissione la delega degli affari economici all’italiano Paolo Gentiloni. Egli infatti è stato non affiancato ma sottoposto ad una specie di sorveglianza del vice presidente esecutivo Valdis Dombrovskis: un lettone rigorista, cui i tedeschi molte volte affidano il compito di dire e fare ciò che essi preferiscono non dire e fare in prima persona. potrebbe servirgli solo per comunicare a Roma in lingua originale, o di casa, giudizi, moniti e quant’altro saranno decisi “collegialmente”- come ha precisato la stessa presidente- dalla nuova Commissione.
potrebbe servirgli solo per comunicare a Roma in lingua originale, o di casa, giudizi, moniti e quant’altro saranno decisi “collegialmente”- come ha precisato la stessa presidente- dalla nuova Commissione.  Ma se così davvero sarà, se si riuscirà cioè a cambiare le regole degli sbarchi, Conte potrà o dovrà dire di avere raccolto i frutti non tanto del suo secondo governo, ma del primo, realizzato con quel Matteo Salvini al Viminale che è diventato solo dal 20 agosto scorso il suo bersaglio preferito, se non unico. Duro è stato
Ma se così davvero sarà, se si riuscirà cioè a cambiare le regole degli sbarchi, Conte potrà o dovrà dire di avere raccolto i frutti non tanto del suo secondo governo, ma del primo, realizzato con quel Matteo Salvini al Viminale che è diventato solo dal 20 agosto scorso il suo bersaglio preferito, se non unico. Duro è stato  lo scontro fra i due anche nel dibattito sulla fiducia nell’aula di Palazzo Madama: con Salvini che ha dato all’altro del poltronista e Conte che, pur non chiamandolo né per nome né per cognome, come fece invece il mese scorso nel momento della rottura, gli ha dato dell’arrogante, prepotente e un po’ persino dell’eversore nei rapporti con la Costituzione, su cui pure aveva giurato l’anno passato da ministro dell’Interno.
lo scontro fra i due anche nel dibattito sulla fiducia nell’aula di Palazzo Madama: con Salvini che ha dato all’altro del poltronista e Conte che, pur non chiamandolo né per nome né per cognome, come fece invece il mese scorso nel momento della rottura, gli ha dato dell’arrogante, prepotente e un po’ persino dell’eversore nei rapporti con la Costituzione, su cui pure aveva giurato l’anno passato da ministro dell’Interno.
 e le stessa aspirazione elettorale, l’editore virtuale, diciamo così, della Repubblica di carta, Carlo De Benedetti, standosene seduto nel salotto televisivo appena riaperto da Lilli Gruber su La 7 di Urbano Cairo, l’editore a sua volta sognato da molte parti nei panni di un Berlusconi più commestibile.
e le stessa aspirazione elettorale, l’editore virtuale, diciamo così, della Repubblica di carta, Carlo De Benedetti, standosene seduto nel salotto televisivo appena riaperto da Lilli Gruber su La 7 di Urbano Cairo, l’editore a sua volta sognato da molte parti nei panni di un Berlusconi più commestibile.  e della Giorgia Meloni sarebbe stata più linearmente, più efficacemente e più stabilmente sconfitta proprio raccogliendone la sfida elettorale. Che pertanto sarebbe stata per l’ex ministro dell’Interno un’autorete maggiore della stessa crisi agostana, sempre che naturalmente la sinistra avesse saputo e voluto attrezzarsi a dovere, anziché scegliere la strada che ha invece imboccato seguendo a sorpresa l’imprevedibile Matteo Renzi: tanto imprevedibile, peraltro, che non ha smesso di lavorare -ha raccontato De Benedetti, cui certamente non mancano buone informazioni- per uscire dal Pd e mettersi in proprio.
e della Giorgia Meloni sarebbe stata più linearmente, più efficacemente e più stabilmente sconfitta proprio raccogliendone la sfida elettorale. Che pertanto sarebbe stata per l’ex ministro dell’Interno un’autorete maggiore della stessa crisi agostana, sempre che naturalmente la sinistra avesse saputo e voluto attrezzarsi a dovere, anziché scegliere la strada che ha invece imboccato seguendo a sorpresa l’imprevedibile Matteo Renzi: tanto imprevedibile, peraltro, che non ha smesso di lavorare -ha raccontato De Benedetti, cui certamente non mancano buone informazioni- per uscire dal Pd e mettersi in proprio.  a Renzi di mettersi in proprio, costituendo un gruppo autonomo alla Camera e rimanendo per un po’ in quello del Pd al Senato perché il regolamento l’obbligherebbe a confluire nel gruppo misto, ha detto che “l’importante è che ci sia il sostegno a questo governo”. Il solo inconveniente per Conte sarebbe quello di dover avere un interlocutore in più sulla sua strada, senza limitarsi a parlare per il Pd col segretario Zingaretti o col capo della delegazione piddina Dario Franceschini.
a Renzi di mettersi in proprio, costituendo un gruppo autonomo alla Camera e rimanendo per un po’ in quello del Pd al Senato perché il regolamento l’obbligherebbe a confluire nel gruppo misto, ha detto che “l’importante è che ci sia il sostegno a questo governo”. Il solo inconveniente per Conte sarebbe quello di dover avere un interlocutore in più sulla sua strada, senza limitarsi a parlare per il Pd col segretario Zingaretti o col capo della delegazione piddina Dario Franceschini. 
 la fiducia se non saranno lasciati sbarcare in Italia i cinquanta migranti appena soccorsi davanti alla Libia da una nave della “Mediterranèe”. Che si è subito indirizzata verso le coste italiane scommettendo proprio sul cambiamento del clima e degli equilibri politici dopo la caduta del governo gialloverde promossa da Matteo Salvini, l’ormai ex ministro dell’Interno distintosi per la chiusura dei porti alle navi delle organizzazioni volontarie di soccorso, e persino a quelle militari italiane.
la fiducia se non saranno lasciati sbarcare in Italia i cinquanta migranti appena soccorsi davanti alla Libia da una nave della “Mediterranèe”. Che si è subito indirizzata verso le coste italiane scommettendo proprio sul cambiamento del clima e degli equilibri politici dopo la caduta del governo gialloverde promossa da Matteo Salvini, l’ormai ex ministro dell’Interno distintosi per la chiusura dei porti alle navi delle organizzazioni volontarie di soccorso, e persino a quelle militari italiane.  per la capacità di condizionamento che possono avere nei riguardi del Pd, il cui segretario Nicola Zingaretti peraltro l’ha voluta nella combinazione tripartita per tingere più di rosso la soluzione alla crisi agostana di governo. Della quale egli si è appena vantato chiudendo la festa tradizionale dell’Unità, sopravvissuta alla scomparsa dalle edicole della storica testata comunista, assicurando “lealtà” al Movimento delle cinque stelle: purché ricambiata, ha aggiunto Zingaretti per rispondere a quanti, fra i grillini, stanno mostrando crescente insofferenza verso il Pd e si chiedono già in che cosa esso possa concretamente manifestarsi diverso dalla Lega nei rapporti con loro.
per la capacità di condizionamento che possono avere nei riguardi del Pd, il cui segretario Nicola Zingaretti peraltro l’ha voluta nella combinazione tripartita per tingere più di rosso la soluzione alla crisi agostana di governo. Della quale egli si è appena vantato chiudendo la festa tradizionale dell’Unità, sopravvissuta alla scomparsa dalle edicole della storica testata comunista, assicurando “lealtà” al Movimento delle cinque stelle: purché ricambiata, ha aggiunto Zingaretti per rispondere a quanti, fra i grillini, stanno mostrando crescente insofferenza verso il Pd e si chiedono già in che cosa esso possa concretamente manifestarsi diverso dalla Lega nei rapporti con loro.  deficit di legittimazione popolare”, già registrata d’altronde dai sondaggi sul gradimento del nuovo governo, ben al di sotto del 50 per cento, contro il 60 e più guadagnatosi dal precedente. Ed ha avvertito che “l’infima minoranza d’italiani” chiamata a dimostrare in piazza contro Conte dalle destre di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini “è destinata però nel tempo a crescere”, magari con l’affluenza dei forzisti ora trattenuti da Silvio Berlusconi. Il quale preferisce e promette una opposizione parlamentare “senza sconti” al nuovo governo, ma secondo indiscrezioni di stampa non smentite ha già telefonato personalmente a Zingaretti per offrirsi sul terreno delle riforme costituzionale ed elettorale, come già fece del resto col governo di Matteo Renzi nel 2014.
deficit di legittimazione popolare”, già registrata d’altronde dai sondaggi sul gradimento del nuovo governo, ben al di sotto del 50 per cento, contro il 60 e più guadagnatosi dal precedente. Ed ha avvertito che “l’infima minoranza d’italiani” chiamata a dimostrare in piazza contro Conte dalle destre di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini “è destinata però nel tempo a crescere”, magari con l’affluenza dei forzisti ora trattenuti da Silvio Berlusconi. Il quale preferisce e promette una opposizione parlamentare “senza sconti” al nuovo governo, ma secondo indiscrezioni di stampa non smentite ha già telefonato personalmente a Zingaretti per offrirsi sul terreno delle riforme costituzionale ed elettorale, come già fece del resto col governo di Matteo Renzi nel 2014. di prima pagina la Repubblica. “Costituente”, d’altronde, tra riforma della Costituzione e riforma della legge elettorale, diventò anche la scorsa legislatura, dopo il fallimento del tentativo dell’allora segretario del Pd Pier Luigi Bersani di far decollare con l’aiuto dei grillini un suo governo “minoritario e di combattimento” e il passaggio ai governi delle intese via via meno larghe, di Enrico Letta e del già ricordato Renzi, patrocinati dall’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ruvido nelle reazioni a chi li declassava a “inciuci”.
di prima pagina la Repubblica. “Costituente”, d’altronde, tra riforma della Costituzione e riforma della legge elettorale, diventò anche la scorsa legislatura, dopo il fallimento del tentativo dell’allora segretario del Pd Pier Luigi Bersani di far decollare con l’aiuto dei grillini un suo governo “minoritario e di combattimento” e il passaggio ai governi delle intese via via meno larghe, di Enrico Letta e del già ricordato Renzi, patrocinati dall’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ruvido nelle reazioni a chi li declassava a “inciuci”. 
 sostituito la Lega col Pd, applicando con più flessibilità le regole sul deficit, in attesa che esse cambino, come ha appena auspicato anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ma qualcosa a Bruxelles non si sta muovendo nel migliore dei modi per l’Italia.
sostituito la Lega col Pd, applicando con più flessibilità le regole sul deficit, in attesa che esse cambino, come ha appena auspicato anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ma qualcosa a Bruxelles non si sta muovendo nel migliore dei modi per l’Italia.  esagerato quel titolo di Libero su grillini e piddini che “si scannano già”, ma di certo non si può dire che stiano vivendo in armonia questi primi giorni di alleanza.
esagerato quel titolo di Libero su grillini e piddini che “si scannano già”, ma di certo non si può dire che stiano vivendo in armonia questi primi giorni di alleanza.  parte di un giornale come il Fatto Quotidiano, sensibilissimo agli umori grillini, c’è francamente ben poco da scommettere sulla durata o tenuta del nuovo governo. “Ma è il Pd o la Lega?”, si è appena chiesto nel titolo di copertina il giornale diretto da Marco Travaglio, il quale ha dedicato anche il suo editoriale a questa domanda che da sola basta ed avanza a capire ciò che già bolle, o continua a bollire, nella pentola del partito maggiore di governo. Dove -ripeto- a comandare è deciso a restare Di Maio, anche a costo di creare a Conte una quantità e qualità di problemi non inferiori a quelle di Salvini, ritrovatosi alla fine all’opposizione.
parte di un giornale come il Fatto Quotidiano, sensibilissimo agli umori grillini, c’è francamente ben poco da scommettere sulla durata o tenuta del nuovo governo. “Ma è il Pd o la Lega?”, si è appena chiesto nel titolo di copertina il giornale diretto da Marco Travaglio, il quale ha dedicato anche il suo editoriale a questa domanda che da sola basta ed avanza a capire ciò che già bolle, o continua a bollire, nella pentola del partito maggiore di governo. Dove -ripeto- a comandare è deciso a restare Di Maio, anche a costo di creare a Conte una quantità e qualità di problemi non inferiori a quelle di Salvini, ritrovatosi alla fine all’opposizione. 
 indicate col titolo di testa nella sanità e nei cantieri “le prime spine” dell’esecutivo
indicate col titolo di testa nella sanità e nei cantieri “le prime spine” dell’esecutivo che deve peraltro ancora ottenere la fiducia delle Camere, soprattutto del Senato. Dove i numeri sono stretti e ballerini quasi come quelli del governo precedente gialloverde, e di altri ancora che proprio a Palazzo Madama sono caduti, come il secondo ed ultimo governo di Romano Prodi nel 2008. Difficoltà vengono indicate anche sulla prima pagina di Repubblica.
che deve peraltro ancora ottenere la fiducia delle Camere, soprattutto del Senato. Dove i numeri sono stretti e ballerini quasi come quelli del governo precedente gialloverde, e di altri ancora che proprio a Palazzo Madama sono caduti, come il secondo ed ultimo governo di Romano Prodi nel 2008. Difficoltà vengono indicate anche sulla prima pagina di Repubblica. speriamo per lui, cioè per lo stesso Conte, che dall’ex segretario del Pd, ex presidente del Consiglio e ora “semplice” ma sempre temuto e imprevedibile “senatore di Scandicci” non gli arrivi la ormai famosa e poco incoraggiante esortazione a “stare sereno”. Essa costò notoriamente Palazzo Chigi all’amico di partito Enrico Letta, facendogli passare poi anche la voglia di restare a Montecitorio come deputato.
speriamo per lui, cioè per lo stesso Conte, che dall’ex segretario del Pd, ex presidente del Consiglio e ora “semplice” ma sempre temuto e imprevedibile “senatore di Scandicci” non gli arrivi la ormai famosa e poco incoraggiante esortazione a “stare sereno”. Essa costò notoriamente Palazzo Chigi all’amico di partito Enrico Letta, facendogli passare poi anche la voglia di restare a Montecitorio come deputato.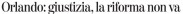 fuori dal governo forse per non contendere a Dario Franceschini il ruolo di capo della delegazione, cui l’ex ministro avrebbe avuto diritto per i gradi che ha nel partito, ha voluto far sentire alta e forte la sua voce avvertendo che la riforma della Giustizia predisposta dal ministro grillino Alfonso Bonafede “non va”. Ma, in verità, non andava neppure ai leghisti, anche se probabilmente per motivi diversi. In ogni caso, è un’altra spina, per dirla con il Corriere, per niente risolta o chiarita evidentemente nel programma di governo concordato nei giorni scorsi.
fuori dal governo forse per non contendere a Dario Franceschini il ruolo di capo della delegazione, cui l’ex ministro avrebbe avuto diritto per i gradi che ha nel partito, ha voluto far sentire alta e forte la sua voce avvertendo che la riforma della Giustizia predisposta dal ministro grillino Alfonso Bonafede “non va”. Ma, in verità, non andava neppure ai leghisti, anche se probabilmente per motivi diversi. In ogni caso, è un’altra spina, per dirla con il Corriere, per niente risolta o chiarita evidentemente nel programma di governo concordato nei giorni scorsi.  e titolo da scatola di tonno, che i ministri del Pd all’Economia e ai Beni culturali, Roberto Gualtieri e il già citato Dario Franceschini, stanno riesumando nei loro dicasteri e dintorni “dinosauri”, di cui uno allontanato personalmente da Conte durante il suo primo governo. Non ne faccio i nomi perché non voglio neppure involontariamente prestarmi alla caccia alle streghe, per la quale non sono francamente, e per fortuna, attrezzato.
e titolo da scatola di tonno, che i ministri del Pd all’Economia e ai Beni culturali, Roberto Gualtieri e il già citato Dario Franceschini, stanno riesumando nei loro dicasteri e dintorni “dinosauri”, di cui uno allontanato personalmente da Conte durante il suo primo governo. Non ne faccio i nomi perché non voglio neppure involontariamente prestarmi alla caccia alle streghe, per la quale non sono francamente, e per fortuna, attrezzato.

 l’altra mano alla sua, sotto lo
l’altra mano alla sua, sotto lo  sguardo del presidente della Repubblica. Che pure il giorno prima aveva dovuto attendere un bel po’ di ore, abbastanza spazientito, che a Palazzo Chigi si compisse l’ultimo braccio di ferro fra i due: Conte deciso a nominare come principale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio il segretario generale uscente della stessa Presidenza, Roberto Chieppa, di sua stretta fiducia, e Di Maio fermo nell’imposizione di Riccardo Fraccaro, formalmente declassato da ministro uscente ma in realtà promosso per il ruolo centrale che è chiamato ad avere sul piano politico. Dovranno passare per le sue mani, per le sue orecchie e per i suoi occhi tutto ciò che finisce poi sulla scrivania del capo del governo, o ne esce. Non a caso in quella postazione Conte aveva dovuto accettare l’anno scorso, negli accordi con i leghisti, Giancarlo Giorgetti, l’uomo di fiducia, almeno allora, di Matteo Salvini.
sguardo del presidente della Repubblica. Che pure il giorno prima aveva dovuto attendere un bel po’ di ore, abbastanza spazientito, che a Palazzo Chigi si compisse l’ultimo braccio di ferro fra i due: Conte deciso a nominare come principale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio il segretario generale uscente della stessa Presidenza, Roberto Chieppa, di sua stretta fiducia, e Di Maio fermo nell’imposizione di Riccardo Fraccaro, formalmente declassato da ministro uscente ma in realtà promosso per il ruolo centrale che è chiamato ad avere sul piano politico. Dovranno passare per le sue mani, per le sue orecchie e per i suoi occhi tutto ciò che finisce poi sulla scrivania del capo del governo, o ne esce. Non a caso in quella postazione Conte aveva dovuto accettare l’anno scorso, negli accordi con i leghisti, Giancarlo Giorgetti, l’uomo di fiducia, almeno allora, di Matteo Salvini. facendogli “l’occhiolino del compromesso”, come lo ha definito sulla prima pagina di Repubblica Francesco Merlo. Non sempre si può riuscire a fare buon viso a cattivo gioco. E il Pd, pur essendo riuscito a strappare ai pentastellati -col cespuglio dello scissionista Roberto Speranza al vertice della Sanità- ben la metà dei Ministeri, come facevano a suo tempo gli alleati della Dc da posizioni elettorali e parlamentari minori, potrà finire per essere coinvolto e indebolito dalle mene e dalle beghe stellari. Che peraltro potranno incrociarsi con quelle interne allo stesso Pd, dove il segretario Nicola Zingaretti deve guardarsi soprattutto da Matteo Renzi, al cui disinvolto e repentino passaggio dal no al sì ai pentastellati ha dovuto piegarsi dopo avere detto e ridetto di non poter cambiare i rapporti con loro senza un preventivo passaggio elettorale.
facendogli “l’occhiolino del compromesso”, come lo ha definito sulla prima pagina di Repubblica Francesco Merlo. Non sempre si può riuscire a fare buon viso a cattivo gioco. E il Pd, pur essendo riuscito a strappare ai pentastellati -col cespuglio dello scissionista Roberto Speranza al vertice della Sanità- ben la metà dei Ministeri, come facevano a suo tempo gli alleati della Dc da posizioni elettorali e parlamentari minori, potrà finire per essere coinvolto e indebolito dalle mene e dalle beghe stellari. Che peraltro potranno incrociarsi con quelle interne allo stesso Pd, dove il segretario Nicola Zingaretti deve guardarsi soprattutto da Matteo Renzi, al cui disinvolto e repentino passaggio dal no al sì ai pentastellati ha dovuto piegarsi dopo avere detto e ridetto di non poter cambiare i rapporti con loro senza un preventivo passaggio elettorale.