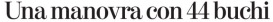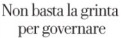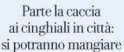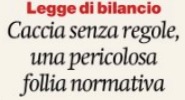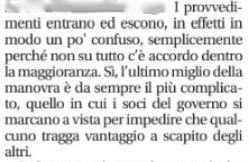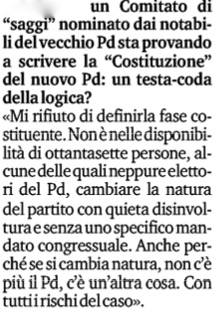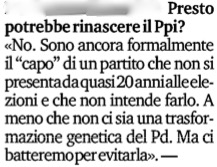Per una volta Mario Draghi ha tirato fuori dal guardaroba il mantello, non il cappotto, per indossarlo estendendolo a Giorgia Meloni. Che in una intervista al Corriere della Sera egli, pur dicendo che “non spetta” a lui “giudicare il governo soprattutto non dopo così poco tempo”, è tornato a definire “una donna abile” provvista di “un forte mandato elettorale”.

Draghi ha inoltre rappresentato in qualche modo l’esecutivo attuale in continuità con i suoi “20 mesi di governo” caratterizzati da “tante sfide raccolte e vinte”, grazie alle quali “Il Paese -ha detto l’ex presidente del Consiglio parlando non più al passato remoto ma semplice, quasi un presente- ha dimostrato di farcela”.

Dall’Irak, arrivata in missione augurale ai militari italiani che vi lavorano, la Meloni avrà gradito, e a ragione, essendosi spesa più volte anche lei nei giorni scorsi a rappresentarsi in continuità col governo precedente. Che è stato particolarmente apprezzato dalla presidente del Consiglio non più tardi di ieri per la vittoria, ad esempio, realizzatasi con lei a Palazzo Chigi sul problema del tetto al prezzo del gas. Cui ha furiosamente reagito Putin al Cremlino, per troppo tempo abituatosi a speculare sul mercato energetico per finanziare la sua guerra all’Ucraina.
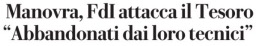
La Meloni non dovrebbe invece rallegrarsi per niente dello sforzo compiuto nelle ultime ore dai suoi amici di partito -sforzo su cui ha titolato la Repubblica- di scaricare sui “tecnici” del Ministero dell’Economia le origini, cause, responsabilità e quant’altro di una certa, obiettiva confusione registratasi nel percorso parlamentare della manovra fiscale alla Camera. “Abbandonati dai loro tecnici”, ha titolato in particolare il giornale fondato dal compianto Eugenio Scalfari scrivendo dei ministri, vice ministri e parlamentari dei “fratelli d’Italia” che hanno partecipato al gioco, chiamiamolo così, degli emendamenti risultati via via di sempre più incerta copertura finanziaria, o addirittura bocciati clamorosamente dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Le lamentele amplificate -ripeto- come con un cerino acceso in un pagliaio dal titolo di Repubblica hanno fatto apparire quello della Meloni un pò simile al primo governo di Giuseppe Conte, nel 2018. Il cui portavoce sbottò nella minaccia di far fuori mezzo Ministero dell’Economia che, secondo lui, non aveva collaborato o addirittura aveva boicottato proprio la legge di bilancio e il suo ambizioso progetto di “sconfiggere la povertà” in Italia col cosiddetto reddito di cittadinanza Ma anche con altre spese poco o per niente allineate ai parametri europei.
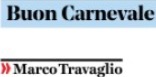
Ora, comunque, che alla manovra finanziaria non resta praticamente che la ratifica del Senato tra i botti di Capodanno, o quasi, si spera che la lista dei pasticci e degli imprevisti, a dir poco, sia finita. E che Marco Travaglio possa rimangiarsi l’augurio fuori stagione di “Buon Carnevale” lanciato col titolo dell’editoriale odierno del suo solito Fatto Quotidiano.
Ripreso da http://www.startmag.it e http://www.policymakermag.it