Vi giuro che non c’entrano nulla quei “Giuseppi” lanciati come due palle a Conte l’anno scorso, una per la maggioranza con la quale aveva governato sino al giorno prima e l’altra per la nuova su cui stava trattando più o meno dietro le quinte per restare a Palazzo Chigi sino alla fine ordinaria, addirittura, della legislatura cominciata nel 2018. Eppure il maggiore partito uscito dalle urne aveva già perduto per strada metà dei voti nelle occasioni avute dagli italiani per tornare in cabina. Nell’antipatia che sto per esprimere, o ribadire, nei riguardi del presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump c’è dell’altro.
La diffidenza verso Conte per la disinvoltura con la quale ha svolto sinora il suo ruolo oggettivamente improvvisato di presidente del Consiglio, avendo fatto tutt’altro mestiere prima di arrivare a Palazzo Chigi, limitata nei suoi danni solo dalla crescente e sempre meno silenziosa supplenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, non influisce minimamente su quella che mi ispira Trump. Il quale probabilmente, per come vanno le cose da un certo tempo a questa parte anche otre Atlantico, Uniti, fatto e detto le stesse cose con e per qualsiasi inquilino del lontanissimo palazzo romano di Piazza Colonna.
Mi basta e avanza per confermare la diffidenza verso Trump quel guantone nerissimo da pugile alzato mentre si contavano i voti degli americani per festeggiare una vittoria materialmente non  ancora conquistata e al temo spesso per minacciare di prendere a pugni il concorrente qualora lo avesse davvero sorpassato, e comunque per contestarne l’eventuale successo con pratiche che in Italia definiremmo giudiziarie, tra carte bollate, avvocati, avvocaticchi e magistrati dagli umori non meno variabili di quelli di casa nostra. Ho scritto casa, badate bene, non cosa, e tanto meno con la maiuscola. Per fortuna Trump ha mostrato, fra l’altro, nei suoi quattro anni di regno di non avere grande considerazione delle Nazioni Unite. Avrebbe già chiamato i caschi blu per sorvegliare seggi e poste americane.
ancora conquistata e al temo spesso per minacciare di prendere a pugni il concorrente qualora lo avesse davvero sorpassato, e comunque per contestarne l’eventuale successo con pratiche che in Italia definiremmo giudiziarie, tra carte bollate, avvocati, avvocaticchi e magistrati dagli umori non meno variabili di quelli di casa nostra. Ho scritto casa, badate bene, non cosa, e tanto meno con la maiuscola. Per fortuna Trump ha mostrato, fra l’altro, nei suoi quattro anni di regno di non avere grande considerazione delle Nazioni Unite. Avrebbe già chiamato i caschi blu per sorvegliare seggi e poste americane.
Già sbeffeggiato dal Covid, d’altronde in numerosa compagnia dappertutto, dal terrazzo della sua Casa Bianca Trump con quel guantone, quel pugno, quello stile e quella vigoria tutta studiata, solida come la cartapesta, non potrà andare lontano: non molto più  lontano di dove sia già arrivato tenendo tutto il mondo col fiato sospeso: tutto l’opposto dell’America alla quale si era abituata almeno la mia generazione, sia pure chiusa a scopo cautelativa da Giovanni Toti, il governatore della Liguria, in qualcuno degli armadi delle sue residenze.
lontano di dove sia già arrivato tenendo tutto il mondo col fiato sospeso: tutto l’opposto dell’America alla quale si era abituata almeno la mia generazione, sia pure chiusa a scopo cautelativa da Giovanni Toti, il governatore della Liguria, in qualcuno degli armadi delle sue residenze.
Entro in officina per ragioni di cuore scommettendo sulla vignetta di Makkox per Il Foglio, cioè su Joe Biden. Va bene, l’ex vice di Obama finirebbe il suo mandato a 82 anni: quanti ne aveva Sandro Pertini -ho sentito ricordare in qualche trasmissione televisiva con un certo scetticismo- al momento dell’elezione a presidente della Repubblica italiana, nel 1978. Sette anni dopo, se fosse dipeso da lui, avrebbe raddoppiato. Ed è stato, anzi è nella memoria degli italiani il presidente forse più rimpianto fra quelli succedutisi al Quirinale, senza offesa per i morti e per i vivi.
Ripreso da http://www.startmag.it e http://www.policymakermag.it


 con un’altra di segno opposto, sempre guidata dalla stessa persona arrivata in politica davvero per caso, chi ne vorrà raccontare davvero la storia con dati inoppugnabili, e tentarne anche un’analisi psicologica, oltre che politologica e istituzionale, non potrà davvero fare a meno delle 243 pagine scritte dal mio amico Paolo Armaroli per le edizioni La Vela. Il libro s’intitola “Conte e Mattarella- Sul palcoscenico e dietro le quinte del Quirinale- Un racconto sulle istituzioni”.
con un’altra di segno opposto, sempre guidata dalla stessa persona arrivata in politica davvero per caso, chi ne vorrà raccontare davvero la storia con dati inoppugnabili, e tentarne anche un’analisi psicologica, oltre che politologica e istituzionale, non potrà davvero fare a meno delle 243 pagine scritte dal mio amico Paolo Armaroli per le edizioni La Vela. Il libro s’intitola “Conte e Mattarella- Sul palcoscenico e dietro le quinte del Quirinale- Un racconto sulle istituzioni”. sulle qualità preminenti di Armaroli. E -guarda caso- si chiama proprio Il Dubbio il giornale in cui ci siamo alla fine ritrovati insieme a scrivere.
sulle qualità preminenti di Armaroli. E -guarda caso- si chiama proprio Il Dubbio il giornale in cui ci siamo alla fine ritrovati insieme a scrivere. immaginare un’altra coppia fra Quirinale e Palazzo Chigi: Giuliano Amato e Giuseppe Conte, anche questa volta in ordine rigorosamente alfabetico. Dai, Paolo, provaci. E, visto che ci troviamo, ti prego di assolvermi dalla tentazione in cui sono una volta caduto, sia pure con le dovute cautele che non mi hai riconosciuto, nella tentazione di paragonare Conte al suo corregionale Aldo Moro, come aveva già fatto d’altronde anche Eugenio Scalfari.
immaginare un’altra coppia fra Quirinale e Palazzo Chigi: Giuliano Amato e Giuseppe Conte, anche questa volta in ordine rigorosamente alfabetico. Dai, Paolo, provaci. E, visto che ci troviamo, ti prego di assolvermi dalla tentazione in cui sono una volta caduto, sia pure con le dovute cautele che non mi hai riconosciuto, nella tentazione di paragonare Conte al suo corregionale Aldo Moro, come aveva già fatto d’altronde anche Eugenio Scalfari.
 diventa, come se tutto dipendesse più dal contesto che da altro. Sorprendente davvero, se alla vigilia del verdetto finale il giornale più informato dei processi italiani, più ancora di un Casellario, con predilezione per le posizioni dell’accusa, dava per scontato in prima pagina che l’imputato potesse “sfangarla ancora”. Alludo naturalmente al Fatto Quotidiano fondato da Antonio Padellaro uscendo dall’Unità e diretto da qualche tempo da Marco Travaglio, sconsolato -dal suo punto di vista- per la posizione assunta in Cassazione dall’accusa, cioè dalla Procura Generale, per niente convinta della colpevolezza, almeno per intero, di Verdini. Per il quale aveva pertanto proposto un nuovo processo d’appello, dopo quello che si era chiuso, fra l’altro, con l’imputato in lacrime che giurava di avere dato davvero tutto alla sua banca fallita, per niente gestita come il “bancomat personale” contestatogli sin dal primo momento dall’accusa.
diventa, come se tutto dipendesse più dal contesto che da altro. Sorprendente davvero, se alla vigilia del verdetto finale il giornale più informato dei processi italiani, più ancora di un Casellario, con predilezione per le posizioni dell’accusa, dava per scontato in prima pagina che l’imputato potesse “sfangarla ancora”. Alludo naturalmente al Fatto Quotidiano fondato da Antonio Padellaro uscendo dall’Unità e diretto da qualche tempo da Marco Travaglio, sconsolato -dal suo punto di vista- per la posizione assunta in Cassazione dall’accusa, cioè dalla Procura Generale, per niente convinta della colpevolezza, almeno per intero, di Verdini. Per il quale aveva pertanto proposto un nuovo processo d’appello, dopo quello che si era chiuso, fra l’altro, con l’imputato in lacrime che giurava di avere dato davvero tutto alla sua banca fallita, per niente gestita come il “bancomat personale” contestatogli sin dal primo momento dall’accusa.  ma poi anche dai giudici, che in qualche modo ne hanno paradossalmente contestato le
ma poi anche dai giudici, che in qualche modo ne hanno paradossalmente contestato le  richieste prendendone il posto d’accusa. E ha potuto il giorno dopo titolare trionfalmente
richieste prendendone il posto d’accusa. E ha potuto il giorno dopo titolare trionfalmente  sulla condanna, aggiungendo “la cattiveria” di giornata del figlio che ha accompagnato il padre in carcere, invece del “preferibile” e potenziale genero, che è Matteo Salvini.
sulla condanna, aggiungendo “la cattiveria” di giornata del figlio che ha accompagnato il padre in carcere, invece del “preferibile” e potenziale genero, che è Matteo Salvini.  la quale i manettari diffidano a tal punto dei giudici che inorridiscono all’idea che le loro carriere vegano separate da quelle dei pubblici ministeri, ritenendo che ciò toglierebbe forza e autonomia a questi ultimi, a tutto vantaggio degli imputati. Che non a caso sono divisi dall’ormai fortunatamente ex magistrato Pier Camillo Davigo tra quelli che riescono disgraziatamente a farla franca, con l’assoluzione, e quelli che meritatamente non ce le fanno.
la quale i manettari diffidano a tal punto dei giudici che inorridiscono all’idea che le loro carriere vegano separate da quelle dei pubblici ministeri, ritenendo che ciò toglierebbe forza e autonomia a questi ultimi, a tutto vantaggio degli imputati. Che non a caso sono divisi dall’ormai fortunatamente ex magistrato Pier Camillo Davigo tra quelli che riescono disgraziatamente a farla franca, con l’assoluzione, e quelli che meritatamente non ce le fanno.
 ai nipoti o non ne ricevano, vuoi per accorciargliela e contribuire alla soluzione finale del problema della spesa pensionistica, mi sta sugli zebedei, direbbe l’anziano -pure lui- Vittorio Feltri, meno misurato di me nel linguaggio e anche nelle espressioni facciali.
ai nipoti o non ne ricevano, vuoi per accorciargliela e contribuire alla soluzione finale del problema della spesa pensionistica, mi sta sugli zebedei, direbbe l’anziano -pure lui- Vittorio Feltri, meno misurato di me nel linguaggio e anche nelle espressioni facciali.  giovani. Se hanno smesso di lavorare e sono andati in pensione
giovani. Se hanno smesso di lavorare e sono andati in pensione  lla regolare scadenza delle leggi in vigore, alcune delle quali oggettivamente balorde, ma pur sempre modificabili, hanno lo stesso rubato l’avvenire ai giovani percependo trattamenti privilegiati, col sistema retributivo, rispetto a quello meno vantaggioso del contributivo. Per cui maggioranze di tutti i colori si sono rincorse nei tentativi di tagliare le pensioni con imposte travestite da contributi di solidarietà, anche a costo di risparmiare nel complesso poche centinaia di milioni di euro l’anno e ridurre di molto di più le entrate fiscali. Non parliamo poi delle riduzioni imposte a quel sistema di assistenza o aiuto sociale che gli anziani con pensioni non da fame hanno potuto per anni garantire ai loro figli e nipoti, supplendo allo Stato sempre a corto di soldi per sprechi e simili.
lla regolare scadenza delle leggi in vigore, alcune delle quali oggettivamente balorde, ma pur sempre modificabili, hanno lo stesso rubato l’avvenire ai giovani percependo trattamenti privilegiati, col sistema retributivo, rispetto a quello meno vantaggioso del contributivo. Per cui maggioranze di tutti i colori si sono rincorse nei tentativi di tagliare le pensioni con imposte travestite da contributi di solidarietà, anche a costo di risparmiare nel complesso poche centinaia di milioni di euro l’anno e ridurre di molto di più le entrate fiscali. Non parliamo poi delle riduzioni imposte a quel sistema di assistenza o aiuto sociale che gli anziani con pensioni non da fame hanno potuto per anni garantire ai loro figli e nipoti, supplendo allo Stato sempre a corto di soldi per sprechi e simili. quelli adoperati contro Toti. Ne accetto da un sociologo e statistico ancora più anziano come
quelli adoperati contro Toti. Ne accetto da un sociologo e statistico ancora più anziano come Giuseppe De Rita. E tento magari di convincere il chirurgo a risparmiarsi la fatica e a farmi morire in anestesia, senza farmene accorgere. Ma da Toti, da questo presunto politico e persino “governatore” di una regione importante come la Liguria, no. Non accetto lezioni, consigli, proposte e quant’altro. Gli chiedo solo di abbassare la cresta e chiedere scusa, ma chiaramente, non con frasi ambigue come ha fatto, a tutti gli anziani che ha offeso, sorpassando persino la recente proposta di Beppe Grillo di privarli del diritto di voto.
Giuseppe De Rita. E tento magari di convincere il chirurgo a risparmiarsi la fatica e a farmi morire in anestesia, senza farmene accorgere. Ma da Toti, da questo presunto politico e persino “governatore” di una regione importante come la Liguria, no. Non accetto lezioni, consigli, proposte e quant’altro. Gli chiedo solo di abbassare la cresta e chiedere scusa, ma chiaramente, non con frasi ambigue come ha fatto, a tutti gli anziani che ha offeso, sorpassando persino la recente proposta di Beppe Grillo di privarli del diritto di voto. 
 maggiore governabilità e altre meraviglie ancora promesse al popolo con l’avvento della cosiddetta Seconda Repubblica. Il cui esordio tuttavia non era spettato al centrosinistra ma, a sorpresa, al centrodestra improvvisato da Silvio Berlusconi, con la sua Forza Italia, alleandosi al Nord con la Lega di Umberto Bossi e al Centro-Sud col Movimento Sociale di Gianfranco Fini. in evoluzione verso Alleanza Nazionale.
maggiore governabilità e altre meraviglie ancora promesse al popolo con l’avvento della cosiddetta Seconda Repubblica. Il cui esordio tuttavia non era spettato al centrosinistra ma, a sorpresa, al centrodestra improvvisato da Silvio Berlusconi, con la sua Forza Italia, alleandosi al Nord con la Lega di Umberto Bossi e al Centro-Sud col Movimento Sociale di Gianfranco Fini. in evoluzione verso Alleanza Nazionale. della sinistra trascorsero
della sinistra trascorsero  il loro tempo, mentre Lamberto Dini guidava un governo simil-tecnico per portare avanti il più possibile una legislatura azzoppata, a studiare il modo in cui rendere la rottura nel centrodestra la più profonda e meno recuperabile possibile. Come? Facile: inseguendo Bossi sulla strada del federalismo, ciò promettendogli più di quanto Berlusconi avesse potuto e voluto fare.
il loro tempo, mentre Lamberto Dini guidava un governo simil-tecnico per portare avanti il più possibile una legislatura azzoppata, a studiare il modo in cui rendere la rottura nel centrodestra la più profonda e meno recuperabile possibile. Come? Facile: inseguendo Bossi sulla strada del federalismo, ciò promettendogli più di quanto Berlusconi avesse potuto e voluto fare. in persona, che era considerato il più abile, il più furbo, il più tutto della coalizione ulivista. Ma non ci riuscì neppure lui perché commise l’imprudenza di scommettere su un turno elettorale regionale che perse, dimettendosi con un sentimento di orgoglio di cui va ancora fiero. E passò la mano a Giuliano Amato, sfidando a suo modo quella parte dell’ex Pci e, più in generale,
in persona, che era considerato il più abile, il più furbo, il più tutto della coalizione ulivista. Ma non ci riuscì neppure lui perché commise l’imprudenza di scommettere su un turno elettorale regionale che perse, dimettendosi con un sentimento di orgoglio di cui va ancora fiero. E passò la mano a Giuliano Amato, sfidando a suo modo quella parte dell’ex Pci e, più in generale,  della sinistra che non perdonava allo stesso Amato di essere stato il braccio destro, il “dottor Sottile”, il grande consigliere dell’odiatissimo Bettino Craxi, nel frattempo liquidato giudiziariamente dalla scena politica e costretto alla fuga, o addirittura latitanza, o all’esilio, secondo le preferenze, nella sua casa delle vacanze in Tunisia, finendo lì i suoi giorni amari.
della sinistra che non perdonava allo stesso Amato di essere stato il braccio destro, il “dottor Sottile”, il grande consigliere dell’odiatissimo Bettino Craxi, nel frattempo liquidato giudiziariamente dalla scena politica e costretto alla fuga, o addirittura latitanza, o all’esilio, secondo le preferenze, nella sua casa delle vacanze in Tunisia, finendo lì i suoi giorni amari. nel 2000 neppure l’investitura a candidato, per l’anno dopo, a Palazzo Chigi. La sempre troppo composita coalizione di cosiddetto centrosinistra gli aveva preferito Francesco Rutelli. Che avrebbe poi avuto l’onore, orgogliosamente rivendicato, di perdere onorevolmente col Cavaliere, tanto preoccupato in effetti della concorrenza del giovane “Cicciobello” da negargli alla fine della campagna elettorale un confronto diretto.
nel 2000 neppure l’investitura a candidato, per l’anno dopo, a Palazzo Chigi. La sempre troppo composita coalizione di cosiddetto centrosinistra gli aveva preferito Francesco Rutelli. Che avrebbe poi avuto l’onore, orgogliosamente rivendicato, di perdere onorevolmente col Cavaliere, tanto preoccupato in effetti della concorrenza del giovane “Cicciobello” da negargli alla fine della campagna elettorale un confronto diretto. Il quale di suo aggiunse quel tantino di esuberanza e impazienza, volontà di sfida e quant’altro, da perdere il referendum confermativo. E così, oltre alla salvezza della già fallita riforma del titolo V si aggiunse quella dell’ormai quasi defunto Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. E fu perduta anche l’occasione di una riduzione dei parlamentari abbinata ragionevolmente ad una modifica del cosiddetto, paralizzante e ripetitivo bicameralismo perfetto, come lo definiscono i costituzionalisti.
Il quale di suo aggiunse quel tantino di esuberanza e impazienza, volontà di sfida e quant’altro, da perdere il referendum confermativo. E così, oltre alla salvezza della già fallita riforma del titolo V si aggiunse quella dell’ormai quasi defunto Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. E fu perduta anche l’occasione di una riduzione dei parlamentari abbinata ragionevolmente ad una modifica del cosiddetto, paralizzante e ripetitivo bicameralismo perfetto, come lo definiscono i costituzionalisti. e chiudere l’istituto regionale, di cui tutti hanno peraltro scoperto i costi cresciuti a dismisura, assieme alle spartizioni partitiche, correntizie e quan’altro di ogni angolo di potere e sottopotere.
e chiudere l’istituto regionale, di cui tutti hanno peraltro scoperto i costi cresciuti a dismisura, assieme alle spartizioni partitiche, correntizie e quan’altro di ogni angolo di potere e sottopotere.
 dalla oggettiva debolezza del governo, dalla confusione di ruoli fra Stato e Regioni e dalla inadeguatezza
dalla oggettiva debolezza del governo, dalla confusione di ruoli fra Stato e Regioni e dalla inadeguatezza  anche dell’opposizione del centroodestra. Dal cui fronte è arrivata la figuraccia peggiore delle ultime 24 ore con la sortita del governatore ligure Giovanni Toti per il confinamento degli anziani,, anche perché “non produttivi”. Essi sarebbero da chiudere negli armadi, a casa, come ha titolato beffardamente un giornale di quella stessa parte politica, Libero, non si sia se per allontanarli o avvicinarli alla destinazione finale di una bara.
anche dell’opposizione del centroodestra. Dal cui fronte è arrivata la figuraccia peggiore delle ultime 24 ore con la sortita del governatore ligure Giovanni Toti per il confinamento degli anziani,, anche perché “non produttivi”. Essi sarebbero da chiudere negli armadi, a casa, come ha titolato beffardamente un giornale di quella stessa parte politica, Libero, non si sia se per allontanarli o avvicinarli alla destinazione finale di una bara.  responsabilità delle parole attribuitegli e poi confermandone il senso. Una volta tanto non ha forse sbagliato Il Fatto Quotidiano
responsabilità delle parole attribuitegli e poi confermandone il senso. Una volta tanto non ha forse sbagliato Il Fatto Quotidiano 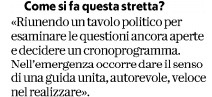 manchi al governo e alla maggioranza. Il che non mi pare francamente poco. Né mi sembra bastare, per rimediarvi, l’invito alla solita riunione attorno a “un tavolo politico”, peratro già chiesto inutilmente da Matteo Renzi, per decidere addirittura “un cronoprogramma” da realizzare da soli, par di capire.
manchi al governo e alla maggioranza. Il che non mi pare francamente poco. Né mi sembra bastare, per rimediarvi, l’invito alla solita riunione attorno a “un tavolo politico”, peratro già chiesto inutilmente da Matteo Renzi, per decidere addirittura “un cronoprogramma” da realizzare da soli, par di capire. il futuro del Campidoglio da scrivere con Zingaretti. “Noi pensiamo al virus”, ha reagito parlando al plurale la sindaca uscente della Capitale. Ci mancherebbe solo questo: che le sorti della guerra virale siano affidate a lei, come quelle delle immondizie romane.
il futuro del Campidoglio da scrivere con Zingaretti. “Noi pensiamo al virus”, ha reagito parlando al plurale la sindaca uscente della Capitale. Ci mancherebbe solo questo: che le sorti della guerra virale siano affidate a lei, come quelle delle immondizie romane.
 o sfortune, ha tradotto in “un siluro alla Raggi”, cioè alla sindaca uscente, quello lanciato – o rlanciato, perché non è la prima volta- da Di Maio proponendo “una coalizione”, come a Milano, Torino, Napoli e altrove, che non potrebbe prescindere dal Pd. Che pure sta alla Raggi, peraltro incaponitasi nella ricandidatura, come il diavolo all’acqua santa.
o sfortune, ha tradotto in “un siluro alla Raggi”, cioè alla sindaca uscente, quello lanciato – o rlanciato, perché non è la prima volta- da Di Maio proponendo “una coalizione”, come a Milano, Torino, Napoli e altrove, che non potrebbe prescindere dal Pd. Che pure sta alla Raggi, peraltro incaponitasi nella ricandidatura, come il diavolo all’acqua santa.  ’azione svolta in Campidoglio, che il suo sostegno alla collega di movimento e amica è non sicuro, ma sicurissimo. Ciò significherebbe che, volente o nolente, sotto sotto, il segretario del Pd Nicola Zingaretti sta lasciando credere a
’azione svolta in Campidoglio, che il suo sostegno alla collega di movimento e amica è non sicuro, ma sicurissimo. Ciò significherebbe che, volente o nolente, sotto sotto, il segretario del Pd Nicola Zingaretti sta lasciando credere a Di Maio che alla fine potrebbe convincersi a darle una mano, magari se dovesse riuscire ad arrivare di nuovo al ballottaggio, come l’altra volta alla signora riuscì con la destra. E ciò spiegherebbe, d’altronde, tutti gli ostacoli che Zingaretti sta opponendo alla candidatura davvero forte al Campidoglio dell’ex ministro Carlo Calenda.
Di Maio che alla fine potrebbe convincersi a darle una mano, magari se dovesse riuscire ad arrivare di nuovo al ballottaggio, come l’altra volta alla signora riuscì con la destra. E ciò spiegherebbe, d’altronde, tutti gli ostacoli che Zingaretti sta opponendo alla candidatura davvero forte al Campidoglio dell’ex ministro Carlo Calenda.