
Uno, nessuno e centomila, si potrebbe pirandellianamente dire di Giuseppe Conte per i soprannomi e i paragoni che si è meritato al suo sesto anno di attività politica, peraltro cominciata nel 2018 già all’alto livello di presidente del Consiglio su designazione dei grillini e col tormentato consenso, al Quirinale, di Sergio Mattarella. Il quale disse pubblicamente che avrebbe preferito sentirsi proporre qualcuno che fosse passato almeno una volta per un’elezione, magari solo a consigliere comunale.

Nel 2018 Conte aveva solo 52 anni, 5 in più dei 47 che aveva avuto il suo corregionale Aldo Moro arrivando a Palazzo Chigi nel 1963, e di rimanervi o tornarvi per cinque volte, dopo essere già stato ministro, capogruppo alla Camera e soprattutto per quattro anni segretario della Dc, il maggiore partito di quei tempi. Due carriere insomma da non poter mettere neppure a confronto, anche se un estimatore un po’ smodato di Conte è arrivato a considerarlo non per scherzo, ma sul serio, scrivendone sul suo giornale, il migliore capo di governo in Italia dopo il conte, con la minuscola, Camillo Benso di Cavour.

I soprannomi o simili, compresi i paragoni, guadagnatisi in cinque anni dall’avvocato di Volturara Appula si sprecano: da Contuccio, appena affibbiatogli sul Foglio, a Camaleonte per la capacità di trasformarsi, che è poi l’essenza del diavolo spiegata in un congresso della Dc da Arnaldo Forlani chiudendo la sua prima esperienza di segretario del partito per essere sostituito dal capocorrente Amintore Fanfani, Che si era stancato e preoccupato di vederlo crescere e deciso di prenderne il posto cambiandone la linea politica.

Da sciacallo, per tornare ai soprannomi di Conte, così definito pubblicamente da alcuni esponenti del Pd sorpresi dall’uso da lui fatto delle indagini giudiziarie a Bari per terremotare i progetti comuni sul municipio della città e ritirarsi dalla giunta regionale di Michele Emiliano, all’indovino o orologiaio per la capacità di prevedere, e non solo lamentare, i guai pugliesi del Nazareno. Dal conte spendaccione e fatuo, per via dei superbonus e del reddito di cittadinanza, a Raffaello Mascetti , conte pure lui, interpretato da Ugo Tognazzi nei celeberrimi “amici miei” cinematografici. Egli avrebbe potuto meritarsi anche il Vitangelo Mascarda del già citato romanzo drammatico di Luigi Pirandello “Uno, nessuno, centomila” se di quel personaggio alla ricerca disperata della sua identità non si fosse giù appropriato nei suoi nuovi spettacoli teatrali Beppe Grillo, garante, consulente ed ex cofondatore del Movimento 5 Stelle ora presieduto dall’ex premier.
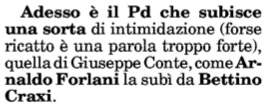
In ogni soprannome o controfigura c’è naturalmente del paradosso o esagerato, e persino ingiustamente offensivo, per carità, perché la polemica politica è spesso feroce, ma consentitemi di esprimere totale dissenso dal paragone che su ItaliaOggi Carlo Valentini ha fatto fra il Conte, con la maiuscola, aspirante al ritorno a Palazzo Chigi forzando mano, piedi e cervello al Pd, e il Bettino Craxi che vi sarebbe arrivato nel 1983, rimanendovi sino al 1987 e proponendosi di tornarvi dopo le elezioni del 1992, imponendosi sulla Dc di un povero, sottomesso Arnaldo Forlani.
A parte la comune dimensione, dal 10 al 14 per cento, del Psi craxiano degli anni Ottanta e delle 5 Stelle odierne di Conte, non vi è nulla che possa avvalorare un paragone così cervellotico. Craxi fu lo statista occidentale che permise all’Italia di sbloccare e partecipare al riarmo missilistico della Nato destinato a fare crollare il comunismo, Conte vota contro gli aiuti militari all’Ucraina aggredita dalla Russia di Putin.

Conte non ha molto interesse, diciamo così, alla salute del Pd, Craxi ne ebbe per la Dc, fra la rabbia dei comunisti, ritardandone la fine di una quindicina d’anni dopo la tragica fine di Aldo Moro. E quanto alla buonanima di Forlani, vice di Craxi a Palazzo Chigi dopo esservi passato da presidente, egli non subì per niente il leader e amico socialista, astenendosi -unico e solo- nella votazione della direzione democristiana che sbarrò la strada di Palazzo Chigi all’amico già nel 1979, dopo l’incarico conferitogli dal presidente della Repubblica Sandro Pertini. Quell’astensione lasciò accesa la fiammella della ripresa dell’alleanza fra i due partiti dopo la fine, voluta da Enrico Berlinguer, della fase della cosiddetta politica di solidarietà nazionale prodotta dal risultato paralizzante delle elezioni politiche anticipate del 1976.
Si raccomanda di ripassare bene la cronaca – per favore, direbbe Papa Francesco- o studiare meglio la storia prima di scriverne.
Pubblicato sul Dubbio

Lascia un commento