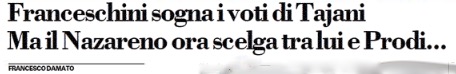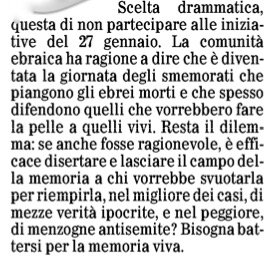Sul putiferio provocato dalla notizia, diffusa dalla stessa premier Giorgia Meloni, dell’iniziativa giudiziaria su di lei, sui ministri dell’Interno e della Giustizia e sul sottosegretario alla Presidenza del Consiglio delegato ad occuparsi dei servizi segreti, si ha solo l’imbarazzo della scelta fra chi ha compiuto per primo o di più falli di reazione, chiamiamoli così cercando di essere equanimi. Che è cosa francamente difficile nell’ossimoro di questa calda stagione politica d’inverno.

Ha sbagliato di più la premier a esibire in un video quello che ha definito un “avviso di garanzia”, con tanto di reati ipotizzati a carico suo e dei colleghi di governo per il rimpatrio in Libia del generale Almasri,del quale la Corte penale internazionale dell’Aja aveva chiesto e per qualche ora anche ottenuto la carcerazione in Italia dopo averlo lasciato viaggiare liberamente fra Gran Bretagna e Germania? Un generale accusato di gravissimi reati nel trattamento degli immigrati in Libia, dei quali sono aumentate le partenze per l’Italia dopo il suo arresto, in una coincidenza a dir poco significativa.

O hanno sbagliato l’associazione nazionale dei magistrati e tutti quelli che le sono andati appresso contestando alla Meloni la natura dell’atto ricevuto dalla Procura della Repubblica di Roma? Che sarebbe non un avviso di garanzia ma una semplice e “dovuta” comunicazione di inoltro al competente tribunale dei ministri, composto per sorteggio, di un esposto delll’avvocato Luigi Li Gotti. Che ciascuno colloca politicamente dove vuole riferendosi alle varie tappe del suo impegno politico: a destra e a sinistra, essendo lui passato per il Movimento Sociale, Alleanza Nazionale e Italia deivalori di Antonio Di Pietro, guadagnandosi in quest’ultima collocazione un sottosegretariato nel secondo governo di Romano Prodi.

Esiste sul piano logico, mediatico, percettivo una differenza fra indagini in corso, impedite per legge alla ordinaria Procura della Repubblica di Roma in materia di reati ministeriali, o indagini imminenti, dati i tempi ristretti lasciati al tribunale dei ministri per valutare la situazione? Dubito che esista, per quanto importante, persino vitale, sembri apparire all’associazione nazionale dei magistrati in un momento in cui essa è impegnata in un duro scontro con il governo sulla riforma della giustizia all’esame del Parlamento. Uno scontro che non è arrivato all’improvviso, ma rientra in un conflitto fra giustizia e politica in corso da una trentina d’anni se vogliamo risalire alle inchieste giudiziarie note col nome di “Mani pulite”. O da una quarantina se vogliamo risalire al 1985, quando l’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga impedì al Consiglio Superiore della Magistratura, da lui stesso presieduto, di processare a suo modo il capo del governo Bettino Craxi. Che aveva criticato come riduttivo il trattamento giudiziario riservato ai terroristi assassini del giornalista Walter Tobagi, del Corriere della Sera.