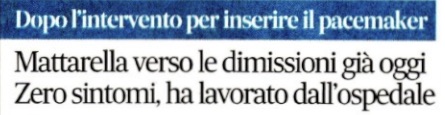A ogni morte di Papa, si diceva una volta per contrassegnarne l’eccezionalità in senso soprattutto temporale, tanto lunghi erano di solito i Pontificati. E quanto brevi i governi che dall’altra parte del Tevere si susseguivano per le loro precarie condizioni di salute politica. Alcuni dei quali nascevano o morivano appesi anche ai rosari, diciamo così, del Papa di turno.
Del Pontefice bastava un sopracciglio soltanto mormorato nei palazzi romani di pasoliniana memoria per accelerare o scongiurare una delle crisi cicliche di cui vivevano i partiti. E non solo quelli di governo, ma anche di opposizione, perché spesso fra pezzi degli uni e degli altri si intrecciavano dialoghi, manovre e persino intrighi dei quali il presidente del Consiglio di turno spesso era uno degli ultimi ad accorgersi, e finirne travolto.
La prima morte di Papa che io ricordo intrecciata in qualche modo con le cronache politiche di cui mi occupavo già da tempo fu quella di Giovanni XXIII, all’anagrafe Angelo Roncalli, avvenuta il 3 giugno 1963, dopo meno di cinque anni di Pontificato però intenso di novità, e meno di due mesi dopo le elezioni politiche ordinarie del 28 e 29 aprile. Alle quali la Dc, il partito cattolico guidato da Aldo Moro, si era presentato avendo già tracciato per la nuova legislatura il completamento del percorso del centro-sinistra, col trattino, lasciato dallo stesso Moro sperimentare da Amintore Fanfani alla guida governativa delle cosiddette “convergenze parallele”, senza spingersi ad un’alleanza “organica” con i socialisti al posto dei liberali. Che Moro si era riservata per sé.
Giovanni XXIII aveva abbastanza pubblicamente incoraggiato sia Fanfani che Moro, spintosi dal canto suo a promuovere una specie di consultazione di tutti i vescovi italiani per coprirsi, diciamo così, le spalle. Alla morte del Papa i settori ancora contrari della Dc, e ma anche di altri partiti, a quella svolta politica sperarono di trovare qualche sponda oltre Tevere con l’arrivo di un altro Pontefice. Ma Paolo VI, all’anagrafe Giovanni Battista Montini, peraltro legato da un’amicizia personale con Moro, di cui era stato negli anni giovanili anche uno dei confessori, deluse aspettative di quel senso.
Il pontificato di Paolo VI durò più di 15 anni, interrompendosi il 6 agosto 1978 per una specie di colpo di grazia inferto alle sue condizioni di salute dalla morte orrenda di Moro nelle mani delle brigate rosse. Alle quali il Papa si era inginocchiato in un pubblico messaggio per sollecitarne il rilascio, dopo il tragico sequestro compiuto il 16 marzo fra il sangue della sua scorta. E, non avendolo ottenuto, anche perché chiesto “senza condizioni”, con una formula criticata dallo stesso Moro nel covo dove era rinchiuso ma presumibilmente concordata con l’allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti, il Papa ne celebrò la solenne messa funebre, nella Basilica di San Giovanni, prendendosela con Dio che non aveva ascoltato le sue preghiere.
Giovanni Parolo II, il papa polacco venerato come santo, sulla cui statua al Policlinico Gemelli si affacciano le stanze dove i suoi successori sono stati ricoverati al bisogno, morì nel 2005 governando Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi. In difesa della cui esperienza politica dal primo momento, nel 1994, il papa “straniero” aveva lasciato carta bianca al cardinale Camillo Ruini, arrivato ad uno scontro diretto nel 1994 con l’allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro in azione contro il primo governo Berlusconi, già pochi mesi dopo la formazione.
Papa Francesco, ancor più di Giovanni Paolo II e poi del tedesco Benedetto XVI, ha cercato di tenersi alla larga, diciamo così, dalla politica italiana, ma non abbastanza per nascondere e trattenere una simpatia ricambiata con Giorgia Meloni, la prima donna, e di destra, a Palazzo Chigi. Una simpatia della quale la sinistra italiana, o quel che ne è rimasto dopo il suicidio giustizialista di una trentina d’anni fa, ha naturalmente sofferto, sino a farsene un altro motivo di ossessione nella pratica della sua opposizione.
Pubblicato su Libero
Ripreso da http://www.startmag.it