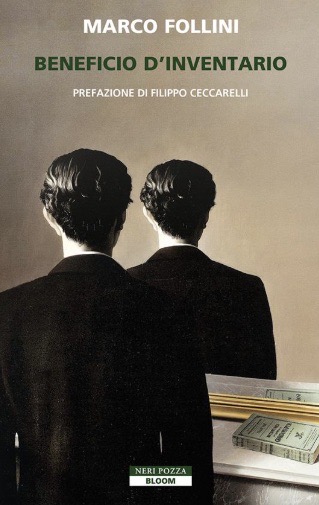Conobbi Pasquale Laurito, il decano dell’associazione della stampa parlamentare appena scomparso a 98 anni, più di mezzo secolo fa, Dio mio. Collaboravamo insieme al Globo, un quotidiano della Confindustriadiretto da Remigio Rispo, conservatore in tutto, a cominciare dall’abbigliamento, e da quel “Lei” che dava a tutti, dall’autista al redattore capo. Ciò mi lasciò pensare che anche Laurito in qualche modo lo fosse, anche se lo sapevo, anzi lo immaginavo, per le sue origini calabresi, spintosi sino a simpatizzare per il socialista Giacomo Mancini. Che nel Psi era un autonomista tosto, superato poi negli anni solo da Bettino Craxi, col quale peraltro non sarebbe andato d’accordo per questioni di carattere più che di politica.

Fu proprio Rispo a rivelarmi invece, e con un certo compiacimento, l’appartenenza di Pasquale, del quale ero diventato intanto amico, al partito comunista. E me lo disse contentissimo di sorprendermi, compiaciuto di averlo nella squadra degli informatori anche per la possibilità che gli dava in privato di sapere del Pci, e delle sue intriganti vicende interne, più di quelli che Fortebraccio sull’Unità chiamava “lor signori”.

L’amicizia con Pasquale si strinse ulteriormente nel 1968, quando ci trovammo insieme, pur non più nello stesso giornale, scambiandoci notizie e segreti, a difendere Aldo Moro dallo sfratto da Palazzo Chigi deciso dai cosiddetti “amici” di corrente della Dc, che si chiamavano “dorotei”. Essi gli avevano contestato troppa pazienza nei rapporti col Psi che aveva portato al governo nel 1963, salvo offrirgliene ancora di più pur di portare Mariano Rumor alla guida d una edizione dichiaratamente “più incisiva e coraggiosa” del centro-sinistra“ a “maggioranza delimitata” permessa cinque anni prima a Moro.
Ma mentre io solidarizzavo con Moro, peraltro pugliese come me, non condividendo quella che ritenevo una porcata fattagli nel partito pur di sostituirlo, Pasquale godeva, diciamo così, dell’occasione offerta a Moro dai suoi colleghi di partito per spostarsi reattivamente a sinistra, scavalcandoli. Il centrosinistra, ripeto, “più incisivo e coraggioso” di Rumor impallidì rapidamente di fronte alla sopraggiunta “strategia dell’attenzione” di Moro verso il Pci. E persino verso la contestazione giovanile dalla quale i dirigenti comunisti cercavano di tenersi ad una certa distanza, avendo avvertito di non poterla controllare o convogliare come erano abituati a fare con tutto ciò che era protesta.
Sapevamo entrambi della diversa angolatura delle nostre comuni simpatie per Moro, ma costituimmo con Pasquale uno strano connubio politico a livello giornalistico, confezionando anche un’agenzia di stampa chiamata Ipe -da “informazioni politiche ed economiche”- che cessò le pubblicazioni dopo il fallimento della scalata tentata da Moro alla Presidenza della Repubblica alla scadenza del mandato di Giuseppe Saragat. Che lo stesso Moro nel 1964 aveva aiutato ad essere eletto al Quirinale, tra le resistenze e le paure dei democristiani, succedendo all’ormai impedito Antonio Segni.
Da allora, da quella nostra curiosa esperienza di “convergenze parallele”, secondo una formula propedeutica al centro-sinistra attribuita proprio a Moro ancora segretario della Dc, fra il 1959 e il 1963, il mio rapporto con Pasquale fu solo di amicizia e simpatia personale. Le assonanze politiche furono ancora più di carattere e di stile, a proposito dei leader succedutisi tra prima e seconda Repubblica, che di linea o di progetti.

Ci scontravamo amichevolmente, per esempio, io con le mie simpatie per Bettino Craxi e lui per Massimo D’Alema, mai lasciato indifeso in qualsiasi polemica in quella nota informativa, prevalentemente breve, che egli confezionava lasciandola chiamare “velina rossa”. Contrapposta a quella “bianca”, di ben più largo e remunerativo mercato, del compianto Vittorio Orefice. Che aveva sempre un occhio di riguardo, diciamo così, per la Dc.
Addio, Pasquale. E grazie dell’amicizia che mi hai ricambiato così a lungo.
Pubblicato su Libero