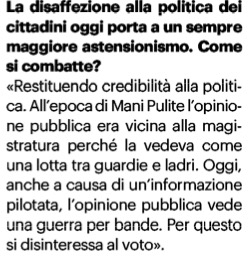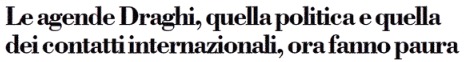Presi fra la drammatica vicenda giudiziaria delle sevizie nel carcere minorile di Milano, che ha messo e mette a dura prova il mio garantismo, e la sconcertante fuga dalle urne nella Basilicata -pur dopo, o proprio a causa di una campagna elettorale preparata con i fuochi artificiali delle liti e degli sgambetti interni ed esterni alle due coalizioni contrappostesi- sono sfuggite la portata e il significato della convergenza ricreatasi fra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Mario Draghi. Ricreatasi, se mai si fosse davvero interrotta.

Questa volta la convergenza è avvenuta non su un passaggio della politica interna- come tre anni fa, quando il primo mandò il secondo a Palazzo Chigi per garantire un governo al Paese ritenendo di non potere sciogliere in quel momento le Camere anticipatamente- ma sulle prospettive europee. Alle quali, volenti o nolenti, chi per spingere e chi per frenare, sono chiamati a lavorare e ancor più lo saranno tutti i paesi dell’Unione, e relative forze politiche, nel Parlamento che sarà eletto a giugno.
Ormai, nonostante la tormentata vicenda appena conclusa del nuovo patto di stabilità, non si potrà che andare avanti sulla strada dell’Unione, non tornare indietro. Ce lo impone la cosiddetta geopolitica. Lo impongono le guerre che l’assediano, una delle quali -quella naturalmente in corso da più di due anni in Ucraina- entrata quasi come un’enclave in una Europa alla quale il paese aggredito e invaso dalla Russia di Putin si è proposto ottenendo la disponibilità ad accoglierlo, non certo un rifiuto.

Per andare avanti, al passo impostole -ripeto- dalla geopolitica e dall’istinto, direi, di sopravvivenza, l’Unione Europea ha bisogno di una riforma “radicale”, ha detto Mario Draghi anticipando un rapporto sui problemi della competitività apprezzabilmente chiestogli dalla Commissione uscente presieduta da Ursula von der Leyen. Una riforma “incisiva e coraggiosa”, ha detto Mattarella. Il cui mandato al Quirinale è stato rinnovato poco più di due anni fa, per cui ne ha ancora cinque a disposizione. Che, conoscendo l’uomo del Colle, non trascorreranno certamente inoperosi o passivi, né dentro né oltre i confini nazionali, per quel che ancora essi valgano e continueranno a valere nel percorso comunitario ancora incompleto.
L’asse istituzionale creatosi fra Mattarella e Draghi nel 2011, scambiato nella casa grillina e dintorni per un “Conticidio” e approdato così nelle librerie con la firma del direttore del Fatto Quotidiano, si tradusse in una maggioranza politica con ripetute fiducie parlamentari. Che si interruppero nell’estate dell’anno dopo con lo sbocco a quel punto inevitabile delle elezioni anticipate. A loro volta sfociate nel governo attuale che, pur presieduto da una ex oppositrice di Draghi, la leader della destra Giorgia Meloni, ne ha ereditato e sviluppato la qualificante politica estera. E’ sembrato e sembra un paradosso, ma è semplicemente la realtà.
Chissà se quell’asse -ripeto- appena ritrovato con o nelle parole di Draghi e Mattarella, in ordine alfabetico, non riuscirà a tradursi nel nuovo Parlamento europeo, con il concorso di forze politiche capaci di confluire in una nuova maggioranza, come nel Parlamento italiano fra il 2011 e il 2012. Ma questa volta in una prospettiva più lunga. Chissà.

Si sono già levate voci preoccupate, anche di miei colleghi e amici carissimi, per il rischio di un vulnus della democrazia rappresentativa, chiamata ad adeguarsi a operazioni di vertice piuttosto che crearne di proprie. Ma è un timore che francamente, e personalmente, non avverto perché convinto che nessuno voglia o possa comunque congiurare, piuttosto che lavorare, confrontarsi e infine decidere nelle sedi proprie. Dalle quali sicuramente non si lascerà escludere l’Europarlamento che tutti saremo chiamati ad eleggere fra poco, accorrendo alle urne -spero, condividendo l’auspicio del capo dello Stato- non con l’affluenza minoritaria delle elezioni regionali appena svoltesi in Basilicata. Dove tutto alla fine è risultato virtuosamente -si fa per dire- dimezzato: sia la vittoria del confermato centrodestra, sia la sconfitta del campo più o meno largo a comune partecipazione del Pd di Elly Schlein e delle 5 Stelle di Giuseppe Conte. Non parliamo poi del terzo incomodo nella corsa al governatorato dal nome – Follia- già sfortunato di suo.
Pubblicato sul Dubbio