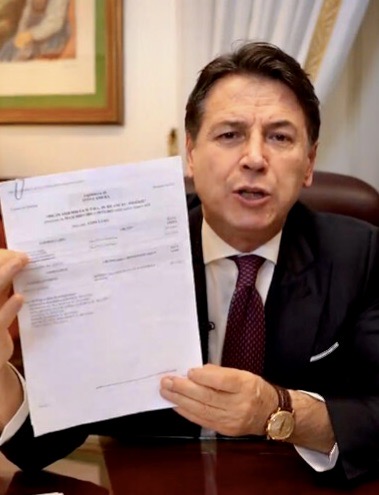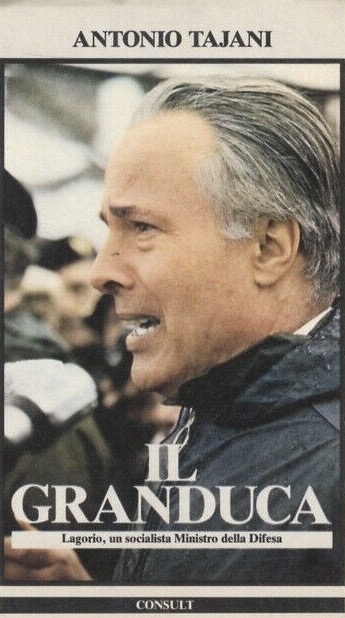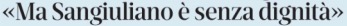Senza voler fare torto a nessuno della famiglia del compianto Aldo Moro, la figlia primogenita Maria Fida, appena morta a 77 anni, fu quella che visse più tumultuosamente la terribile vicenda del padre, rapito il 16 marzo 1978 dalle brigate rosse, a poca distanza da casa fra il sangue della scorta decimata in via Fani, e ucciso pure lui dopo 55 giorni di penosa prigjonia. E di drammatica impotenza e inefficienza dello Stato, a dir poco, non mancando francamente elementi, emersi anche dalle inchieste parlamentari condotte sulla tragedia, per sospettare che i terroristi avessero trovato connivenze nello Stato sia nella preparazione del sequestro, sia nella sua gestione. Connivenze sempre negate dai brigatisti ma di cui anche Maria Fida avvertì i segni protestando contro i buchi neri delle indagini.
Maria Fida fu tra le più critiche all’interno della famiglia nei riguardi dell’allora ministro dell’Interno Cossiga, un cui uovo pasquale mandato al figlio, il piccolo Luca, durante la prigionia del nonno, la mamma fece rotolare per le scale di casa strappandolo dalle mani degli agenti di Polizia che lo avevano portato.

Luca è proprio quel nipotino che Moro nella straziante lettera di addio inviata alla moglie, quando si accorse che stava per essere ucciso, immaginava di accarezzare i riccioli. E sperava di rivedere lassù perché -scrisse- “sarebbe bello che ci fosse luce”. Quel nipotino che era felice di ospitare ogni tanto nella sua casa di via di Forte Trionfale, sempre a Roma, a poca distanza peraltro dalla mia.
Maria Fida quando il padre era presidente del Consiglio fece praticantato di giornalismo nella redazione romana della Gazzetta del Mezzogiorno, Al termine le toccò naturalmente l’esame di abilitazione. Il padre non era più a Palazzo Chigi. Ebbi tuttavia una telefonata davvero inusuale dal suo capo ufficio stampa Corrado Guerzoni. Che, precisando di no nfarlo a nome di Moro , mi chiese d segnalare Maria Fida ad Alberto Giovannini, che faceva parte della commissione d’esame ed era il direttore del quotidiano per il qauale io allora lavoravo: Il Giornale d’Italia. Dove, peraltro, in dissenso da chi seguiva con me la politica interna, il compianto Franco Cangini, sostenevo la candidatura di Moro al Quirinale, al posto di Amintore Fanfani, l’altro “cavallo di razza” della Dc, come li chiamava Carlo Donat-Cattin. E convinsi persino, in una intervista, il leader liberale Giovanni Malagodi ad esprimersi a favore appunto di Moro, una volta fallita per i dissensi interni al partito la candidatura ufficiale dell’allora presidente del Senato.
Ne derivò quasi u incidente nel Transatlantico di Montecitorio con un anziano e autorevole collega, Enrico Mattei, che mi accusò di avere manipolato Malagodi. Figuriamoci: uno che quando si lasciava intervistare dettava anche le virgole e i punti delle sue frasi. Il fatto è che Malagodi non condivideva la rappresentazione di Moro come di un uomo a disposizione -come dicevano gli avversari anche interni alla Dc- di un partito comunista che aveva fatto sapere di essere disposto a votarlo al Quirinale, “per quanto -disse Giancarlo Pajetta- sia stato l’unico a non avercelo chiesto”.
Ma torniamo agli esami di Maria Fida. Felice di occuparsene, Giovannini mi informò dopo le prove che la figlia di Moro era “brava davvero” e mi chiese di far sapere all’allora ministro degli Esteri che l’avrebbe assunta volentieri al giornale che dirigeva. Riferii naturalmente a Guerzoni, che un quarto d’ora mi richiamò incaricandomi di riferire a Giovannini che Mari Fida sarebbe stata libera di accettare ma senza il conseno del padre, Infatti non se ne fece nulla.
Evidentemente il Giornale d’Italia ea troppo a destra per Moro, anche se ne aveva sostenuto l’elezione al Quirinale, Ma la figlia -ironia della sorte- sarebbe finita molto più a destra.e non solo, di quanto il padre avesse potuto immaginare.

Eletta senatrice nel 1987 per la Dc, Maria Fida ne lasciò il gruppo per passare addirittura a Rifondazione Conunista. E infine, non più parlamentare, all’Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini. Dove neppure riuscì a restare a lungo, visto che Lorenzo Cesa ne ha appena ricordato la figura lsciando intendere di averla in qualche modo riportata a casa nella sua formazione, che fa parte della diaspora democristiana.
Pubblicato su Libero
Ripreso da http://www.startmag.it il 10 febbraio