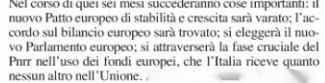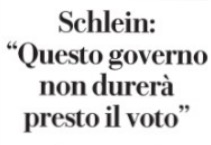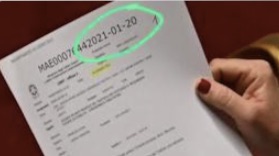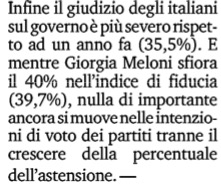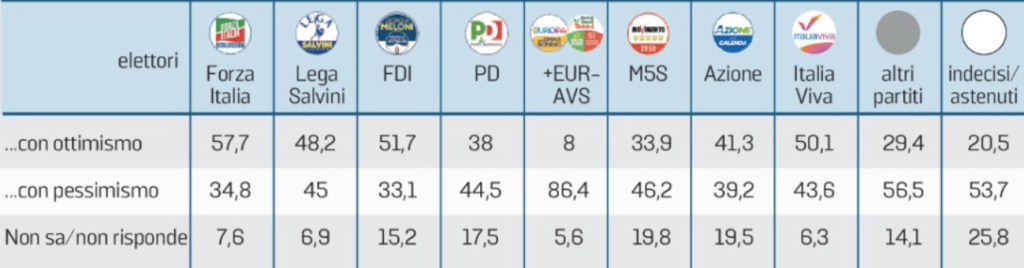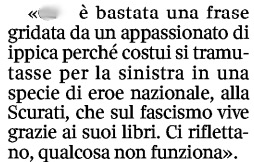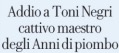
Appena morto a Parigi con tutti i debiti pagati alla giustizia italiana, che lo aveva condannato prima a 30 e poi a 12 anni di carcere per associazione sovversiva, banda armata, concorso morale in una rapina mortale, Toni Negri non ne aveva compiuti nemmeno 50 quando -nell’estate del 1983- fu lasciato scappare in Francia nientemeno che dal presidente del Consiglio e dal ministro dell’Interno allora in carica. Che erano, rispettivamente, il leader socialista Bettino Craxi e il democristiano “tutto di un pezzo”, come lo chiamavano nel suo partito, Oscar Luigi Scalfaro. Il quale si compiaceva di portare addosso, attaccata sulla pelle sotto l’abito civile, la toga di magistrato solo apparentemente dismessa nel 1946, quando era stato eletto all’Assemblea Costituente.


Quello di Craxi e di Scalfaro non fu un atto né di generosità né di codardia, o tradimento allora contestabile ad entrambi davanti alla Corte Costituzionale. Fu una decisione paradossale, utile ad evitare che l’intera legislatura appena cominciata si svolgesse nelle curiose modalità immaginate da quel diavolo di Marco Pannella. Che aveva candidato e fatto eleggere deputato quel noto professore universitario di filosofia, benchè in carcere di massima sicurezza dal 1979, quando fu arrestato in una sostanziale retata a Padova di sospetti terroristi, assassini, rapinatori e sequestratori.


Liberatolo per forza nel momento dell’elezione a deputato, i magistrati predisposero tempestivamente la richiesta di autorizzazione ad arrestarlo daccapo per la gravità dei reati contestatigli, in attesa di processarlo. Poi, nello scenario perseguito da Pannella, essi avrebbero dovuto autorizzarlo di volta in volta ad essere tradotto alla Camera per partecipare alle sedute d’aula o di commissione scelte dal detenuto per assolvere al proprio mandato.
Pur amici entrambi di Pannella, presidente del Consiglio e ministro dell’Interno non ebbero bisogno neppure di parlarsi fra di loro. Bastò uno scambio di sguardi per intendersi e capire che, mollando la sorveglianza già allertata e lasciando scappare Negri in Francia da un porto della Toscana, avrebbero risparmiato agli italiani uno spettacolo imprevedibile nei suoi sviluppi e risvolti.


Così Toni Negri trovò rifugio in Francia, come altri nelle sue condizioni. E, incassata per tutta la legislatura con delega non so a chi la sua lauta indennità parlamentare, tornò in Italia di sua volontà dopo 14 anni, a processi terminati, condanne ridimensionate e in grado di patteggiare un modesto “residuo di pena”, contenente quattro anni di semilibertà. Un epilogo in qualche modo coerente con la sua storia stravagante, a dir poco, di uomo cresciuto con fede religiosamente cattolica e politicamente socialista ma tanto radicale nei suoi ragionamenti, nelle sue condotte e nelle sue frequentazioni, fra le quali quella con Renato Curcio, da procurarsi ogni tipo di sospetti: anche di avere concorso alla fondazione delle brigate rosse e al sequestro di Aldo Moro.
Ripreso da http://www.startmag.it e http://www.policymakermag.it