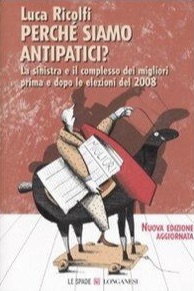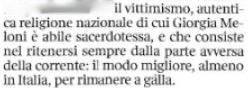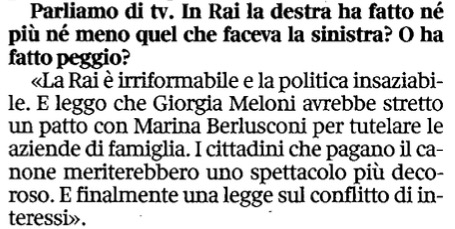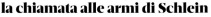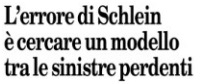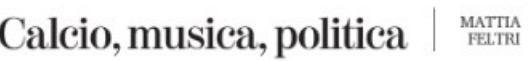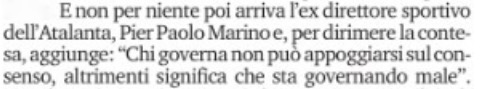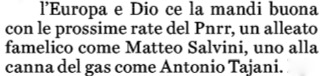In nessuna delle pur numerose e promozionali anticipazioni del libro-intervista a Giorgia Meloni di Alessandro Sallusti, che si è procurato oggi la sfottente definizione di “direttore del Giorgiale” da parte di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, avevo trovato la formula “Dio, Patria e Famiglia”. Che è invece rilanciata oggi, o comunque attribuita con titoli, vignette e quant’altro alla premier italiana dopo l’incontro a Budapest col presidente ungherese Viktor Orban. Una formula, virgolettata in prima pagina dalla Stampa, che ci riporta con la memoria anche al famoso grido in piazza della Meloni, con le vene gonfiate sul collo, durante la corsa a Palazzo Chigi: “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana”.
Cristiana, ripeto. Che pure dovrebbe rispettare i dieci comandamenti, il secondo dei quali dice, anzi grida anch’esso: “Non nominare il nome di Dio invano”. E lasciate che lo ricordi, senza spingersi a segnalarlo al Papa perché prima di perdonarla generosamente la inviti per telefono a non rasentare la bestemmia, uno che non credo sospettabile, almeno da chi è abituato a leggerlo, di pregiudizio contro la Meloni. Non la considero una fascista né in erba né cresciuta, né un’intrusa come sotto sotto, senza più dirlo neppure agli amici per timore di rischiare l’emarginazione, pensa ancora qualcuno persino nel centrodestra rimpiangendo i tempi della coalizione a trazione forzista o leghista.

Non scomodiamo per favore in politica Domineddio, tanto meno per convincere il mio amico Marco Follini a non ripetere ciò che ha scritto ieri sulla Stampa per esprimere la certezza, da ex dirigente e storico dello scudo crociato, che mai la Meloni potrà essere o assomigliare a una democristiana. Come invece crede che sia miracolosamente già avvenuto un altro ex o post-dc quale Gianfranco Rotondi, già ministro berlusconiano.


Pur nel timore di esagerare nelle citazioni del Fatto e del suo direttore, ne condivido “la cattiveria” di giornata. Che attribuisce al “Padreterno” questa reazione a “Giorgia d’Ungheria”, come la sfotte oggi anche Il Foglio: “Dai nemici mi guardi Dio che dai nemici mi guardo io. Ma Dio sono io: qui tocca fare tutto a me”.

La mia protesta, diciamo, finisce qui. E non si avventura sulla strada di Mattia Feltri, sempre sulla Stampa, che contesta alla Meloni l’impegno contro le denatalità, che l’ha peraltro portata a Budapest, perché si è limitata, almeno per ora, a una sola figlia nella famiglia -altra parola magica del suo trittico politico- messa su col convivente, quasi marito Andrea Giambruno. Ma vedrete che prima o dopo i due si sposeranno, non appena la Meloni ne avrà il tempo fra un viaggio e l’altro, un Consiglio dei Ministri e l’altro, un libro e l’altro, un’arrabbiatura e l’altra, una telefonata e l’altra. E sarà sicuramente festa a vantaggio anche del suo gradimento da premier appena registrato in discesa da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, a dispetto della tenuta del suo partito.
Ripreso da http://www.startmag.it e http://www.policymakermag.it