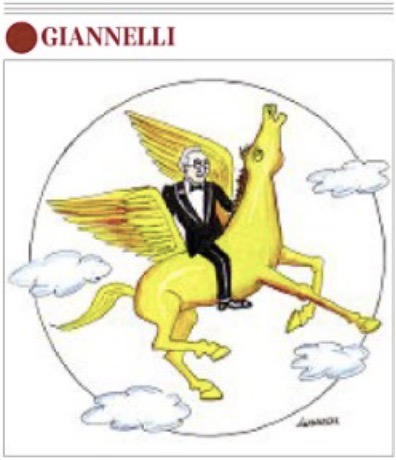Negli spazi televisivi scampati, diciamo così, ad una monumentalizzazione di Pippo Baudo così ridondante da non piacere- credo- all’interessato che la sta osservando da lassù, stropicciavo gli occhi a vedere le immagini provenienti dalla Casa Bianca. Dove, nel vertice euro americano sull’Ucraina seguito al suo incontro in Alaska con Putin, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha voluto alla sua sinistra la premier italiana Giorgia Meloni. “Grande leader e fonte di ispirazione”, ha detto Trump quasi spiegando la ragione della sua scelta. Ne ha poi apprezzato con una mimica inequivocabile la proposta ribadita di garantire la sicurezza dell’Ucraina, violata da Putin con la sua invasione chiamata eufemisticamente operazione speciale, attraverso un congegno politico e militare riconducibile al famoso articolo 5 del trattato dell’alleanza atlantica. Sì, proprio quella: la Nato, alla quale Putin è riuscito ad impedire l’adesione dell’Ucraina ma non potrà probabilmente impedire di garantirle la sicurezza nei confini e nelle dimensioni che usciranno dalle trattative per la pace.
La Meloni seduta e dialogante alla sinistra di Trump, col presidente ucraino Zelensky di fronte, il presidente francese Macron alla destra di quello americano e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a un’estremità del tavolo, quasi come in una curva allo stadio, è stato per me uno spettacolo eccezionale. Eppure, scusatemi della immodestia, ne ho visto di cose, e vissute di esperienze, in 65 anni di mestiere, cominciati con la cronaca nera e il giro degli ospedali, continuata con la cronaca bianca, quella del Campidoglio, e poi con la cronaca politica, la frequentazione di leader di ogni colore. E con avventure professionali come la partecipazione alla fondazione del Giornale di Indro Montanelli, la direzione del primo telegiornale privato, che fu quello di Rete 4 chiamato Dentro la notizia traducendo in italiano una trasmissione americana di notizie di cui si era innamorato Silvio Berlusconi seguendola da spettatore in un soggiorno di studio oltre Oceano, e di un giornale pubblico come era ancora in quei tempi Il Giorno, voluto dal mitico Enrico Mattei.
Ne ho viste, sentite e vissute -ripeto- di tutti i colori e di tutti i suoni. Ho visto la Dc di Amintore Fanfani perdere il referendum sul divorzio e imboccare, con quella sconfitta, la strada di un declino solo rallentato dall’aiuto fornitole da Montanelli invitando a votarla “col naso turato”. Ho visto catapultato, o quasi, uno storico e giornalista, Giovanni Spadolini, dalla direzione del Corriere della Sera sottrattagli sorprendentemente dall’editrice Giulia Maria Crespialla prima guida non democristiana del governo nella storia della Repubblica. Ho visto succedergli alla guida del governo il primo socialista, sempre nella storia della Repubblica, Bettino Craxi con un altro socialista quasi regnante al Quirinale, Sandro Pertini. Una combinazione che la Dc visse come una maledizione non accorgendosi che serviva, anch’essa come il voto a naso turato di Montanelli, ad allontanarne la fine, sopraggiunta con Tangentopoli, annessi e connessi.
Ho visto crollare il comunismo col muro di Berlino e i comunisti italiani cercare di salvarsi cambiando nome e simbolo al loro partito. E scoprendosi battuti nelle elezioni politiche del 1994 da Silvio Berlusconi, il migliore amico di quel Craxi di cui erano riusciti a liberarsi con l’aiuto della magistratura.
Potrei ancora continuare ed esaurire lo spazio senza arrivare alla conclusione. Che è di non avere mai immaginato di vedere quella Meloni dell’altra sera (ora italiana) alla Casa Bianca, con tutto ciò che la sua postazione e il suo intervento hanno significato e significano. Anche in Italia, dove vale, per le opposizioni sempre rosicanti la massima ricavata dal latino su Dio che accieca chi vuole perdere. “Quem Juppiter vult perdere dementat prius”, in originale.
Pubblicato su Libero