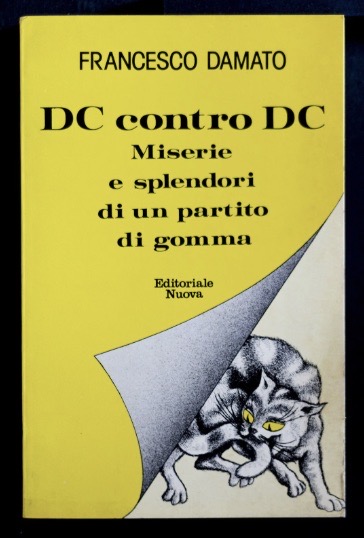E’ più, molto di più di una foto di opportunità quella dell’udienza concessa in Vaticano dal Papa a Matteo Salvini, accompagnato dalla figlia Mirta, dal tesoriere della sua Lega Alberto Di Rubbia, e dal capo del suo ufficio di segreteria Daniele Bertana. Mancava solo il suo amico Stefano Beltrame, proprio in quelle ore -o quasi- nominato dal governo ambasciatore d’Italia a Mosca, dopo esserlo stato a Vienna e assistito da diplomatico il ministro, sempre leghista, dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Un giornata insomma che non poteva essere migliore per il leader leghista, vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, reduce da passì, iniziative e altro che avevano messo in serie difficoltà la premier, rimasta in silenzio anche di fronte alle proteste ufficiali della Francia per attacchi rivolti dallo stesso Salvini al presidente Emmanuel Macron. Che non intendeva e non intende rimanere attaccato al tram, dove lo aveva sistemato a parole il leader leghista per la sua smania di mandare truppe in Ucraina e rendere più visibile, più concreta, più efficace la difesa europea del paese da più di tre anni sotto invasione e fuoco della Russia di Putin.
Già la decisione di Papa Leone XIV di riceverlo in Vaticano, sia pure dopo un’udienza ufficiale alla premier Giorgia Meloni e una privata al vice presidente forzista del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, è stata per Salvini gratificante, a dir poco, specie nel contesto già accennato della politica estera italiana. Che è di pertinenza della premier a Palazzo Chigi e di Tajani alla Farnesina, come rivendicato continuamente dallo stesso Tajani, ma di cui Salvini rivendica il diritto di occuparsi pure lui come leader di partito nella coalizione di maggioranza ed esponente del governo. Col quale non a caso il Papa si è soffermato a parlare anche, se non soprattutto di politica estera.
Per sottolineare, questa volta nel contesto non di questa stagione politica ma della storia quasi ottantennale della Repubblica, l’importanza della nomina di un diplomatico di simpatie leghiste, a dir poco, a Mosca in piena guerra con l’Ucraina è forse il caso di ricordare la caldissima estate del 1964. C’era la “guerra fredda” fra la perdurante Unione Sovietica e un Occidente ancora guidato saldamente dagli Stati Uniti. Non un leader qualsiasi della maggioranza di centro-sinistra, ancora col trattino, guidata da Aldo Moro, e appena ricompostasi a chiusura di una crisi nella quale si erano sentiti i famosi “rumori di sciabola” riferiti dal vice presidente socialista del Consiglio Pietro Nenni, ma il presidente della Repubblica Antonio Segni non riusciva a fare nominare il suo amico Federico Sensi ambasciatore a Mosca. Se ne lamentò col ministro degli Esteri Giuseppe Saragat. Che, presente un Moro particolarmente imbarazzato, gli ripose tanto male, anche per come aveva gestito la crisi appena conclusa, da procurargli un ictus da quale il capo dello Stato non si riprese più. E fini sostituito in meno di sei mesi dallo stesso Saragat.