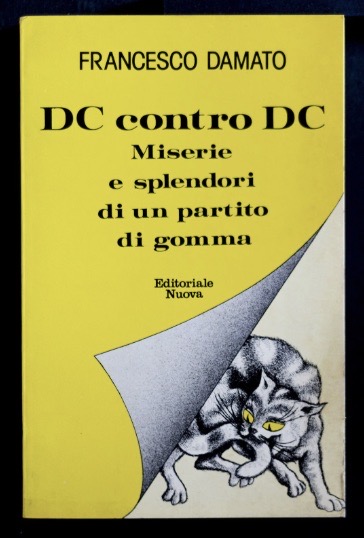Metti insieme tasselli come la giornata particolare di Matteo Salvini in Vaticano, preceduta da quella di Antonio Tajani, e prima ancora da quella di Giorgia Meloni, poi andata a fare i bagni a Rimini nelle acque di Comunione e Liberazione fra standing ovation di un pubblico prevalentemente giovanile, e uno come Marco Damilano, un giornalista di sinistra cresciuto in una famiglia democristiana di vecchio stampo, ne ricava un mosaico intitolato su Domani, il giornale col quale Carlo De Benedetti si consola della perdita di Repubblica, “clerico melonismo”.
Che nelle prime reazioni della cattolica “adulta” Rosy Bindi è stato sospettato di attingere cultura, rapporti e quant’altro nel sottosegretario di maggiore fiducia della premier che è Alfredo Mantovano, ma che Damilano ha attribuito al vecchio ma sempre operativo, fra interviste, incontri e telefonate, cardinale Marcello Ruini. L’unico -deve avere pensato il giornalista forse non sbagliando, chissà- che può avere immerso il biscotto della Meloni nella storia dell’Azione Cattolica e delle sue divisioni sulla cosiddetta “scelta religiosa”, che avrebbe troppo ristretto le visioni e le scelte dei fedeli impegnati in politica, destinandoli per esempio nel 1974 , dopo molti ma inutili tentativi di evitarla, all’avventura referendaria contro il divorzio. Perduta da un Fanfani saltato come un tappo dalla bottiglia di champagne della storica vignetta di Sergio Forattini su Paese sera. Bindi ancor più di Damilano, scrivendone in una lettera ad Avvenire seguita a un’intervista alla Stampa, ha sofferto il ricordo di quelle divisioni nel mondo cattolico -o “clericale” nel lessico di Domani– ed esortato la stessa Meloni e i suoi consiglieri, ispiratori e quant’altro, laici o religiosi che siano, graduati e non, a resistere alla tentazione di riproporle e praticarle.
Pensate un po’ di quanto sono capaci i moisaicisti -li chiamerei- del rosiconismo, terrorizzati dalla bravura della Meloni, e dei suoi alleati di governo, compreso il Salvini dei rosari e delle immaginette che tira fuori durante i comizi- nell’”occupare i vuoti”, come lo stesso Damilano ha scritto- creati in quello che una volta veniva chiamato e considerato l’elettorato cattolico. Ed ora è più semplicemente, ma più drammaticamente per la sinistra accasatasi nel Pd di Elly Schlein, l’elettorato nazionalpopolare, come l’allora presidente socialista della Rai Enrico Manca chiamava il pubblico del vitalissimo e già campione di ascolti Pippo Baudo.