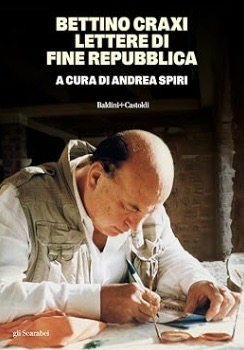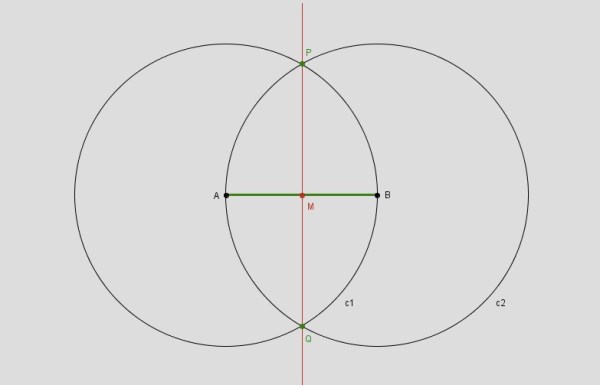Alla faccia dei “24 carati” di socialismo, o di sinistra, che Goffredo Bettini in un lungo intervento -quasi un saggio- avrebbe restituito a Bettino Craxi a 25 anni dalla morte scrivendone ieri sull’Unità ripensata e diretta dal generoso Piero Sansonetti. Che ha messo nel titolo i carati, appunto, che Bettini tuttavia non ha restituito.

Egli ha riconosciuto “sbagliato”, bontà sua, “ridurre” Craxi a “una sorta di spregiudicato capo politico, emerso in una congiuntura della storia di sinistra, un caso patologico”, ma ha ripiegato solo sulla formula di un Craxi che “fu un socialista e un democratico, naturalmente con le sue peculiari caratteristiche e idee”. Un “totus socialista” tradotto sempre generosamente dall’Unità” nel titolo interno, a pagina 10.
A Craxi 25 anni dopo la morte, preceduta peraltro dalla fine pure del Pci, Bettini ha continuato a rimproverare di non aver saputo “misurare e indagare con la necessaria serenità le peculiarità” del partito di Palmiro Togliatti e successori. E neppure le responsabilità che i socialisti avrebbero avuto nell’avvento del fascismo, addebitate loro da Bettini citando “un editorialista del Corriere della Sera”, scoperto leggendo Antonio Scurati, che il 23 novembre 1920 così aveva commentato i disordini sopraggiunti a elezioni amministrative: “Di chi è la colpa di questa situazione? Chi, se non il partito socialista, aspira alla guerra civile?”.

Spintosi molto più avanti nel tempo per arrivare al discorso pronunciato da Craxi alla Camera nel 1992, mentre maturava il suo coinvolgimento nella “tempesta giudiziaria” di Tangentopoli, Bettini ha contestato all’allora segretario del Psi di avere denunciato “fuori tempo massimo” il carattere diffuso del finanziamento della politica. Solo “per allontanare le accuse che in quel momento gli piovevano sulla testa”.
“Il Pds rispose in modo “povero” e opportunista. No, noi siamo i “buoni” e voi i “cativi”…intravedendo la possibilità di accelerare un ricambio politico”, ha annesso, riconosciuto e quant’altro Bettini. Che ha anche ricordato che al Pds “non andò bene” perché nel 1994, solo dopo due anni, “Berlusconi stravinse”.

Bettini ha anche provato a immaginare che cosa avrebbe dovuto dire, piuttosto, Achille Occhetto dopo quel discorso di Craxi alla Camera, pur rivendicando il merito della sua parte politica di non avere ceduto al “lusso” e alla “mondanità”: “Ma, sì, anche noi siano pienamente parte di un sistema a politico istituzionale arrivato alla frutta perché gestiamo insieme agli altri la sanità pubblica…perché il sindacato all’interno delle grandi aziende di Stato decide parte delle assunzioni….perchè il 30 per cento degli appalti nell’edilizia è destinato alle cooperative”. E ti pare poco, caro Bettini, pur vantando amicizia con Bobo Craxi, a un cui articolo sul padre è stato affiancato il tuo sull’Unità, che quel discorso o ragionamento fosse mancato? E con esso tutto il resto? Compreso il suicidio della sinistra.