
Diffido francamente di quella bomba di carta che mi sembra, francamente, il “duello sul Viminale” gridato da Repubblica enfatizzando, a dir poco, il rimpianto, le aspirazioni e quant’altro attribuiti a Matteo Salvini dopo l’assoluzione piena ottenuta nel processo di primo grado per gli sbarchi di migranti clandestini ritardati nel 2019 dall’allora ministro dell’Interno. Che perciò vorrebbe tornare ad esserlo se ne avesse la pur improbabile occasione.

Mi colpisce di più il pur meno vistoso annuncio sulla prima pagina del Corriere della Sera riguardante l’associazione nazionale dei magistrati. Il cui presidente Giuseppe Santalucia ha deciso di lasciare, di non riproporsi alla imminente scadenza del suo mandato quadriennale.
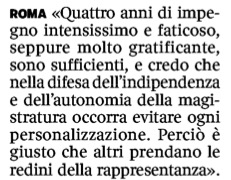
Nel proposito dichiarato di “evitare ogni personalizzazione”, Santalucia ha detto che “è giusto che altri prendano le redini della rappresentanza” delle toghe. Che tuttavia in un’assembla svoltasi di recente nel “Palazzaccio” romano della Corte di Cassazione ha inasprito l’agitazione contro la riforma della giustizia proposta dal governo al Parlamento, sino a mettere in cantiere anche il ricorso allo sciopero.
La rinuncia di Santalucia -eccellente un po’ come le assoluzioni che hanno sconfessato le accuse al già ricordato Salvini e all’altro Matteo della politica italiana, Renzi, per finanziamento illegale della sua corrente- sembra un po’ la rinuncia di un generale a guidare l’ultimo assalto delle sue truppe.

Una coincidenza ancora più clamorosa è tuttavia quella fra la rinuncia annunciata da Santalucia e un’intervista nella quale Luciano Violante, già magistrato, già responsabile dei problemi della giustizia del defunto Pci, già presidente della Camera, ha ricordato ai suoi ex colleghi che “non spetta alle toghe riformare la giustizia”, ma al Parlamento. “Parola di Violante”, ha titolato in prima pagina La Verità.

I magistrati sul piede di guerra “non possono essere controparte di nessuno, tanto meno del governo. Così come -ha aggiunto Violante- mi sembra un errore che siano loro a organizare l’eventuale referendum abrogativo”, anch’esso minacciato contro la riforma. “In questo modo -ha aggiunto Violante parlando sempre dell’associazione dei magistrati -diventa protagonista di un conflitto. I cittadini devono avere fiducia nei magistrati, che perciò non possono comportarsi da combattenti. Serve il senso della misura, per tutti”.

Dubito, personalmente, che questo “senso della misura” prevarrà. Come sospetto, probabilmente a torto, che ne dubiti pure il presidente uscente dell’associazione che ha deciso di lasciare. Ma il monito di Violante è l’ultimo passo compiuto dall’ex presidente della Camera sulla strada intrapresa da tempo per riequilibrare i rapporti fra la politica e la giustizia saltati a favore della seconda una trentina d’anni fa con mani presumibilmente “pulite”.











































