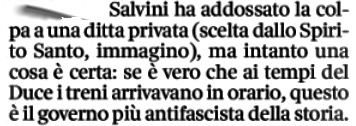Viktor Orban, il premier ungherese ospite d’onore di Matteo Salvini più di tutti gli altri a Pontida, deve avere una concezione particolare dell’amicizia. Come quella, del resto, dello stesso Salviniquando ha difeso l’”amico”, appunto, Antonio Tajani offeso a voce e per iscritto dai giovani leghisti. Che in fondo avevano preso sul serio quel “mangiare pesante”, e bere evidentemente troppo, rimproverato al collega e alleato di governo dallo stesso Salvini per avere espresso preoccupazioni dopo il successo elettorale conseguito in Austria da una destra orgogliosamente estremista, diciamo pure nazista.
Fra le righe della promozione di Salvini ad “eroe” per il processo procuratosi, o procuratogli soprattutto dagli ex alleati grillini, ritardando da ministro dell’Interno cinque anni fa lo sbarco ci circa 150 migranti dalla nave Open arms, il premier ungherese ha voluto dare una lezione di rigore, intransigenza e altro al governo italiano. Del quale il leder leghista fa parte ora come vice presidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, compresi i porti.

In Ungheria -si è vantato Orban- non entra un solo immigrato irregolare. In Italia, si sa, continuano ad entrarne, anche se più contenuti, come puntualizzano la premier Meloni e lo stesso Salvini. Ma l’Ungheria non ha i confini italiani. Li ha tutti terrestri, senza un solo metro, anzi centimetro marino, con tutte le complicazioni che derivano dalle acque. C’è da chiedersi se Orban, già impettito di suo ma ancora di più quando si mette a dare lezioni agli altri, sappia leggere le carte geografiche.
Capisco i doveri di ospitalità e annessi e connessi. Ma il leader leghista dovrebbe guardarsi da certi ospiti, appunto. E anche -visto che ci sono- da certi militanti della sua Lega rimasti fermi ai tempi in cui il Sud era considerato la Terronia da affidare alle energie dell’Etna e di tutti gli altri vulcani sparsi sul suo territorio, insulare e peninsulare.
Quella maglietta verde a Pontida inneggiante al Nord prima di tutto, ma ancor più all’Italia che “non è una e non lo sarà mai”, col suo tricolore che il giovane Umberto Bossi una volta invitò una signora di Venezia che lo sventolava dalla finestra a buttarlo “nel cesso”; quella maglietta verde a Pontida, dicevo, è stata un po’ come -fatte le debite proporzioni, naturalmente- la guerriglia a Roma sabato scorso nella manifestazione a favore dei palestinesi.
La 36.ma edizione del festoso raduno leghista rischia di essere ricordato più per quella maglietta che per altro, compresa la presenza “nera” -secondo il titolo di Repubblica- degli ospiti esibiti dal vice presidente del Consiglio. Una maglietta che -vedrete- sarà adoperata contro la Lega e il governo dai promotori del referendum contro le autonomie differenziate pur messe dalla sinistra nella Costituzione 23 anni fa con la riforma del titolo quinto, riguardante le Regioni, le Province e i Comuni.
Pubblicato sul Dubbio