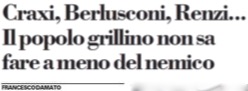A Palazzo Chigi se l’aspettavano. La decisione presa dalla giudice Silvia Albano, del tribunale di Roma, di trasferire in Italia i primi dodici migranti sbarcati in Albania per le operazioni preliminari alla definizione delle loro pratiche è esattamente quella che una settimana fa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, intervistato dal Foglio, aveva praticamente messo nel conto protestando contro la pretesa dei magistrati -peraltro suoi colleghi- di giudicare loro i paesi sicuri di provenienza o di rimpatrio dei migranti clandestini. Che il governo ritiene invece essere di sua esclusiva competenza per un decreto interministeriale adottato a suo tempo.
L’Egitto e il Bangladesh da cui provengono i dodici migranti trasportati nei centri allestiti dall’Italia in Albania non sono stati considerati sicuri, o del tutto sicuri, dalla giudice Albano. Che ha perciò disposto il trasferimento dei dodici in Italia non potendo essere respinti. E avendo diritto, proprio per la mancanza di sicurezza nei loro paesi, alla protezione internazionale negata invece dalle autorità amministrative italiane.

La premier Meloni, raggiunta dalla notizia fra il Libano e la Giordania, in una missione peraltro servita anche a supplire alla sgradevole esclusione da un vertice a quattro fra americani, francesi, tedeschi e inglesi sulla guerra in Ucraina, oltre a protestare contro la “decisione pregiudiziale” della giudice di Roma ha annunciato per lunedì una riunione del Consiglio dei Ministri. Dove intende rendere più stringente la competenza del governo nella valutazione della sicurezza dei paesi di provenienza dei migranti. Più stringente, in particolare, con una legge d’urgenza che, sostituendo il decreto interministeriale in vigore, renderebbe possibile ricorrere anche alla Corte Costituzionale, oltre che ai gradi superiori della magistratura ordinaria, giù prenotati dal ministro dell’Interno, contro le decisioni giudiziarie di prima istanza.
Al di là di questi aspetti giuridici della questione, si è aperto l’ennesimo scontro fra politica e magistratura. Anzi, fra governo e magistratura, potendo quest’ultima contare sistematicamente in questi casi sull’aiuto delle opposizioni di turno, accomunate dall’abitudine di usare la stampella giudiziaria nelle loro azioni politiche di contrasto. Lo dimostra il processo in corso a Palermo per il ritardato sbarco di 147 migranti nel 2019 disposto dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini.

A questo processo, dove sono stati chiesti dall’accusa sei anni di carcere per l’imputato, si è arrivati per l’autorizzazione concessa a suo tempo dal Senato col voto determinante dei grillini di sapore ritorsivo, dopo la crisi del primo governo di Giuseppe Conte. Che fu provocata nell’estate di quel 2019 da un Salvini eccitato, diciamo così, dal successo appena conseguito nelle elezioni europee. Che avevano portato d’un colpo la Lega dal 17 per cento delle elezioni politiche dell’anno precedente al 34.