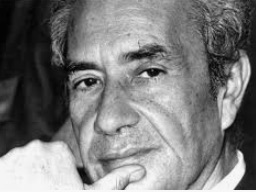Avevo 18 anni nel 1956, quando gli ungheresi si rivoltarono all’Unione Sovietica, nella cui sfera erano caduti con gli accordi Yalta. E persero la loro partita sotto gli occhi di un Occidente rassegnato. Mi sentii con tanti miei coetanei un ungherese, ben prima che un mitico presidente americano come Jhon Fitzgerald Kennedy ci facesse sentire orgogliosamente tutti berlinesi parlando davanti al muro che ancora divideva quella città e, più in generale, il mondo tra Ovest ed Est. Era il 26 giugno 1963. Dopo sei mesi egli sarebbe stato ucciso a Dallas, nel suo Paese

A 18 anni mi dividevo fra la lettura del Corriere della Sera e del settimanale longanesiano Il Borghese, che avevano praticamente in comune l’inviato in Ungheria Indro Montanelli. E non esitai a riconoscermi più in Longanesi che in Montanelli quando fra i due scoppiò una furiosa polemica sulla classificazione degli insorti a Budapest: se comunisti autentici e buoni contro quelli cattivi, come sosteneva Montanelli, o per niente comunisti contro il comunismo, come sosteneva Longanesi.

Chi l’avrebbe detto che nell’estate di 68 anni dopo avrei dovuto leggere le cronache politiche di una Ungheria che, a comunismo finito, crollato col muro di Berlino nel 1989, condotta da Viktor Urban, presidente di turno dell’Unione Europea, è nelle disgrazie dell’Occidente e nelle grazie di Mosca. Dove comanda dal Cremlino non Giuseppe Stalin, morto nel 1953, non Leonid Breznev, morto nel 1982 quando era già una mummia travestita da vivo, ma Vladymir Putin. Che, già comunista pure lui, cresciuto nei servizi segreti dell’Urss, è forse peggiore degli altri due per ottusità e caparbietà nella volontà di imporre non più un’ideologia, o soprattutto quella, ma solo la forza militare del suo paese, anzi del suo regime. Rosso di sangue e di vergogna dopo due anni e mezzo di guerra all’Ucraina bombardando anche un ospedale pediatrico. Che cosa -al di là dei suoi edifici non rasi al suolo o danneggiati dai sovietici nell’occupazione territoriale più stringente seguita alla rivolta- dell’Ungheria di quel lontano, lontanissimo 1956 è difficile dire. Rimangono solo i mei ricordi giovanili. E il desolante incedere nei vertici e incontri internazionali di un presidente ungherese che nel 1956 non era neppure ancora nato. Nacque sei anni dopo, nell’Ungheria ormai ben normalizzata nella logica di Mosca, ieri come a tratti sembra ancora oggi, a dispetto della Nato che, a 75 anni appena compiuti, annovera dal 1997 quel paese fra gli aderenti. Se tutto questo vi sembra normale…
Ripreso da http://www.startmag.it il 14 luglio