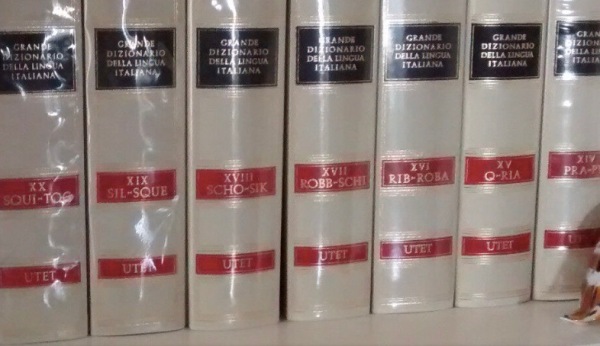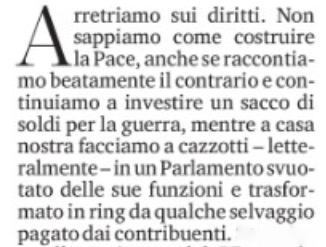Fa in fondo parte della quasi terza guerra mondiale a pillole, come dice il Papa, anche quella che la politica italiana sta conducendo contro il dizionario in una catena di ossimori.
Abbiamo una destra dichiaratamente conservatrice, anche nelle parti moderate e non “estreme” immaginate a Berlino dal caudicante cancelliere Sholz, che felicemente innova.

Al Senato si è appena consumato il primo dei quattro passaggi parlamentari della riforma della Costituzione che introduce l’elezione diretta del presidente del Consiglio. Come si eleggono da anni i sindaci dei Comuni e i presidenti delle Regioni senza che né gli uni né le altre siano uscite dalla democrazia.
Alla Camera è stata approvata definitivamente con legge ordinaria l’attuazione delle cosiddette autonomie differenziate regionali introdotte nel 2001 nella Costituzione dalla sinistra, che corteggiava la Lega di Umberto Bossi sul terreno del federalismo per cercare di impedirne il ritorno all’alleanza con Silvio Berlusconi. Dalla quale era riuscito a sfilarla alla fine del 1994 l’allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, per niente rassegnato alla calma dopo avere cercato inutilmente di trascinare nella lotta all’allora presidente del Consiglio il quasi vertice della Chiesa. Ne ha appena dato conferma, nel silenzio assordante e imbarazzante, oltre che imbarazzato, di ciò che ancora rimane -cioè parecchio- della sinistra di allora ammantatasi all’alba della seconda Repubblica nei panni dichiaratamente progressisti.
I progressisti, appunto, ai quali fu iscritto d’ufficio nel 2020 il grillino Giuseppe Conte diventandone addirittura il “punto più avanzato” per dichiarazioni e interviste intrecciatedel segretario del Pd Nicola Zingaretti e del suo “filosofo” di riferimento Goffredo Bettini; i progressisti, dicevo, vogliono adesso andare non avanti ma indietro rispetto alla riforma costituzionale del 2001. E, rovesciandosi addosso secchiate di liquame politico, dipingono la Repubblica delle regioni da loro stessi disegnata 23 anni fa come destinata alla disgregazione, affondata nel disordine e via infernando. Da Inferno, per quanto Papa Francesco ottimisticamente lo immagini da qualche tempo sgomberato.

Non è la prima volta, a dire la verità, che i progressisti italiani hanno il passo del gambero Già nella prima, ormai lontana prima Repubblica ghigliottinata dalla magistratura ribaltando i rapporti con la politica fissati dai costituenti, i progressisti alla Berlinguer, tanto celebrato in questi giorni, scambiarono la Costituzione per un fortino assediato da Bettino Craxi con i suoi progetti di riforma istituzionale. E pure Craxi entrò nel girone dei reazionari, come prima di lui un vecchio campione dell’antifascismo e dell’antifranchismo quale il repubblicano Randolfo Pacciardi. Che aveva osato raccogliere e rilanciare quelle tracce di presidenzialismo già affiorate nelle discussioni all’Assemblea Costituente. Il povero Pacciardi ne morì quasi di crepacuore, contestato per primo dal leader della sua parte o area politica Ugo La Malfa.
Neppure la Malfa -pace all’anima sua- scherzava nella guerra al dizionario. Anzi, al buon senso. Ricordo lo sgomento che mi procurò personalmente nel 1973, rimediando un mezzo insulto quando osai contestaglierlo in un corridoio della Camera.
Erano i mesi e i giorni in cui il governo della “centralità” Andreotti-Malagodi, come lo chiamava l’allora segretario della Dc Arnaldo Forlani avendolo fatto realizzare dopo l’uscita dei socialisti dal centrosinistra a causa dell’elezione di Giovanni Leone al Quirinale, veniva spinto verso la crisi da Amintore Fanfani nella Dc e da La Malfa, appunto, fuori dalla Dc.

Proprio La Malfa, precedendo formalmente Fanfani che stava scaricando il suo ex delfino Forlani dietro le quinte, notificò lo sfratto ad Andreotti rompendo la maggioranza sulla vertenza del cosiddetto codice postale. Che non era quello da voi giovani forse immaginato pensando ai numeri che precedono le città nella corrispondenza, ma quello allora in discussione anche per introdurre la televisione a colori. Alla quale La Malfa, sostenuto dal Pci, era contrario per ragioni di austerità, temendo gli sperperi che gli italiani avrebbero fatto cambiando i televisori. Sullo sfondo c’erano formalmente i contrasti sul sistema francese -Secam- o tedesco – Pal- da adottare sul piano tecnico. Diavolo di un progressista, La Malfa, col suo preferito bianco e nero neppure iuventino. La Malfa e i comunisti che gli andavano dietro pur di ottenere una crisi di governo.
Pubblicato su Libero
Ripreso da http://www.startmag.it il 23 giugno