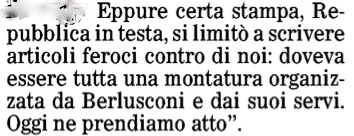Non più tardi dell’anno scorso, il 19 aprile parlando a Cracovia, il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella riandava con la memoria alla domanda che nel 1939 percorreva l’Europa, a cominciare dalla Francia, se valesse la pena “morire per Danzica”. E al “seguito di quelle incertezze”, cioè all’attacco navale tedesco a Danzica all’alba del 1° settembre e alla conseguente seconda guerra mondiale messa mostruosamente nel conto da Hitler d’intesa con la Russia sovietica di Stalin. Che ne sarebbe stata poi investita cambiando fronte.

Il presidente francese Emmanuel Macron, che pure due anni fa era tra quelli che non volevano umiliare la Russia non più sovietica di Putin ma ugualmente cinica, non si è chiesto in questi giorni se valga la pena morire per l’Ucraina invasa e bombardata anche con armi chimiche, ma è andato ancora più in là. Ha manifestato come meglio o più forte non poteva, non bastandogli evidentemente “i piani Nato” in cantiere secondo Repubblica, la tentazione di mandare truppe francesi in Ucraina per impedirne, o cercare di impedirne il crollo. E ha sorpreso il governo italiano più ancora di Putin. Col quale, o con la Russia del quale, il nostro Paese “non è in guerra”, ha ricordato il titolatissimo ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio Antonio Tajani. Che potrebbe trovarsi fra qualche settimana candidato inconsapevole, come il Cristoforo Colombo scopritore dell’America, al vertice dell’Unione Europea, battendo paradossalmente il candidato italiano di Macron: volente o volente, l’ex premier Mario Draghi.

Neppure l’imponente ministro della Difesa Guido Crosetto si sente in guerra con Putin e la sua Russia, pur non dimenticando -ha detto in una intervista al Corriere della Sera- che “ogni giorno vengono sganciati diecimila, ripeto diecimila, granate di artiglieria su obiettivi civili, su persone, su infrastrutture” di un paese che siamo impegnati da più di due anni ad aiutare anche militarmente, cioè a difendere. E nella difesa è obiettivamente difficile, diciamo pure impossibile, se non a costo di mentire o tradire, separarsi dalla guerra in certe condizioni. Che sono poi quelle in cui si trova l’Ucraina ancora non “denazificata” come nei propositi dichiarati urbi ed orbi da Putin, con la benedizione del Patriarca di Mosca, in apertura della sua originaria “operazione speciale” di polizia.

“Se già in tanti non vogliono “morire per l’Ucraina” -ha scritto ieri il direttore Alessandro Sallusti sul Giornale, come nel 1939, aggiungo io, non volevano morire per Danzica- figuriamoci quanti sarebbero disposti a tirare le cuoia per la Francia di Macron”. Già, perché -è convinto Sallusti, forse anche come Tajani, Crosetto ed altri che non hanno avuto la franchezza di dirlo- Macron si sarebbe inoltrato di più sul terreno della guerra per motivi di bassa, bassissima, fognaria politica interna: per mettere in difficoltà la destra francese in crescita nei sondaggi elettorali per il voto europeo del 9 giugno.