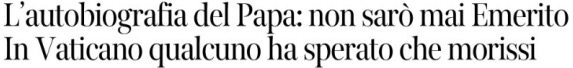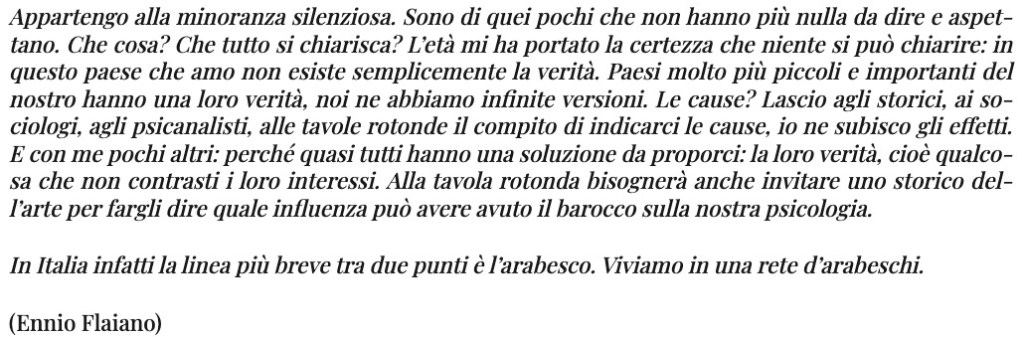Sono trascorsi 46 anni, quasi mezzo secolo a pensarci bene, dal 16 marzo 1978. Quando il presidente della Dc Aldo Moro, del quale sembrava che mancassero ormai solo nove mesi all’elezione alla Presidenza della Repubblica per sostituire il collega di partito Giovanni Leone ormai in scadenza di mandato, fu rapito dai brigatisti rossi in via Fani, a Roma, a poca distanza da casa. Fu sequestrato fra il sangue della scorta decimata in quella che qualcuno degli stessi terroristi definì poi “una mattanza”, riconoscendo in fondo che si era forse fatto più fuoco e sangue del necessario considerando l’obiettivo da raggiungere. Che era quello di rapire uno dei politici più autorevoli del Paese -se non il più decisivo- ma anche dei meno protetti, o decisamente il meno protetto di tutti: tanto da essere stato lui scelto al posto di altri dei quali erano state esaminate scorte, abitudini, percorsi. Erano stati, in particolare, vagliati i presidenti del Senato Amintore Fanfani e del Consiglio Giulio Andreotti.

Moro, 62 anni ancora da compiere in settembre, già cinque volte presidente del Consiglio, una sola volta ma a lungo -per le abitudini di quel tempo- segretario della Dc, dal 1959 al 1963, autore della prima coalizione “organica”, cioè completa di centrosinistra, comprensiva di democristiani, socialisti, socialdemocratici e repubblicani dopo l’esperienza centrista con i liberali; Moro, dicevo, uscì quella mattina da casa dopo avere abbracciato il nipotino Lucaper andare alla Camera. Dove si presentava il secondo governo monocolore democristiano di Giulio Andreotti, sostenuto con la formula della “solidarietà nazionale” anche, o soprattutto, dai comunisti. Ai quali proprio Moro strappando un po’ col suo partito- diviso fra chi voleva andare alle elezioni politiche e chi voleva accontentare le aspirazioni ministeriali dei comunisti di Enrico Berlinguer concedendo due dicasteri a esponenti eletti come indipendenti nelle liste del Pci- aveva strappato la concessione di passare dall’astensione sul precedente governo al voto di fiducia in cambio di un programma concordato ancor più dell’altro.
Moro aveva inoltre impedito nelle ultime battute della crisi anche la concessione ai comunisti di due teste democristiane di governo reclamate perché troppo ostili al Pci: Antonio Bisaglia e Carlo Donat-Cattin, in ordine rigorosamente alfabetico. In realtà, il secondo era molto più importante del primo perché leader della sinistra sociale, cioè sindacale, della Dc.
La conferma di entrambi nella lista del governo diffuso la sera prima a tarda ora, quando giù il giornale ufficiale del Pci era stato stampato con le prime copie senza quei due ministri, aveva talmente sorpreso, anzi irritato il segretario comunista in persona da aver fatto sapere ad Andreotti che la discussione sulla fiducia non potesse essere considerata scontata col voto favorevole. Si potevano prevedere anche una conferma dell’astensione o, peggio, una rottura.

Con quella minaccia sulla testa della maggioranza e coll’amico segretario del suo stesso partito Benigno Zaccagnini tentato dalle dimissioni per dimostrare al Pci la sua buona fede nella promessa fatta di un cambiamento dei ministri particolarmente sgraditi alla sinistra comunista, Moro pensava quella mattina ad un’altra giornata delle sue, faticosa d’incontri, consigli, contenimento dei contrasti, promesse di nuove soluzioni, magari nella prospettiva del Quirinale. Dove alla fine dell’anno gli sarebbe stato più facile guidare il percorso di quella stagione politica, accelerando ma anche ritardando ulteriormente il disegno del governo col Pci che gli veniva attribuito, a torto a ragione, in Italia e all’estero, specie al Dipartimento di Stato americano. Dove l’uomo, nonostante i rapporti sostanzialmente fiduciosi dell’ambasciatore degli Stati Uniti da Roma, veniva più temuto che amato. Egli ebbe una volta uno scontro così duro in privato con Kissinger da aver pensato ad un ritiro dalla politica attiva, per ammissione o racconto di uno dei suoi stretti collaboratori: il portavoce Corrado Guerzoni.

Ma quella mattina Moro uscì da casa inconsapevolmente solo per andare incontro alla morte, arrivata per lui 55 giorni dopo, a conclusione di una prigionia penosissima, per la sua scorta immediatamente. E non dico meritoriamente, con grave e spietata durezza, solo per pietà verso le vittime e per i rapporti di simpatia che avevo col caposcorta maresciallo Oreste Leonardi. Essi pagarono duramente non uno ma più errori commessi in una protezione, a mio modestissimo avviso, troppo familiare, troppo abituale, troppo scontata dell’uomo affidato alle loro menti e alle loro armi, compresi i mitra che solevano portarsi appresso più nel bagagliaio che nell’abitacolo dell’auto.

Eppure il povero Leonardi aveva avvertito da tempo segni anomali attorno all’abitazione, all’ufficio e agli altri posti che il presidente della Dc usava frequentare, comprese le due chiese vicino casa: la più vicina in via Trionfale e la più distante in Piazza dei Giochi Delfici. Il caposcorta aveva chiesto che fosse messa a disposizione del suo protetto un’auto ugualmente blindata ma più leggera e veloce. Lo aveva chiesto personalmente al ministro dell’Interno Francesco Cossiga, che me lo raccontò dicendo di essersi proposto di provvedere al più presto. Ma non abbastanza per prevenire i fatti, ammesso e non concesso che un’auto più veloce avrebbe potuto supplire ad altri inconvenienti.

Il primo di quegli inconvenienti era l’abitudine della scorta di infilarsi in un budello come via Fani per risparmiare qualche minuto e centinaia di metri aggirando il più frequentato e lento piazzale Igea. Anch’io facevo quella scorciatoia per accompagnare mia figlia in auto a scuola, proseguendo poi per la redazione romana del Giornale dove lavoravo. E quella mattina me la trovai preclusa da due uomini in divisa che avevano messo le loro moto di traverso per dirottare il traffico. Erano guardie finte, Proprio in quei momenti si stava consumando la tragedia dell’assalto e del sequestro, col marciapiede finale della strada sgombero di una rivendita di fiori, avendo i terroristi provveduto a tagliare di notte le gomme del furgoncino del proprietario per impedirgli l’ingombro che sarebbe costituito per loro la sua attività quella mattina.

A strage avvenuta si fantasticò di “geometrica potenza di fuoco” e d’altro dei terroristi. Ma quale geometrica potenza di fuoco, L’agguato in quella strada, in quelle condizioni, era di una fin troppo banale progettazione ed esecuzione, Vi fu solo, come ho già ricordato con la “mattanza” di fonte terroristica, solo speco di fuoco e di sangue. E di errori anche degli inquirenti, che cominciarono col perdersi nei loro uffici le foto scattate dal compagno carrozziere di una mia amica giornalista. Cristina Rossi, che abitavano in un attico affacciato sul posto della strage. Quelle foto scomparse la dicono lunga anche su tanti altri misteri evocati su via Fani: dalle auto e degli uomini dei servizi segreti segnalati sul posto ai locali del bar e ristorante che vi affacciavano in cui la lingua tedesca fu sentita mescolarsi troppo a quella italiana.
Pubblicato su Libero