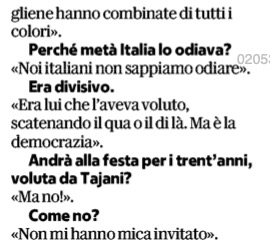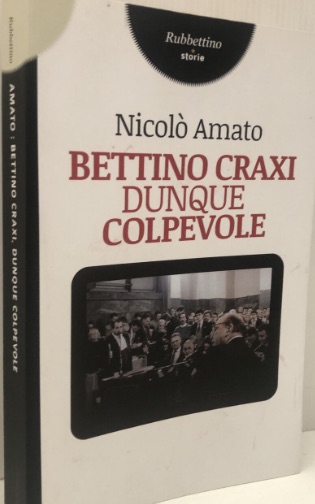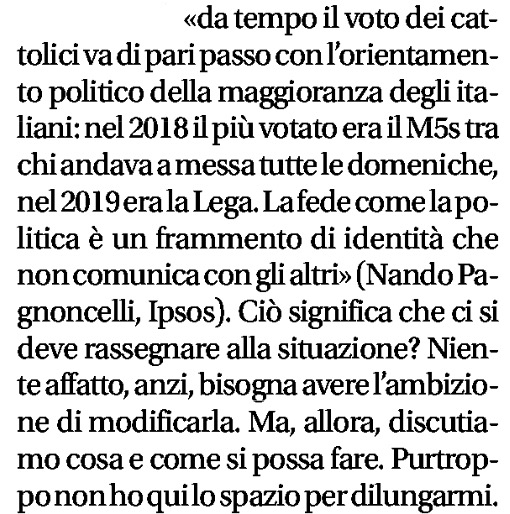Uno dà soltanto un’occhiata alla prima pagina del Corriere della Sera e si illude o teme, secondo le preferenze politiche, che all’improvviso la maggioranza sia arrivata al capolinea sulla guerra in Ucraina e sia risorto in Italia il bicameralismo dalle ceneri cui era stato ridotto anche dall’ultima legge di bilancio, approvata dal Senato e ratificata a Montecitorio in poche ore con una blindatura di voti di fiducia.

“Quell’attrazione irresistibile tra Salvini e Conte”, racconta appunto il Corriere riferendo delle “mosse degli ex alleati” sempre più stanchi o contrari, rispettivamente, agli aiuti all’Ucraina e smaniosi di contribuire ad uscirne per via diplomatica con un ordine del giorno competitivo, diciamo così. con gli appelli e persino le iniziative del Papa e del suo Nunzio speciale.

Che sorpasso di Conte sulla Schlein al Senato, veniva da dire, nello stesso giorno in cui alla Camera il primo era stato costretto ad unirsi alla seconda applaudendo uno scontro con la Meloni sulla sanità. Uno scontro da quale la premier era fisicamente uscita schiacciata sullo schienale della sua postazione di governo con gli occhi sbarrati verso il soffitto e l’ìepiteto di “regina dell’austerità” affibbiatale dalla segretaria del Pd. Un anticipo poco promettente, peraltro, del famoso duello televisivo diretto fra la leader effettiva della maggioranza e quella potenziale o aspirante delle opposizioni.


Poi si va a leggere bene il racconto della seduta al Senato e si scopre che tanto Salvini e Conte non ci sono entrati fisicamente. Si sarebbero mossi dietro le quinte dei loro capigruppo: l’uno, il leghista Massimiliano Romeo, autore del già ricordato ordine del giorno guadagnatosi subito la disponibilità dell’altro, il grillino Stefano Patuanelli, a votarlo per contraddire il rinnovo degli aiuti all’Ucraina approvato dalla maggioranza. Si scopre inoltre che il capogruppo leghista aveva tenuto a sottolineare il carattere pur paradossalmente “personale” del suo documento, prontamente modificato su richiesta del governo per togliere tutto ciiò che lo rendeva votabile dai grillini e infine appovato dalla maggioranza con gli stessi numeri -ma proprio gli stessi- raccolti il giorno prima dalla tanto contestata legge sulle autonomie differenziate, o “spacca Italia” nella rappresentazione opppsitoria.


“Conte e Salvini -ha raccontato il retroscenista principe del Coriere, Francesco Verderami- in via ufficiale si fanno notare poco o niente insieme, come si conviene per certe liaisons dangereuses. Ma in via delle elezioni europee usciranno ancora allo scoperto”, cioè al semiscoperto, “e fino a giungo andrà così, avvisa un cultore di manovra politiche come Franceschini. La campagna elettorale elettorale sarà lui e lui contro le altre”. Cioè i fantasmi contro le persone reali. Più che una campagna elettorale, una seduta spiritica. La Meloni si può pure ricompore e distogliere gli occhi dal lucernaio della Camera.
Ripreso da http://www.policymakermag.it