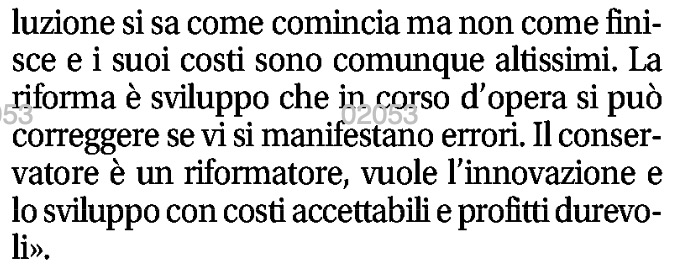Sono sempre a senso unico le strade della strumentalizzazione: anche quella delle prime pagine dei giornali piene oggi di titoli indignati contro “il saluto romano” lamentato dal Corriere della Sera e l’”adunata nera” denunciata da Repubblica per quelle centinaia o migliaia di braccia levate davanti a quella che fu la sezione romana missina di via Acca Larenzia. Dove da più di 40 anni si ricorda una strage successiva con tre giovani vittime successiva a quell’altra odiosa del 1973 a Primavalle.


Un po’ di onestà d’informazione e d’immagine dovrebbe fare accompagnare le foto delle tante braccia alzate con quelle del 7 gennaio 1978, con o senza i cadaveri. Basterebbero quelle senza. O la riproduzione di qualcuna delle tante scritte di poco glorioso antifascismo a scoppio ritardato -visti gli anni trascorsi dalla fine della dittatura- con le quali si invocavano sui muri di diverse città italiane, senza che nessuno si scandalizzasse più di tanto, “10, 100, 1000 Acca Larentia”.


Senza volere sposare la riduttiva vignetta del Foglio su quelle braccia e mani levate per reclamare “come un sol uomo” in un’aula scolastica o simile il bisogno di “andà in bagno”, ma neppure ridurre tutto all’ennesima “trappola identitaria” -ha titolato il Corriere– in cui sarebbe caduta col suo silenzio anche la premier Giorgia Meloni, penso che si debba finirla con questa pagliacciata di reclamare da lei un giorno sì e l’altro pure dimostrazioni della rottura con un passato che anagraficamente non le può appartenere. La Meloni non deve farsi perdonare come il Fini pur tanto apprezzato a suo tempo per la rottura con Silvio Berlusconi quel Mussolini ancora scambiato nel 1994, dopo lo sdoganamento della destra da parte dello stesso Berlusconi, come “il più grande statista” del secolo allora non ancora concluso.

Via, sarebbe ora anche per noi giornalisti, oltre che per i politici dalla coerenza a corrente alternata, di uscire dall’asilo Mariuccia e di affrontare con maggiore serietà problemi vecchi e nuovi dell’Italia. Persino Marco Travaglio sul suo Fatto Quotidiano è riuscito a contenere la sua polemica per il silenzio rimproverato alla Meloni scrivendo sopra la testata, senza dileggiare la leader della destra conservatrice di questo secolo col solito fotomontaggio in orbace o simili, che la premier dovrebbe dissociarsi da quelle braccia alzate “non perché sia fascista ma perché è la premier di uno Stato antifascista”. La cui Costituzione non sarà dichiaratamente antifascista, come ha recentemente sostenuto il presidente del Senato Ignazio La Russa, ma fu fatta da antifascisti. E, pur pur con una norma compresa fra “le disposizioni transitorie e finali”, dispone il divieto della “riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”.
Come ho già scritto qui e altrove, a me sembra che la premier sia tornata alle “dimensioni”, e altro ancora, più democristiane che del fascismo degli anni del “consenso” storicizzato da Renzo De Felice.
Ripreso da http://www.startmag.it e http://www.policymakermag.it