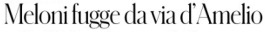Anche se nata e cresciuta mediaticamente per la volontà mostrata nel 2013, cioè dieci anni fa, di volerne vendicare la mancata elezione al Quirinale, trafitto da almeno 105 franchi tiratori del Pd, la segretaria Elly Schlein non è riuscita a restare a Cesena, invitata dalla minoranza del partito raccoltasi attorno al presidente Stefano Bonaccini, per ascoltare anche il discorso più annunciato e più atteso: quello di Romano Prodi. L’ha apprezzato solo a distanza, non so francamente con quanta convinzione, ispirando forse la vignetta di Emilio Giannelli che oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera propone la Schlein timorosa che “la corrente Bonaccini” finisca per investirla come “un tornado”.
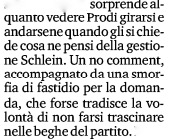

Prodi nel suo intervento, affaticato dal caldo e dal dolore della recente perdita della moglie Flavia, si è limitato a chiedere alla Schlein l’ossimoro di un “radicalismo dolce”. E in politica estera ne ha addirittura condiviso la sofferenza, chiamiamola così, per i perduranti aiuti militari all’Ucraina aggredita dalla Russia di Putin dicendo che “ci comportiamo da vassalli con gli Stati Uniti”, mancando di una “capacità propositiva”, al pari del resto di una “Unione Europea sbandata”. Che tale evidentemente non era quando a guidarla era praticamente lui a Bruxelles come presidente della Commissione esecutiva, dal 1999 al 2004. Eppure al termine del raduno cesenatico egli è apparso “sorprendente” a Carlo Bertini, della Stampa, per il rifiuto di rispondere ai giornalisti che gli chiedevano un giudizio sulla “gestione Schlein”. “Un no comment accompagnato da una smorfia di fastidio per la domanda”, ha scritto Bertini attribuendo al professore forse troppo generosamente solo “la volontà di non farsi trascinare nelle beghe del partito”. Come se la decisione di correre a Cesena non avesse avuto alcun significato politico nelle condizioni in cui si trova il Pd dopo la vittoria congressuale della Schlein, gli abbandoni di esponenti di provenienza sia democristiana sia comunista e le sconfitte elettorali già accumulate, e ricordate da Bonaccini.

Naturalmente è del tutto comprensibile, specie dopo il lutto familiare -ripeto- che lo ha anche fisicamente segnato, l’accoglienza da padre nobile del partito e da “ultimo vincitore” elettorale riservatagli a Cesena dai convenuti e da molti giornali. Comprensibile, ripeto, ma non per questo del tutto condivisibile. In primo luogo perché la nascita del Pd avvenne anche nel tentativo di interrompere l’esperienza di vaste coalizioni di cosiddetto centrosinistra, uliviste o d’altra denominazione, volute da Prodi e tutte condizionate dagli umori delle componenti più estreme. In secondo luogo perché, proprio a causa di quella condizione, Prodi dopo le due vittorie conseguite su Silvio Berlusconi, nel 1996 e nel 2006, non riuscì a restare più di due anni scarsi a Palazzo Chigi per governare su designazione degli elettori: la seconda volta trascinandosi appresso nella caduta anche le Camere, sciolte anticipatamente.
Ripreso da http://www.startmag.it e http://www.policymakermag.it