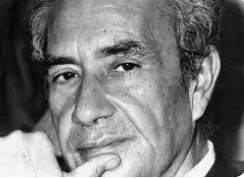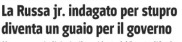

Pur col governo “inguaiato” -come titola un quotidiano non certo ostile come Il Giornale”- dalla vicenda del presidente del Senato Ignazio La Russa sceso in campo per difendere il figlio accusato di uno stupro, peraltro avvenuto a casa sua, la premier Giorgia Meloni non demorde dall’offensiva contro le toghe da lei sospettate di fiancheggiare le opposizioni nella lunga campagna elettorale per il Parlamento europeo da rinnovare fra quasi un anno.
In prima batttuta, di fronte alla imputazione “coatta” a Roma del sottosegretario alla Giustizia e collega di partito Andrea Delmastro per abuso d’ufficio sovrappostasi alle indagini milanesi sulla ministra del Turismo Daniela Santanchè, anche lei amica e collega di partito, la presidente del Consiglio se l’è presa con “una frangia della magistratura” politicizzata. Ieri quella frangia è diventata “un potere costituito”.

Dal Giappone, dov’è in missione internazionale, il guardasigilli Carlo Nordio ha spalleggiato la premier. Prima egli ha definito “irragionevole” l’imputazione coatta del suo sottosegretario, avendo già sostenuto che non c’era segreto d’ufficio nella vicenda Cospito costata l’incriminazione a Delmastro. E poi ha annunciato il proposito di riformare sia l’istituto dell’imputazione coatta, disposta dal giudice per le indagini preliminari contro l’archiviazione proposta dalla pubblica accusa, sia l’avviso di garanzia praticamente notificato alla Santanchè a mezzo stampa, come quello al compianto Silvio Berlusconi nell’autunno del 1994. Che contribuì a indebolirlo mentre Umberto Bossi già preparava la crisi del suo primo governo sulle pensioni.
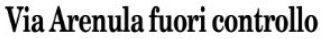

Va detto tuttavia che anche un giornale garantista come Il Foglio ha avuto da ridire, o da riscrivere, sugli assist di Nordio alla premier con un titolo di prima pagina su “Via Arenula fuori controllo”. Non è certamente la vignetta di Altan su Repubblica contro la Meloni decisa a spedire “le toghe rosse nelle fosse”, ma il segnale è ugualmente negativo per la guerra all’arma bianca che va ormai profilandosi tra governo e magistratura.
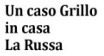
Sulla complicazione, sempre per il governo, costituita dal già accennato caso La Russa -sia figlio che padre- che ha inondato di titoli, foto e vignette le prime pagine di quasi tutti i giornali, lasciatemi esprimere quanto meno il disagio che mi procura vedere il presidente del Senato pizzicato dal giornale elettronico La Notizia con questo titolo: “Un caso Grillo in casa La Russa”. Un caso, quello del figlio di Grillo imputato con amici dopo una notte tempestosa di sesso in Sardegna nel 2019 e del padre insorto contro gli inquirenti, ancora aperto. Salvo prescrizione magari favorita, volente o nolente, dal rischio di un processo praticamente azzerato o azzerabile per la sostituzione di un giudice trasferito in altra sede.
Ripreso da http://www.policymakermag.it e http://www.startmag.it